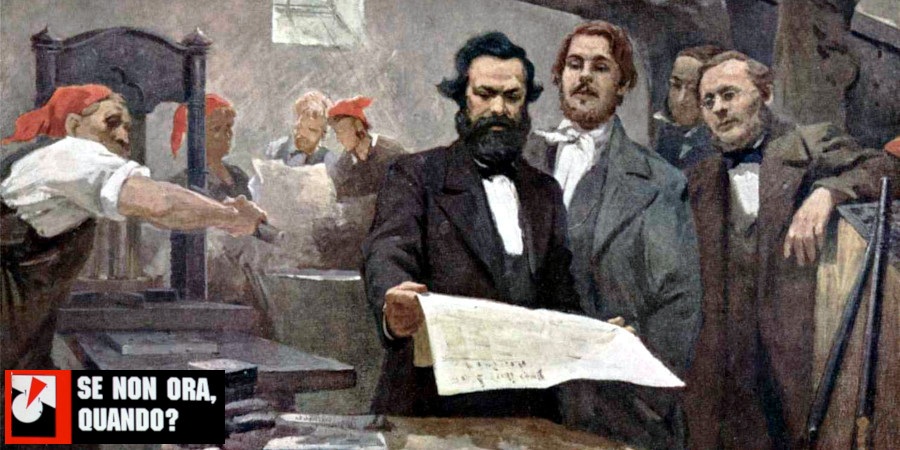dal Documento Politico per l’Assemblea nazionale della Rete dei Comunisti, Roma, 23 marzo 2002
1. DAL WELFARE AL WARFARE. PASSANDO PER GLI “ANIMAL SPIRITS”
L’ 11 Settembre non è cominciata la crisi economica, questo ormai lo dicono tutti, ma questa mordeva già da tempo; il crollo delle borse ed il blocco degli investimenti era cominciato già dal 2000 accentuando le caratteristiche finanziarie e speculative dell’economia. La riduzione dei consumi e la competizione commerciale tra aree economiche hanno peggiorato la situazione e se ne sono visti i risultati nel fallimento del WTO a Seattle nel 1999.
In questi mesi sono giunti anche altri segnali significativi, anche se forse sotto valuta ti, come il fallimento delle aziende elettriche private della California, la crisi della sanità ed il fallimento delle ferrovie inglesi fino all’ultimo clamoroso esempio del fallimento della ENRON e un’altra serie di “sintomi” che hanno rivelato le difficoltà del neoliberismo sfrenato che, partendo da Reagan e la Thatcher, in realtà ha tenuto per appena 20 anni.
Le varie crisi finanziarie iniziate nel 1997, di cui l’ Argentina è solo un ultimo esempio, e soprattutto la crisi del Giappone, che ormai da circa un decennio non riesce a risollevarsi dalla stagnazione/recessione, sono i segnali che nel mondo il vento è veramente cambiato.
È bastato un decennio in cui il capitalismo è rimasto senza “briglie” per far riemergere i limiti di un modo di produzione al quale la storia ha concesso, bontà sua, una “prova di appello”.
Il Giappone in crisi da un decennio, gli USA in fase recessiva e l’Europa con una asfittica crescita, sono i giganti che non riescono a rompere la gabbia del mancato sviluppo. E c’è solo la Cina che con il suo ingresso nel WTO può dare una speranza di crescita conomica quantitativa.
Dentro questo contesto si inserisce l’attacco alle “Torri Gemelle” e si crea, così, un’opportunità di ripresa economica e dell’egemonia imperialista americana nel mondo, in un mondo in cui invece i soggetti “geopolitici” vanno moltiplicandosi, determinando il nuovo ciclo di guerre imperialiste.
Non a caso la guerra contro il terrorismo viene chiamata “infinita”, proprio perché di fronte alla crisi della crescita economica “pacifica” la via di uscita praticabile è quella di una economia che trova nella guerra il suo volano via via sempre più fondamentale; confermando così che la guerra è una realtà “normale”, quindi permanente, dell’imperialismo.
Sulle motivazioni strutturali e sulle sue dinamiche economiche e storiche abbiamo pubblicato nel mese di Novembre 2001 il quaderno di Contropiano “La belle epoque è finita” che si è avvalso di validi contributi analitici e teorici e che esprime, nelle sue linee generali, il nostro punto di vista su questa nuova fase che si apre; una nuova fase dell’imperialismo, e quindi sempre e comunque prosecuzione della spartizione di zone di influenza, della politica dei monopoli, delle concentrazioni, del ruolo dell’economia finanziaria, del ruolo dello Stato, nelle diverse forme che via via si danno e sempre con mezzi adeguati alla situazione.
Siamo perciò di fronte ad un passaggio che nasce dal ventennio neoliberista e che ripropone l’assenza di prospettiva di crescita della società capitalista. Dal Welfare al Warfare; dunque di nuovo lo Stato che interviene nell’economia di fronte al blocco del mercato ma che non può più avere a disposizione gli spazi di sviluppo e di mediazione del conflitto sociale degli anni ’50 e ’60, e in maniera diversa degli anni ’70, storicamente ormai superati in modo irreversibile.
La produzione di armi, e sempre più frequentemente il loro uso, è un forte incentivo per far funzionare l’economia. Forse è per questo che dalla guerra contro l’Iraq del ’91 c’è stata una crescita esponenziale dei conflitti che hanno visto crescere la politica imperialista degli USA ma anche quella dei nuovi, seppur ancora inadeguati, competitori europei.
Il nuovo protagonismo dello Stato nell’economia capitalista, basata sulla produzione bellica, ha una serie di implicazioni che dovranno essere tenute presenti soprattutto rispetto alle caratteristiche delle politiche interne ai paesi sviluppati, dunque, anche all’Italia.
Guerra come realtà permanente dell’imperialismo e quindi anche come prospettiva. Ma se ciò è vero vuol dire che anche questa volta la guerra non costituisce un “problema” per gli imperialisti ma solo per i lavoratori che si domandano quale può essere il futuro di una società che ha tali basi. Quale civiltà si continua a proporre all’umanità tutta e non solo agli abitanti delle aree sviluppate?
2. UNA EGEMONIA IN CRISI?
La guerra come risoluzione delle contraddizioni del capitalismo nel suo sviluppo imperialistico può essere nascosta per un periodo più o meno lungo attraverso una forte ed incontrastata, oggi, capacità di manipolazione ideologica tra le popolazioni (sicuramente tra quelle dei paesi sviluppati, molto di meno le altre che ne pagano direttamente le conseguenze).
Sintomatica, in questo senso, è la martellante campagna nazionalista degli USA che richiama talvolta accenti nazisti degli anni ’30 (God Bless America e Gott Mit Uns), ma significativi sono anche i ritrovati accenti militaristi della più “pacifica” Europa che, per costruire le sue agibilità militari, invia i propri soldati, per ora, in alleanza con gli Stati Uniti, forse, poi, farà da sola.
La pericolosità di un tale sviluppo è evidente a tutti, soprattutto a chi lo sostiene, ed entra in contraddizione con aspirazioni umane generali ma anche con la “pacifica” vita interna dei paesi capitalisti sviluppati.
Il rischio è dunque evidente, ma forse meno evidente e più importante è il significato profondo che ha effettivamente questo salto di qualità. Si tratta, infatti, di un chiaro sintomo di assenza di prospettiva di sviluppo sociale e civile e dimostra una incombente crisi nell’attuale nuova fase di sviluppo imperialistico; crisi che può anche essere trascinata a lungo ma che ha le caratteristiche della strutturalità, in quanto l’attuale guerra non è e non si presenta come effetto di scelte politiche “errate”.
Se guerra significa carattere tipico e strutturale per tutte le diverse configurazioni dell’imperialismo, lo è ancora di più nell’attuale fase di competizione globale, di contrapposizione interimperialistica. Allora è su questo che bisogna ragionare ed è questa che va interpretato, in quanto ciò modifica completamente un quadro generale ed internazionale che negli anni ’90 si presentava, o ci veniva rappresentato, come forte e stabile.
Se allarghiamo la riflessione oltre la dimensione bellica, emergono altri sintomi di questa crisi di egemonia. La quale, a ben vedere, non è che la conseguenza di una caratteristica essenziale del modi di produzione capitalistico (MCP), già perfettamente posta in luce da Marx: cioè la sua capacità di incessante innovazione tecnologica, accompagnata, però, dall’incapacità di utilizzare appieno la stessa innovazione prodotta, nonché la tendenza a dare a questa innovazione una valenza, contraria alle aspirazioni umane profonde. In questo modo, lo stesso svolgimento storico del MCP offre la più evidente smentita – ed oggi più che mai – delle sue ipocrite pretese di libertà e di rispetto dei tanto propagandati “diritti umani”.
Il rischio dell’“apprendista stregone” è sempre presente, in quanto si mobilitano forze sociali enormi per finalizzarle a risultati a queste di fatto estranei. Quando parliamo di “crisi di egemonia” del capitalismo intendiamo nient’altro che il manifestarsi di questa contraddizione.
Per riprendere il discorso iniziale, i sintomi di questa crisi sono evidenti da tempo e non vengono affrontati e risolti, né potrebbe essere altrimenti, in quanto la crisi assume anche carattere strutturale tendendo alla irreversibilità.
Si vedano solo alcuni esempi.
- La questione ambientale è forse quella che da tempo è ben presente non solo agli ambientalisti ma alle oligarchie del capitalismo mondializzato.
- L’uso della scienza a fini privati che genera miseria, ad esempio tra i contadini del Terzo Mondo, e paure che assumono la forma di psicosi di massa, come sulla vicenda della mucca pazza.
- La “superfluità” di masse di popolazione mondiale ai fini della produzione di profitto, che nei paesi sviluppati si manifesta come disoccupazione strutturale e nel resto del mondo sotto la forma di fame, epidemie, guerre civili, emigrazione con il conseguente spopolamento di ampie parti di continenti, come l’Africa o come l’Asia Centrale, magari ricchi di materie prime.
- La riduzione della democrazia sempre più a simulacro formale negli stessi paesi imperialisti (negli altri non è mai esistita realmente), dove la capacità di partecipare, non solo dei lavoratori ma anche di tutti i “cittadini”, è espropriata dalle oligarchie che rappresentano il capitale.
- Si potrebbe parlare di come sta nascendo un nuovo soggetto storico quale l’Unione Europea che viene costruita con ben poco rispetto delle stesse regole democratiche borghesi.
- Nelle manifestazioni dell’apparente contraddizione tra possibilità e fini, la guerra svela la vera faccia dell’imperialismo, la sua natura intrinseca, ma allo stesso tempo “sveglia” gli animi sopiti perché rappresenta la “cima della montagna”, il punto dove la società capitalista per svilupparsi deve distruggersi.
Naturalmente nel parlare di guerra non dobbiamo fare errori di schematismo e pensare che la terza guerra mondiale sia alle porte. Il punto non è questo in quanto, realisticamente, ci troviamo all’inizio di una nuova fase lunga in cui si va concretizzando una nuova figura obiettiva di imperialismo e di contraddizioni interimperialistiche, nelle quali la guerra rappresenta una condizione endemica e le cui forme di espressione e di sviluppo oggi non sono prevedibili. Basti pensare alla presenza delle armi atomiche ed alla loro diffusione vista come pericolo ma anche come deterrente rispetto ad una guerra che abbia le forme storiche già conosciute nelle due guerre mondiali del ’900.
Avere presenti gli attuali livelli di contraddizione del capitalismo ci deve far rifuggire risolutamente da ogni ipotesi catastrofista, in quanto, se è vero che il rischio di divenire “apprendista stregone” il capitalismo lo corre effettivamente, è anche vero che un ruolo fondamentale nella storia dell’umanità lo ha sempre svolto la soggettività.
Dunque, pensare che le contraddizioni determinino nel breve-medio periodo una fine, e magari producano un nuovo inizio, è una visione deterministica, religiosa, del corso della storia che ha portato il movimento operaio spesso a non capire da che parte “poteva”, e non doveva, andare il mondo alla fine del secolo passato.
Questa ipotizzata crisi di supremazia, di egemonia ha, dunque, delle possibilità, delle potenzialità che da sole però non vanno certo nella direzione da noi auspicata e della quale dovremmo capire bene le caratteristiche. È su questo approfondimento che occorre lavorare per individuare le basi materiali della crisi di civiltà che si sta manifestando nella cosiddetta “globalizzazione” capitalista.
3. UNA NECESSARIA LETTURA DIALETTICA
Guerra ancora una volta come fase di “rilancio” dello sviluppo capitalistico e declino di egemonia come effetto di questo nuovo livello delle contraddizioni; sono vere queste affermazioni? O meglio in base a quali criteri e riferimenti arriviamo a queste conclusioni?
Non basta certo l’esperienza empirica per formulare simili giudizi. D’altra parte il sistema capitalistico – per mantenersi e svilupparsi – ha prodotto due terribili guerre mondiali, che lo hanno favorito anche nel compito di comprimere ed, alla fine, vincere – mediante quella che vien chiamata “guerra fredda”, ma che ha molto l’aspetto di un’autentica terza guerra mondiale – la sfida ad esso lanciata da quei paesi non solo europei, in cui il proletariato ha tentato, per la prima volta, la strada verso il socialismo. È in questo tragico modo che, oggi, quello capitalistico appare l’unico sistema sociale dominante intemazionalmente.
Qui si pone il nodo degli “ingredienti” da usare per la costruzione di una visione scientifica del mondo – nel senso, in cui Marx e Lenin usano il termine e qui si pone il problema del dibattito e delle divergenze, che hanno caratterizzato e che ancora segnano il movimento comunista (se così si può ancora chiamare) e in generale il movimento intemazionale di lotta contro l’attuale fase imperialistica.
In termini più espliciti, è ancora valida la tradizione teorica, che giunge fino a Marx e a Lenin? Sono ancora valide le direttrici politiche fondamentali del leninismo?
Indubbiamente gli ultimi due decenni del XX secolo hanno posto un serio problema di interpretazione dello sviluppo storico, con tutto quello che ne consegue sul piano della teoria, delle concezioni politiche ecc., ed hanno colpito e reso incerto un pensiero che era sembrato effettivamente, per la prima volta, incidere sulle vicende umane in modo progettuale.
È scaturita da questa fase una confusione ed un disorientamento di cui vediamo gli effetti tutti i giorni a livello intemazionale.
Non possiamo ora pensare di dare delle risposte certe a questo scompaginamento degli schemi interpretativi marxisti, in quanto sarebbe una velleità volontarista, ma pensiamo che vada continuato, per quanto ci riguarda direttamente pur senza ritenerci “decisivi”, un serio e lungo lavoro che entri nel merito delle questioni e che si prenda la responsabilità della chiarezza e della verifica. Sottrarsi a queste condizioni, nella definizione di una visione generale delle cose, significa continuare sulla strada del pensiero “debole” che è sempre destinato a soccombere, nonostante le mode.
Intraprendere questa strada significa, per prima cosa, prendere le distanze da ogni atteggiamento schematico e difensivo che si riduce alla ripetizione di definizioni e giudizi tanto giusti (non sempre) quanto inutili.
Se partiamo da questa necessità, prima ancora teorica che pratica, in quanto abbiamo constatato come lo schematismo sia impotente, ci si pone in primo piano un problema metodologico: come riaffermare la correttezza della visione marxista rinnovandone la forza nell’età odierna.
Su questo riportiamo un passo del seminario organizzato dal giornale Contropiano su “Partito e Teoria” che esplicita in modo chiaro il metodo dialettico da adottare e che prende a pretesto uno scritto di Togliatti (P. Togliatti. Il Partito Comunista Italiano. ER 1997).
“Quando noi diciamo che in Italia è necessario ed è maturo uno sviluppo verso il socialismo, esprimiamo un concetto economico e politico abbastanza complesso ma nella realtà della vita di tutti i giorni questa necessità si esprime in modo diretto, che tutti i lavoratori possono percepire.
Noi partiamo dall’analisi dei rapporti di produzione, constatiamo che questi sono giunti alla fase capitalistica e già toccano gli ultimi stadi della evoluzione del capitalismo, contrassegnati dalla espansione imperialistica, dal prevalere del monopolio sulla libera concorrenza dei produttori isolati e da una generale tendenza alla reazione politica.
Naturalmente, questo è soltanto uno schema generale, nel quale, per renderlo vivente e aderente alla realtà si deve inserire la considerazione dei residui di passati regimi economici e del loro peso relativo, la considerazione dei contrasti interni che sono, in relazione con ciò, specifici del nostro paese e la considerazione del posto che esso ha occupato e occupa nel mondo. La realtà economica si traduce poi, a seconda dello sviluppo concreto degli avvenimenti, in contrasti precisi di classe e politici, sui quali esercitano grande influenza le forme di organizzazione della società, delle classi e dello Stato, le tradizioni lontane e vicine, il grado di coscienza acquistato dai differenti gruppi sociali, e prima di tutto dalla classe operaia e dalle classi lavoratrici.
Quando parliamo di maturità storica e di necessità economica e politica dello sviluppo verso il socialismo vogliamo quindi dire che la maggior parte delle questioni sono essenziali per il progresso del paese e vitali per la maggioranza dei cittadini, o vengono risolte in modo che porti ad intaccare e ridurre, sino a distruggerli i privilegi del ceto dirigente capitalistico, oppure non possono mai essere risolte in modo radicale, definitivo. Le classi dirigenti possono ottenere, con queste o quelle misure, determinati risultati, o respingendo le richieste delle popolazioni e comprimendo il loro movimento rivendicativo, oppure facendo concessioni e ammettendo conquiste parziali di questo movimento. In questi casi però le questioni si ripresentano, alla fine, in altro modo, talora più acuto, su un terreno differente e in forme diverse dalle precedenti, aprendosi cosi contrasti e contraddizioni nuove, che continuamente travagliano la società. (…)”
Quale che sia il giudizio da dare sull’azione politica di Togliatti e per quanto la pagina citata rimandi ad un contesto per molti versi assai diverso da quello in cui oggi ci troviamo, dal punto di vista teorico tuttavia questa stessa pagina si presta bene al chiarimento di alcuni punti essenziali in merito alla dialettica. L’argomento di Togliatti si svolge a due livelli: quello che ha per oggetto la dinamica propria del modo capitalistico di produzione, e l’altro, che tiene conto delle particolarità di un capitalismo determinato, Vitaliano. Questa duplicità di piani non ha nulla a che vedere con le “vie nazionali al socialismo”, ma si con la distinzione – dialettica – fra dinamica del concetto da un lato e dinamica del concetto nell’esistenza dall’altro.
In altre parole, all ‘esperienza effettiva non si presenta mai il modo capitalistico di produzione, ma si un modo capitalistico di produzione (italiano, sudafricano, nordamericano, ecc); tuttavia non sarebbe possibile comprendere e prevedere le dinamiche di un certo determinato modo capitalistico di produzione, se non si conoscessero le dinamiche del modo capitalistico di produzione in quanto tale; in realtà è solo perché conosciamo queste ultime che possiamo riconoscere, poniamo, nelle vicende economico-sociali italiane le manifestazioni del capitalismo in versione italiana. In altre parole, la conoscenza del concetto – e solo questa – mi mette in condizione di comprendere quanto si mostra, si presenta nell’esistenza effettiva.
Ciò dipende dal fatto che, nel linguaggio della dialettica, concetto non è tanto il risultato di un’operazione di astrazione, quanto piuttosto di comprensione della dinamica – o “linea di sviluppo”. come Marx diceva – di un certo tipo di realtà (nel nostro caso, il modo capitalistico di produzione).
Siccome, però, ciò che esiste ne II’esperienza è sempre e solo il caso determinato, quando il mio problema sia agire su quel caso determinato (ed agire è possibile, solo, su casi determinati) allora la mia consapevolezza deve avere come contenuto non solo la generale “linea di movimento” della cosa ma sì anche le particolari movenze che essa assume svolgendosi operando, entro la determinatezza del caso in questione (e nel testo citato Togliatti indica molto bene le “determinatezze”, che vanno considerate per operare nel contesto di un certo capitalismo, collocato in uno spazio e in tempo determinati).
È questo perciò lo sforzo di elaborazione che oggi bisogna fare; cioè prendere tutti quegli elementi che interpretano ancora la dinamica reale della società capitalista, analizzati dal pensiero di Marx ma anche dai grandi teorici del ’900 del movimento comunista, e collegarli alle forme che questi assumono oggi in un contesto produttivo, sociale, culturale, scientifico e politico del tutto nuovo rispetto al passato nella sua esistenza concreta attuale.
Naturalmente questa premessa metodologica e di ricerca deve essere completata da una fondamentale e decisiva “analisi concreta della situazione concreta” che abbia i caratteri di approfondimento e di scientificità necessari.
È dunque sul merito delle questioni che è possibile verificare la validità del pensiero marxista pur nel rinnovato contesto storico.
4. L’IMPERIALISMO DEL XXI SECOLO
Quando, nella seconda metà degli anni ’90, abbiamo cominciato a riprendere l’analisi sull’imperialismo, a partire dal saggio popolare di Lenin, in realtà ci sentivamo un po’ “anomali” rispetto alla posizione che c’era all’epoca sul mondo unipolare che più che maggioritaria era “unica” anch’essa.
La lettura delle analisi fatte quando il pensiero comunista era vitale ed incideva nella realtà ci ha portato a due tipi di conclusione che poi abbiamo sviluppato.
La prima era che le caratteristiche di fondo deH’imperialismo dell’epoca di Lenin mantenevano intatta la loro validità in quanto dinamiche reali della società capitalista odierna che conferma e accelera, e quindi non toma indietro, su monopoli, concentrazioni, ruolo del capitale finanziario, conflitti per la spartizione di zone di influenza, imposizione di gerarchie di proletari “metropolitani” e “periferici”.
La seconda è che tale dinamica oggi si esprime con figure diverse e in modo diverso da quella degli inizi del ’900, quando la dimensione nazionale era quella storicamente adeguata a creare le condizioni migliori per lo sviluppo delle forze produttive di quell’epoca
La presenza delle esperienze socialiste dal ’17 all’89 ha contribuito a modificare le caratteristiche dell’imperialismo nel ’900.
Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, il mondo capitalista è sempre stato di fatto unipolare, il nemico comune aveva fatto relegare in secondo piano le contraddizioni interimperialiste, e la competizione tra sistemi sociali diversi aveva impegnato l’occidente in uno sviluppo potente delle forze produttive, dalla scienza fino alla riorganizzazione sociale della produzione.
Senza averne avuto coscienza all’epoca, con effetti politici probabilmente gravi, possiamo dire che ciò che può essere in qualche modo paragonato alla categoria dell’“Impero” come modello è da tempo alle nostre spalle, nel senso che una “quasi assenza” di forti contraddizioni interimperialistiche si è avuta dopo la II Guerra Mondiale in una condizione non “mondializzata” del capitalismo.
La fine dell’URSS ha restituito al mondo i caratteri, le dinamiche, i modi originari dell’imperialismo ma con nuove figure e configurazioni nelle nuove vesti di una potenzialità delle forze produttive molto più vasta che stanno ridisegnando la mappa economica e sociale mondiale attorno a nuove dimensioni statuali.
L’Unione Europea, pur nella contraddittorietà del proprio sviluppo, è un frutto di questa nuova condizione, come pure la nascita del NAFTA negli anni ’90 e della FTAA (Mercato Comune Americano) ora sono una espressione diretta degli Stati Uniti.
Blocchi economici e statuali, in forme nuove e non paragonabili meccanicamente al passato, si vanno costituendo nella reciproca competizione, ricreando al loro interno la dimensione di nuovo storicamente adeguata per lo sviluppo delle potenzialità attuali delle forze produttive, come la dimensione nazionale lo era all’inizio del ’900.
USA e UE sono gli esempi più compiuti di un tale processo storico; ma accanto a questi c’è la ridefmizione degli equilibri in Asia con la crisi giapponese e la crescita della Cina, e c’è il tentativo della Russia di avere sue politiche imperialiste.
Imperialismo e blocchi economici sono le forme attuali di espressione, dal nostro punto di vista, del capitalismo.
A cinque anni circa dalla enunciazione di questa nostra visione delle cose, ha preso finalmente vita un dibattito generale che ci ha fatto superare una sorta di isolamento nel quale ci volevano costringere e che ha riportato la questione dell’imperialismo e della competizione interimperialista al centro della discussione.
L’enunciazione a sinistra della “Teoria dell’impero”, che supera una visione empirica e sovrastrutturale che era espressa nella posizione del mondo unipolare che si aveva negli anni ’90, è un fatto positivo; non perché condividiamo questa ipotesi quanto perché rilancia la necessità di un dibattito teorico di livello del quale se ne sente l’assenza da tempo e che è fondamentale per ridare vigore a qualsiasi ipotesi di trasformazione sociale.
Riteniamo di aver espresso in modo forse non sufficiente, ma compiuto, la nostra posizione sull’imperialismo in testi, convegni e dibattiti sviluppati in questi anni.
Dalla metà degli anni ’80 e con la fine dell’Unione Sovietica si è entrati in una fase unipolare di dominio, la fase della globalizzazione a guida USA, in una sorta di modello, per così dire, da “superimperialismo”. Una globalizzazione in cui il modo dello sviluppo capitalistico, le dinamiche di accumulazione, la struttura del mercato del lavoro, la completa liberalizzazione e deregolamentazione dei movimenti di capitale speculativi e non, i livelli di concentrazione proprietaria e di delocalizzazione senza precedenti, rappresentano l’esportazione forzata del modello americano, l’imposizione dell’imperialismo USA al mondo intero.
È in base ad analisi incentrate su considerazioni di carattere politico-economico e militari che si individua un’accesa competizione tra poli imperialisti con l’affacciarsi sulla scena dell’UE, dell’euro e delle implicazioni intemazionali connesse ai processi di espansionismo geoeconomico e geopolitico. È così che si può sostenere, certamente, che già da prima della metà degli anni ’90 la cosiddetta globalizzazione è finita insieme alla fase dell’imperialismo monopolare. Ciò si è realizzato proprio a partire da alcune caratterizzazioni che hanno assunto dopo i primi anni ’90 le modalità delle dinamiche dello sviluppo capitalistico. Si è trattato di processi collegati nell’ambito di un rapporto capitale-lavoro sempre finalizzato al controllo sociale interno ad ogni paese capitalista e allo scontro esterno per la determinazione del dominio globale. Un comando internazionale che si è esplicitato attraverso l’allargamento delle aree di influenza geoeconomica dei grandi blocchi degli USA, dei paesi-guida europei e del Giappone, o comunque della variabile asiatica.
Se globalizzazione, intesa come logica unipolare d’impero, c’è stata, questa ha, per quanto spiegato in precedenza, esaurito le sue funzioni fra la fine degli anni ’80 e quasi la metà degli anni ’90.
In questo contesto si apre la guerra di egemonia interimperialista. È così che si entra nella fase aperta della competizione globale e gli USA pur di mantenere una situazione di assoluto dominio tentano in tutti i modi di combinare la dimensione geopolitica e militare con quella geoeconomica.
Tutto ciò, però, non può non entrare progressivamente in conflitto con le mire espansionistiche degli altri poli imperialisti.
Sinteticamente quello che emerge dalla lettura dei dati e delle analisi ufficiali dei centri studi del capitale è che la globalizzazione, in effetti, è una competizione globale sempre più forte, non tanto e non solo fra imprese nel mercato mondiale ma soprattutto si tratta di una competizione accesa tra aree economiche, tra i blocchi economici UE, USA e variabile asiatica. La globalizzazione è un’espressione propagandistica, mediatica e serve a celare la nuova fase dell’imperialismo e delle lotte interimperialistiche. Una competizione globale per poli in cui gli Stati nazione hanno ancora un loro ruolo 10
ben definito e compatibile ai processi di gestione della crisi di accumulazione del capitale in un contesto di nuovo ciclo di guerre imperialiste.
È fondamentale, pertanto, in questo documento portare la nostra riflessione sulle cose che ci dividono da chi sostiene la “Teoria dell’impero”.
Alcune premesse; la “Teoria dell’impero” non è, necessariamente e solamente, quella espressa da Tony Negri in quanto, in forme diverse, ha assunto la stessa posizione, ad esempio, la maggioranza di Bertinotti nel PRC; inoltre quando si parla di Impero non si parla degli USA specificamente ma di una capacità unitaria a livello mondiale del capitalismo di dirigere i processi complessivi.
A questa impostazione abbiamo da contestare alcune contraddizioni che ci sembra vengano rimosse e non affrontate in modo adeguato.
La prima è di carattere economico strutturale. Infatti una serie di dati mettono in evidenza la tendenza a coagulare le economie non attorno ad un solo polo mondiale ma a più poli regionali. Ad esempio il 30% del commercio mondiale è interno all’area dell’Unione Europea, oppure come spiegare la nascita dell’Euro come moneta di riserva mondiale quando fino ad oggi il dollaro ha svolto “bene” il suo ruolo internazionale? È in controtendenza anche la crisi del WTO, bloccato da continue contraddizioni nel commercio mondiale, come sempre più indefiniti appaiono i ruoli del FMI e della Banca Mondiale. Andrebbe anche spiegato come mai i processi di concentrazione delle società multinazionali non avvengono prioritariamente a livello intemazionale ma si assiste a concentrazioni regionali che rafforzano i poli economici.
La seconda contraddizione è di carattere istituzionale, in quanto i processi di integrazione hanno bisogno di strutture istituzionali e statuali che li sostengano, le istituzioni internazionali invece vivono una fase di indeterminatezza e di indebolimento. Questo è evidente da tempo per l’ONU ma, sorprendentemente, lo è stato nella vicenda afghana anche per la NATO che sembrava l’unica istituzione che fosse sopravvissuta al dopo comuniSmo e rafforzata soprattutto dopo l’aggressione alla Jugolavia del ‘99. In realtà le istituzioni internazionali vengono utilizzate a seconda degli eventi e delle opportunità dai “ soggetti” reali, cioè dagli Stati, ma non sono legate ad un progetto politico mondiale organico necessario ad una effettiva ipotesi di Impero.
Ancora, andrebbe anche spiegata la funzione attuale della guerra e la crescita esponenziale degli episodi bellici nella fase attuale del capitalismo. In altre parole il keynesismo bellico, che si inizia ad intravedere, è una necessità strutturale e, quindi, realtà permanente dell’imperialismo che ridefinisce anche gli equilibri geostrategici attraverso le lotte interimperialistiche, oppure la guerra è oggi solo un intervento “poliziesco” dellTmpero? A noi sembra che la seconda ipotesi non tenga di fronte allo sviluppo degli eventi concreti.
Infine c’è una constatazione di tipo storico-filosofico: la critica al capitalismo è una critica alla irrazionalità di un sistema che non riesce a superare, se non temporaneamente, le proprie contraddizioni interne. Se effettivamente il capitalismo riuscisse ad avere un governo unitario delle sue contraddizioni a livello mondiale è evidente che sarebbe questo il sistema sociale che riesce a dare progettualità e razionalità al futuro dell’umanità e non certo un utopico comuniSmo che sostituisca i fini privati del capitalismo con quelli collettivi.
Che tutto ciò sia storicamente avvenuto dentro un percorso tortuoso dove sviluppo e guerra si sono intrecciati è del tutto secondario; il punto centrale sarebbe comunque che il capitalismo è riuscito a superare quella sua irrazionalità che è alla base di ogni critica nei suoi confronti.
Il dubbio forte che solleviamo è che la “Teoria dellTmpero” corra il rischio di non sviluppare coerentemente una critica complessiva anticapitalista e di consolidare, invece, la forza ideologica dell’assetto attuale affidando al comuniSmo spontaneo ed al “Contro Impero” una alternativa sociale improbabile, generando così un impressionismo pubblicistico che, per creare suggestioni editoriali, potrebbe arrivare a determinare accettazione ed identificazione con l’attuale modello di sviluppo per mancanza di credibilità dell’alternativa.
Naturalmente qui ci limitiamo ad accennare argomenti che sono già stati sviluppati in altre occasioni, o che andranno sviluppati in futuro, e che in questo documento non possono trovare ulteriore approfondimento per ovvi motivi di spazio.
Si è scritto che è necessario evitare ogni schematismo nelle analisi e dunque, sulla questione deUTmperialismo/Impero c’è un dato che va preso seriamente in considerazione.
La conformazione economico sociale dell’imperialismo si sta coagulando, secondo il nostro punto di vista, attorno ai blocchi regionali che si sono definiti in precedenza. Sul piano direttamente economico c’è competizione tra questi blocchi ed addirittura quello europeo potrebbe superare in termini di fondamentali macroeconomici quello statunitense.
C’è però un elemento che determina uno squilibrio tra i due blocchi e, comunque, tra gli USA ed il resto del mondo, ed è quello del monopolio della forza. In altre parole un’analisi della competizione interimperialistica in atto non può rimuovere il dato che l’uso della forza militare è ad appannaggio oggi degli USA e la ripresa del progetto dello scudo antimissile è la conferma che gli americani vogliono mantenere questo primato.
Tale condizione concreta può avere vari effetti; infatti può mantenere il predominio politico degli USA per un tempo più lungo di quello che oggi si possa supporre, oppure potrebbe spingere in tempi più o meno lunghi l’Europa ad un processo di riarmo. Questa tendenza è resa possibile dalla costituzione dell’esercito europeo e dalla tendenziale stagnazione economica anche per l’Unione Europea che potrebbe trovare nel riarmo una via di rilancio.
L’attuale squilibrio, che si verifica per la prima volta nella storia delle società capitaliste, non sappiamo e non crediamo che possa rimettere in discussione il dato strutturale della formazione dei blocchi economici, però, sicuramente, modifica le forme ed i tempi nella manifestazione della competizione interimperialista e ci mette in guardia da visioni manichee su una possibile terza guerra mondiale fotocopiata dal XX secolo.
5. PER UN APPROFONDIMENTO TEORICO SULL’IMPERIALISMO
Nel sostenere la nostra posizione sulla ripresa dell’imperialismo nelle forme attuali dei blocchi economici ci siamo avvalsi in questi anni di un lavoro di analisi statistico-economica, politico-economica, sociale etc. Però questo livello analitico da solo ha il difetto di descrivere i fenomeni, anche di coglierli correttamente nella loro forma, ma non li spiega a fondo. Ne consegue che è necessario continuare nel lavoro di analisi con un tentativo di andare più a fondo nelle motivazioni strutturali.
Il punto anche da mettere in evidenza è quello relativo al meccanismo della economia capitalista, per cui per una fase determinata esiste un meccanismo di crescita, “trascinante” a livello generale, in cui lo sviluppo scientifico, quello economico e quello politico-sociale vanno di pari passo. A questa fase “progressiva” segue invece un periodo in cui il capitale entra in contraddizione con se stesso generando un conflitto tra “fazioni” interne al capitale globale. Cioè si innesta una fase storica in cui i tassi di crescita non permettono più uno sviluppo generale e prevalgono i soggetti “privati”; si apre, così, una competizione, globale in tutti i sensi, dove alla riduzione degli spazi corrisponde un “ frazionamento” del capitale. Questa fase si è manifestata in particolare tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando nella competizione dell’epoca, alcune frazioni del capitale mondiale (quella tedesca, italiana e giapponese) sono state eliminate da altre frazioni (quella USA, inglese e francese).
Ripercorrendo, poi, molto schematicamente le ultime fasi politico-economiche, risulta che già a partire dall’inizio degli anni ’70 comincia a venir meno quel connubio fra sistema produttivo fordista e modelli keynesiani attraverso i quali lo Stato realizzava un contesto complessivo di mediazione, regolazione e compressione del conflitto sociale. L’intenso processo di industrializzazione fordista si sposta, così, verso nuovi mercati, specialmente del Sud-Est asiatico e inizia anche un nuovo e diverso interesse verso l’Europa Centro-Orientale, aumentando la competizione internazionale e mettendo in discussione la leadership statunitense.
Negli ultimi venticinque anni il modello consolidato di democrazia capitalistica, nato negli USA con il fordismo, in tutti i suoi diversi modi di presentarsi, si è dissolto. Contemporaneamente si è andato cancellando quel concetto di società avanzata e di civiltà che aveva inaugurato l’ingresso nella modernità capitalistica, causando lo sbriciolamento della intera struttura produttiva preesistente e distruggendo le stesse forme di convivenza civile determinate dal modello di mediazione sociale di forma keynesiana, imposto anche dalla forza conflittuale del movimento dei lavoratori.
Ne derivano diverse configurazioni del rapporto tra le forme di Stato-governo e processi economico- produttivi ed economico-finanziari; cioè, mutano gli strumenti e l’uso di tecniche (produttive, militari, della formazione di uomini) in rapporto all’esercizio del potere nell’attuale nuova fase dell’imperialismo.
Ecco spiegato perché la crisi del sistema fordista ha portato alla nascita dei nuovi modelli di finanziarizzazione e di accumulazione flessibile basati su intensi processi di competizione globale e sfrenata concorrenza, anche se sempre più spesso imperfetta. La competizione intercapitalistica è così basata sempre più sulla qualità del prodotto, sulla diversificazione quantitativa e qualitativa del lavoro, in un modello sempre più caratterizzato anche dalla messa immediata a produzione delle risorse immateriali del capitale intangibile. Una intensa ristrutturazione del capitale che si accompagna al lavoro manuale sottopagato, delocalizzato e sempre più spesso precarizzato e non regolamentato e a scarso contenuto di garanzie che ne permettono l’uso, il tutto funzionale alle ferree leggi di un mercato sempre più competitivo ma non certo rispettoso delle sue stesse regole “libresche” della libera concorrenza.
Se la cosiddetta “globalizzazione dell’economia” è voluta dal libero gioco delle leggi del mercato, bisogna valutare questo gioco in tutta la sua pienezza, seguendone tutti i processi evolutivi. Interpretare l’attuale crisi dello sviluppo del capitalismo significa, allora, analizzare i meccanismi di gestione di una crisi non più semplicemente di tipo ciclico ma interpretarla con le interconnesse modalità con cui si presenta l’attuale fase dell’imperialismo. Una fase che è comunque finalizzata ad evitare una intensa svalutazione del capitale, in una crisi che assume sempre più anche carattere strutturale, incidendo pesantemente su tutti i meccanismi economico-finanziari che determinano e mantengono il dominio mondiale attraverso la guerra come realtà permanente dell’imperialismo con le forme che esigerà la nuova fase.
L’analisi di fase e dei processi di modifica degli assetti capitalistici mette, quindi, l’accento principalmente sulla competizione globale del dominio geopolitico, geoeconomico e, quindi, sulle dinamiche, degli effetti reali del nuovo ciclo di guerre economico-commerciali e guerreggiate dell’imperialismo. Si comprendono così più chiaramente le necessità insite alla gestione della crisi strutturale di accumulazione, in particolare degli USA, ma non solo.
Questa riflessione ci rinvia alla complessa questione dell’analisi marxiana delle crisi economiche capitaliste, della teoria del valore e della caduta tendenziale del saggio di profitto. Una riflessione che mostra la piena attualità e correttezza dell’intero impianto di analisi proposto da Marx.
Su questo punto centrale si è aperto un dibattito grazie al libro di Bertinotti in cui è stata riaffrontata la questione della teoria del valore e delle sue più dirette implicazioni (crescita, crisi, sfruttamento, ecc.).
Si tratta di un nodo teorico centrale per la corretta lettura delle tendenze storiche del capitale; su questo ci dobbiamo impegnare in un lavoro di approfondimento e di riattualizzazione della tematica, considerando anche la alta composizione organica di capitale che ha l’attuale struttura produttiva.
Qui ci limitiamo a formulare la nostra convinzione che il lavoro, materiale ed immateriale, rimane alla base della produzione di ricchezza e che l’aumento della tecnologia nella produzione, ancora materiale ed immateriale, determina tassi di profitto sempre più bassi a causa del conseguente “risparmio” di forza-lavoro. Da qui la competizione interimperialista che non ha al suo fondo motivazioni politiche o di altro tipo ma è prodotta dal “DNA” della economia capitalista.
Siamo coscienti che questa, per ora, è solo una enunciazione sulla quale siamo però chiamati ad un lavoro di approfondimento e di articolazione della tesi che vogliamo sostenere. Siamo anche coscienti che questo di cui stiamo trattando è una “dinamica essenziale”, una “linea di movimento “ delle modalità dello sviluppo capitalistico che va dimostrata sul piano teorico astraendo dalle forme concrete attuali e che sono, come già abbiamo detto più volte, diverse da altre epoche storiche.
Abbiamo ritenuto necessario tracciare comunque una sintesi, forse estrema, per dare un chiaro quadro teorico di riferimento della posizione che stiamo elaborando, anche per non lasciare e non lasciarci “via d’uscita” comode nella verifica delle tendenze reali che è anche il punto di inizio di un lavoro di elaborazione nel quale siamo impegnati direttamente.
6. LO “STATO COMPETITIVO”
Sono ormai anni che nel quadro della indagine sulla composizione di classe nel nostro Paese e nell’area europea, ci si è dovuti misurare con una questione in molti casi rimossa dal dibattito politico e sindacale: il ruolo di classe dello Stato.
Negli ultimi tempi, il mito acritico della “globalizzazione” sembra aver messo in ombra non solo processi come la competizione intercapitalista o le relazioni internazionali fondate sulla Triade USA, Europa, Giappone ma anche, e qui si entra direttamente nel campo che si vuole affrontare, il ruolo degli Stati.
Esistono molti, anche a sinistra, che ritengono ormai inservibile la categoria di “comitato d’affari della borghesia” come chiave di lettura dello Stato. Tuttavia questa categoria coglie, ancora meglio di altre, la sostanza del ruolo dello Stato nel sistema politico ed economico del capitale e si rivela in tal senso ancora di estrema pertinenza.
Sul piano pratico, se è vero che lo Stato è tornato pienamente a svolgere la funzione di comitato d’affari del capitale finanziario, ciò significa che la dinamica della tassazione, degli investimenti, dei salari e dei profitti – in sostanza della distribuzione reale della ricchezza – segue un trend ben preciso che ha ricadute pesanti sulla realtà sociale e sui lavoratori. Ciò non riguarda solo i meccanismi dell’accumulazione capitalista ma chiama in causa direttamente anche la funzione dello Stato.
Per alcuni decenni, anche nella sinistra e nel sindacato, si era diffusa la convinzione che lo Stato (e soprattutto la “Repubblica nata dalla Resistenza” e “fondata sul lavoro”) avesse assunto appieno il suo carattere universale, neutrale ed in un certo senso “superpartes”. Aver confuso le conquiste sistematizzate in un sistema approssimativo di Welfare State, con un cambiamento più profondo della natura dello Stato in questo sistema politico-economico, ha portato a sottovalutazioni clamorose e distorsioni analitiche significative.
La devastante offensiva antioperaia messa in moto nella seconda metà degli anni ’70 (a seguito della “grande paura” seguita alla grande crisi del ’73 e allo sviluppo delle lotte operaie, studentesche ma anche di quelle anticoloniali nel Terzo mondo), ha via via liquidato ogni pretesa di neutralità o di universalità dello Stato del capitale e lo ha riportato alla sua funzione storica.
La privatizzazione dei servizi, i tagli alle spese sociali, la riorganizzazione della previdenza e della sanità, l’organizzazione apertamente antipopolare del sistema fiscale centrale e locale, corrispondono ad una funzione precisa dello Stato. Esso deve gestire il continuo trasferimento di ricchezza dal lavoro alla rendita finanziaria e al profitto. È una funzione perfettamente in linea con la dominanza del capitale finanziario nell’economia nazionale e transnazionale (classica nell’epoca dell’imperialismo) che ormai domina e rende subalterni tutti gli altri settori della società, inclusi quei settori del capitale troppo deboli sul piano finanziario o troppo vincolati al solo mercato interno.
Ma la modifica della funzione dello Stato rispetto a quella dei decenni del compromesso e dell’uso politico del Welfare State, non produce solo “mutamenti contabili” nel bilancio statale. Essa innesca anche modificazioni notevoli nella composizione di classe ed accentua il processo di polarizzazione sociale in corso in tutte le economie sviluppate. Ad esempio, la “crisi dei ceti medi” (in cui fino a qualche anno fa si potevano includere anche settori di classe operaia e di lavoro dipendente “forte”) non deriva solo dalla accresciuta finanziarizzazione dell’economia, ma anche dalla liquidazione di alcuni paracaduti sociali rappresentati dalla presenza dello Stato nelle aziende dei servizi strategici o dalla “presenza/latitanza statale” in alcune aree (basta pensare al Mezzogiorno, alle pensioni distribuite a pioggia o all’evasione fiscale consentita per il lavoro autonomo, i sussidi per settori marginali dell’economia etc.). In questi ultimi anni, anche gli agricoltori o gli allevatori di mucche prima sussidiati, gli autotrasportatori agevolati fiscalmente, i commercianti o i taxisti in condizioni di mini-monopolio, sono stati investiti come un tornado dalle “liberalizzazioni” dei servizi e dalla competizione economica scatenata in Europa dai templari di Maastricht e dai commissari di Bruxelles.
Lo Stato è tornato ad essere il “comitato d’affari” della borghesia per sorreggerne le ambizioni e gli interessi dentro la competizione globale. La pletora di interessi e di doglianze sociali su cui era stato costruito e mediato lo Stato sociale non ha più ragione di essere. L’integrazione sovranazionale e la costruzione dei poli geoeconomici intorno all’Unione Europea e agli Stati Uniti, invocano uno Stato forte e flessibile, in sostanza uno “Stato competitivo” capace di stare dentro una competizione che ha come scenario l’intero globo.
Il feticcio della globalizzazione sembra ormai soddisfacente anche a molti studiosi e movimenti sociali per spiegare il mondo attuale, le nuove relazioni intemazionali e i nuovi rapporti di forza. Eppure, la categoria della globalizzazione è molto imperfetta e sotto certi aspetti deviante, perché è un’espressione propagandistica che cela la nuova fase del conflitto interimperialistico. È, infatti, più appropriato parlare di competizione globale perché tale è l’epoca che stiamo vivendo; un’epoca in cui la competizione economica e quella politica tra le economie più forti e/o i principali poli geoeconomici (Stati Uniti ed Europa soprattutto) tenderà ad accentuarsi più che a comporsi in un unico “impero” dominato dalle società transnazionali. Oggi, infatti, la struttura di dominio internazionale del grande capitale non appare più organizzata sulla base dello “Stato nazionale” ma su poli dentro cui si coordinano vari Stati tendenzialmente sempre più omogenei sul piano economico, finanziario, monetario e militare. Ed è profondamente errato ritenere che in questo processo gli Stati non abbiano più una funzione determinante.
Lo “Stato/comitato d’affari” si è ormai allargato a livello regionale (ad esempio l’Unione Europea, le cui riunioni, secondo il Financial Times, somigliano sempre più ad un consiglio di amministrazione”) ma mantiene pienamente – anzi accresce – la sua funzione strategica di sostegno politico ed economico all’accumulazione capitalistica, sia attraverso la politica fiscale e di bilancio, sia attraverso la politica commerciale ed intemazionale verso le altre aree economiche e verso gli altri poli imperialisti. Infine, ma non per importanza, lo Stato viene chiamato a svolgere tale funzione anche attraverso lo strumento militare, che, del resto, si è visto all’opera già più volte anche nell’ultimo decennio (vedi Iraq, Balcani, Afghanistan).
Si può allora affermare che la funzione dello Stato nell’epoca della competizione globale dipende innanzitutto della natura dello Stato: esistono, infatti, Stati “disgreganti” (forti) e Stati “disgregati” (deboli). In modo molto pertinente Eric Hobsbawm sottolinea come “una delle grandi questioni che sta di fronte al XXI Secolo è l’interazione tra il mondo dove lo Stato esiste e il mondo dove non c’è”.
Il processo di disgregazione statuale avviato dagli Stati più forti (USA ed Europa) contro l’Europa dell’Est ma anche contro l’Africa “decolonizzata” o l’Asia non più baluardo antisovietico (vedi l’Indonesia e in prospettiva India e Cina), confermano che questa “interazione” è uno dei progetti caratteristici della competizione globale. Per avere una idea concreta, è sufficiente osservare una mappa geografica del mondo attuale e confrontarla con quella di dieci anni fa. Nell’Europa dell’Est solo un decennio fa esistevano dieci Stati, oggi ne esistono ventotto (e forse diventeranno trenta se va ancora avanti il processo di disgregazione della Jugoslavia). Ma è la qualità- più che la quantità- a far riflettere. Dalle ripetute secessioni della ex Urss o dell’ex Jugoslavia, sono emersi numerosi stati piccoli o piccolissimi. Solo alcuni (undici per l’esattezza) superano i dieci milioni di abitanti.
La disgregazione di tutti gli Stati non strategici per i “poli forti” è un processo che sta marciando a tappe forzate dietro la tesi, quasi religiosa, della inevitabilità della globalizzazione e della sovranazionalità dei processi decisionali. Questi nuovi Stati sono piccoli, deboli, subalterni agli organismi finanziari intemazionali (FMI, BM, BERS), sono dipendenti dalla qualità degli investimenti esteri che riescono ad attrarre e dalla quantità di export competitivo che riescono a far arrivare sul mercato regionale e mondiale. A tale scopo, questi Stati devono essere “leggeri” nelle frontiere e nelle dogane, assai “indulgenti” nelle imposte e nelle tasse per gli investitori esteri, obbedienti al FMI nella politica di privatizzazioni e liquidazione dei settori statali dell’economia, puntuali nel pagamento dei debiti accumulati con le banche e gli istituti internazionali, implacabili nel mantenere basso e disciplinato il salario dei lavoratori. Infine, devono assicurare con ogni mezzo – democratico o repressivo – la “stabilità interna” per gli investitori esteri. Se non ci riescono da soli può sempre arrivare la NATO con i bombardamenti o gli interventi “umanitari”.
La funzione determinante dello Stato nell’epoca della competizione globale non si limita però agli aspetti geopolitici e della conquista dei mercati internazionali. Anche sul piano dell’accumulazione, e del mercato interno, la funzione dello Stato si conferma decisiva in settori fondamentali dell’economia capitalista.
- La scienza e la ricerca, ad esempio, vanno visti nel loro ruolo di forze produttive sempre più decisive nella competizione globale. Anche se i loro risultati vengono in gran parte monopolizzati dal profitto privato, il loro raggiungimento richiede forti investimenti di capitale e possibilità di ammortizzazione dei costi che ancora oggi possono essere assicurati solo dallo Stato. Il caso delle biotecnologie è, in tal senso, emblematico. I due ultimi governi tedeschi (democristiano prima e social democratico poi) hanno lanciato un ambiziosissimo piano di sviluppo dell’industria e della ricerca biotecnologica. Nonostante in Germania ci siano ben tre delle prime cinque multinazionali chimiche- farmaceutiche del mondo, senza l’intervento economico dello Stato non avrebbero potuto recuperare il gap e reggere la competizione con le transnazionali USA. Lo scontro tra la Bayer e la Pfizer sui farmaci o la legislazione europea verso gli OGM, sono indicativi di questo conflitto e del crescente ricorso alle leggi dello Stato per intralciare la penetrazione delle società concorrenti sui rispettivi “mercati interni”.
- La formazione del “capitale umano” adeguato e funzionale alle nuove esigenze della accumulazione flessibile, è un compito che viene svolto in larga parte dallo Stato. La gestione aziendalista di scuole, università, centri di formazione tende sì a privatizzare la riproduzione e la gestione del comando (l’insegnamento) ma continuerà ad affidare gran parte dei costi sociali allo Stato.
- La stabilità del mercato interno continua a vedere un ruolo centrale dello Stato. Anche se le privatizzazioni hanno via via ridotto la presenza statale nell’economia, l’andamento dei flussi della domanda interna richiedono ancora e massicciamente l’intervento statale senza il quale il “mercato” si è dimostrato incapace di assicurare i margini di profitto all’accumulazione capitalistica. La vicenda della rottamazione delle automobili, i progetti di cablaggio delle grandi aree metropolitane, la ristrutturazione delle reti energetiche e l’estensione di quelle dei trasporti, dimostrano che i padroni in realtà vogliono “più Stato per il mercato”.
- Infine si dovrebbe riflettere sul fatto che non è risultato affatto trascurabile il ruolo degli interessi nazionali dello “Stato francese” nel bloccare in sede OCSE l’approvazione dell’Accordo Multilaterale sugli In vestimenti (il famigerato AMI), o il “ruolo degli Stati” nel fallimento delle trattative della WTO a Seattle o le forzature degli interessi nazionali dello “Stato USA” sulle reticenze delle multinazionali statunitensi del petrolio in relazione ai tracciati che dovevano seguire gli oleodotti dal Mar Caspio. Sono esempi su cui, appunto, occorre riflettere prima di tracciare giudizi frettolosi e quindi imprecisi sull’esaurimento delle funzioni dello Stato.
- Infine, ma non certo per importanza, sull’onda degli attentati dell’11 settembre, assistiamo alla ripresa impetuosa di particolari forme di keynesismo adatte alla nuova fase dell’imperialismo, ancora attraverso l’economia di guerra. Non si tratta solo della “mano dello Stato” che veicola l’aumento delle spese militari ma di un ritorno ad una funzione rilevante dello Stato nell’economia attraverso il rilancio della spesa pubblica a scapito però delle spese sociali. È evidente l’aumento della spesa pubblica in armamenti, apparati di sicurezza, apparati coercitivi e grandi infrastrutture che seguono e accompagnano le spedizioni militari sul fronte esterno e la coercizione e il controllo sul fronte “interno”. La definizione di “keynesismo militare” appare abbastanza calzante.
Non è possibile, poi, sottovalutare i risultati antipopolari e antidemocratici del dibattito politico/istituzionale, che ha caratterizzato il varo della riforma federalista dello Stato modificando la Costituzione e delegando alle regioni molti poteri e molte competenze. Si è così assistito al paradosso per cui mentre la “sinistra” tuonava contro la devolution di Formigoni e Bossi in Lombardia o lo statuto “secessionista” della Regione Veneto, il governo di centrosinistra – ispirato da apprendisti stregoni come il ministro Bassanini o dalle teste d’uovo emiliane dei DS – partoriva un modello federalista di Stato che recepisce ampiamente le ambizioni delle regioni settentrionali amministrate dal Polo e dalla Lega.
La parola magica della sussidiarietà – rovesciata nel suo contrario – spiana così la strada alle privatizzazioni selvagge di tutti i servizi pubblici, sia affidandoli a soggetti privati sia consegnandoli nelle mani del crescente business del cosiddetto “non profit”. La trappola del federalismo liberista è dunque scattata senza alcuna opposizione.
Questo gigantesco trasferimento di risorse economiche dallo Stato alle amministrazioni locali insieme alla pesantissima privatizzazione delle aziende dei servizi locali, sposta notevolmente la gestione dei centri di potere economico ma anche politico, ridisegnando la mappa dei poteri e i flussi degli interessi materiali in gioco.
L’assalto mosso dai nuovi boiardi alla opportunità offerte dalla riorganizzazione federalista delle istituzioni e dell’economia, è passato quasi inosservato, anzi, sotto molti aspetti esso è stato anticipatore di quello lanciato a livello centrale che ha portato alla nascita del Profit State e al dominio monopolistico dell’economia.
Lo Stato federalista è il risultato della riorganizzazione istituzionale avviata già nei primi anni ’90 e che – grazie al sistema elettorale maggioritario e alla cultura plebiscitarista alimentata artatamente – ha consegnato via via nelle mani degli esecutivi centrali e locali poteri sempre crescenti, alimentandone le ambizioni (vedi il “partito dei sindaci” e poi la “lobby dei governatori”) e consentendo di creare una rete di privilegi e di potere che ha materializzato una nuova classe dirigente potente, arrogante e pericolosa.
In quest’ultimo decennio, in Italia si è prodotta una mutazione enorme sul piano qualitativo e strategico. L’integrazione europea ha ridisegnato completamente l’apparato statale e decisionale ed ha ristrutturato in profondità la relazione tra economia, società e Stato. Questo passaggio, è stato utilizzato come un arnese da scasso per piegare gli interessi materiali del lavoro rispetto a quelli del capitale (che è indubbiamente quello che ha determinato ed egemonizza il processo di costituzione del polo imperialista europeo), ma anche per scardinare le precedenti strutture statali ed istituzionali, ed adeguarle alla dimensione sovranazionale dell’Unione Europea e conformarle alle conseguenti esigenze dello Stato competitivo.
La liquidazione del vecchio sistema e del ceto politico tramite l’operazione Tangentopoli, l’introduzione del sistema elettorale maggioritario e del bipolarismo (con l’omologazione delle politiche e santificazione sistematica della logica bipartisan), le modifiche costituzionali sempre più profonde (il federalismo è stato su questo un “vaso di Pandora”), hanno via via normalizzato l’anomalia italiana ed adeguato il “sistema Italia” ai criteri di efficacia, controllo e di neoliberismo economico sfrenato richiesti dal processo di unificazione europea.
Un processo di unificazione europea che è avvenuto e si regge tuttora su un pesantissimo deficit democratico. Se osserviamo le dinamiche della spesa pubblica nell’ultimo decennio, vedremo che mentre sono stati tagliati pesantemente settori come sanità, istruzione, servizi etc, sono state aumentate o tagliate assai meno le spese destinate agli apparati coercitivi dello Stato: i ministeri degli Interni, della Difesa, della Giustizia e…delle Finanze. Si tratta degli apparati statali atti ad esercitare tutti i poteri monopolistici dello Stato: da quello della violenza (rivendicato apertamente dal ministro Pisanu dopo i fatti di Genova) a quello dell’esercizio della giustizia penale e civile, a quello della imposizione e riscossione delle tasse. È un passaggio ineludibile e funzionale in un processo di fortissima centralizzazione come quello avvenuto nel polo europeo e di rafforzamento del potere degli esecutivi.
Questo processo – in un sistema democratico – non è identificabile tout court con lo stato di polizia ma investe nel suo complesso le funzioni dello Stato. All’insegna della lotta contro l’illegalità, l’evasione fiscale, le infrazioni stradali, le infrazioni alle normative comunali etc., è cresciuto sotto i nostri occhi un esercito di funzionari adibiti esclusivamente ad esercitare le funzioni coercitive di controllo degli apparati statali sulla società. In secondo luogo, le campagne demagogiche sulla sicurezza, sulla tolleranza zero, sulla micro-criminalità e sull’emergenza antiterrorismo a livello intemazionale hanno spianato la strada all’aumento di fondi e assunzioni destinate quasi esclusivamente alle forze di polizia.
In tale contesto, la decisione di dotare l’Italia di un esercito su base professionale e di integrarlo nell’Esercito Europeo, segnano un salto di qualità profondissimo e significativo nella riorganizzazione degli apparati coercitivi dello Stato, estendendo e funzionalizzando il loro ruolo alle proiezioni intemazionali e alla competizione globale alle quali deve adeguarsi lo “Stato “competitivo”.
7. IL “NOVUM” DELLA CLASSE
Vasti settori operai – sia pure di paesi per lo più economicamente arretrati – hanno portato un potente attacco all’imperialismo e scosso internazionalmente il potere della borghesia, formando un insieme di paesi (il cosiddetto campo socialista), impegnati nella transizione verso il socialismo. Nello stesso Occidente, economicamente avanzato, pur senza mai raggiungere effettivamente la forza necessaria alla conquista del potere politico, la classe operaia ha dato luogo a vasti movimenti di lotta che, come nel caso dell’Italia, hanno costretto il capitalismo a rinnovarsi e mettere un freno alle sue tendenze politiche autoritarie.
Questo è stato talmente vero ed incontestabile che la controffensiva del capitale parte già dagli anni ’70, rimettendo in discussione questi rapporti di forza, partendo dalla riorganizzazione della produzione tramite la rivoluzione tecnico-scientifica. Ad oltre venti anni di distanza sono più che evidenti le differenze sociali a livello nazionale ed internazionale. Siamo però convinti che questa differenza non abbia affatto mutato i rapporti di classe della società e che questi, ancora una volta, vanno interpretati sulla base del rapporto tra dinamiche e forme che abbiamo fino ad ora utilizzato.
Per comprendere l’attuale fase della competizione globale è determinante, come sempre, connetterla con l’analisi dell’organizzazione del ciclo produttivo, delle caratteristiche del tessuto produttivo e sociale, del ruolo dello Stato, dei rapporti tra le aree internazionali e della loro struttura economica, degli interessi complessivi di dominio ed espansione che determinano il conflitto interimperialistico. Tutte problematiche fortemente connesse, spesso anzi dipendenti dall’epocale passaggio dall’era fordista a quella cosiddetta “postfordista”.
Si viene definendo un nuovo ciclo produttivo legato fortemente anche alla produzione immateriale che mostra come l’impresa e l’economia cosiddetta postindustriale e postfordista siano fondate più di
prima sui processi di finanziarizzazione dell’economia e sulla messa a produzione delle risorse del capitale intangibile, come processo di trattamento del capitale informazione.
Si realizza, cioè, una intensa crisi di accumulazione che comporta intense modifiche e ristrutturazioni dell’intero sistema capitalistico; il grande capitale internazionale è, quindi, costretto ad aumentare i processi di finanziarizzazione e speculativi provocando al contempo intense trasformazioni del lavoro. Tutto ciò spiega il contesto di sviluppo del lavoro a prevalente contenuto immateriale che si caratterizza estensivamente mediante forme di cooptazione sociale che va oltre la fabbrica e il lavoro produttivo, ed intensamente attraverso l’uso immediatamente produttivo della comunicazione e dell’informazione, risorse del capitale dell’astrazione. Il lavoro immateriale viene così inteso come un lavoro che produce il “contenuto informativo e culturale della merce”, che modifica il lavoro operaio nell’industria e nel terziario, dove le mansioni vengono subordinate alle capacità di trattamento dell’informazione, della comunicazione, orizzontale e verticale.
Da queste analisi emerge che ci troviamo in una fase di transizione ancora in via di definizione ma che presenta comunque dei connotati ben chiari. Si ha un aumento della produzione dei servizi su quella dei beni materiali, ma ciò avviene soprattutto con processi di estemalizzazione dei servizi e di fasi del processo produttivo a basso valore aggiunto basati su un supersfruttamento del lavoro. Un lavoro spesso attinto attraverso processi di delocalizzazione internazionali alla ricerca di forme di lavoro a scarso contenuto di diritti e a bassissimo salario. Si ha, quindi, ancora una volta una delle caratterizzazioni principali delTimperialismo, l’imposizione, cioè, di gerarchie dei proletari “metropolitani” e “periferici”. Si tratta di una determinante della nuova fase imperialista come scelta di divisione della classe operaia metropolitana dal resto; determinante che certo oggi assume caratteri specifici (estemalizzazioni, delocalizzazioni, risorse immateriali, lavoro intellettuale etc.), ma non è certo nata oggi con il just in time, con l’outsourcing, o con altre specifiche “moderne” categorie, come i media e i politicanti anche di sinistra, vogliono far crederci per oscurare la sostanza insita nelle “nuove” modalità dello sfruttamento. È così anche che meglio si capisce l’attuale intenso ricorso alla presenza di lavori intellettuali, della conoscenza e tecnico professionali spesso precarizzati come quelli manuali e ripetitivi.
Tale ristrutturazione complessiva ha portato alla nascita di una forma di lavoro nuovo, alternativo, chiamato anche “lavoro atipico o informale”. Questo termine comprende il cosiddetto lavoro sommerso, precario, illegale, nero, grigio, intermittente, occulto, temporaneo, che si realizza dentro e al di fuori del mercato ufficiale, mal retribuito, senza le regole dei contratti nazionali e che non segue le procedure legali e regolamentative. La mancanza di protezioni legislative e sindacali fa sì che questi lavoratori non siano garantiti in alcun modo e si trovino quindi ad operare in condizioni di lavoro inaccettabili.
È secondo tale direttrice che, a partire dall’imposizione di un nuovo modello di sfruttamento del lavoro, anche se con modi e tempi diversificati, si sta realizzando la nuova fase dell’accumulazione flessibile capitalistica conforti connotati di ridefinizione e di tentativo di riassestamento sul lungo periodo.
La terziarizzazione, la flessibilizzazione dell’economia e la ristrutturazione capitalistica, hanno principalmente creato in questi ultimi anni un numero sempre crescente di lavoratori “atipici ” che sono costretti, a causa della mancanza di lavoro regolare, ad accettare ogni sorta di occupazione con forti connotati di flessibilità delle mansioni (aumentata con il crescere della scomposizione del lavoro) e flessibilità oraria (diminuzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e aumento di quelli a tempo determinato). Si assiste alla nascita di nuove attività, la maggior parte delle quali a carattere terziario, che generano e forzano, nello stesso tempo, lo sviluppo di nuovi soggetti di classe, del lavoro e del non lavoro, di nuovi modelli e nuovi meccanismi di crescita, di organizzazione e di accumulazione.
Tutto ciò non significa certamente abbandono del fordismo, superamento del lavoro salariato o addirittura fine del lavoro. Le forme di produzione fordista convivono con le nuove forme e i nuovi processi di accumulazione del cosiddetto postfordismo, accompagnandosi a relazioni di lavoro di tipo prettamente schiavistico, nel Terzo Mondo ma anche nelle aree economiche a capitalismo avanzato.
In un tempo in cui le macchine vanno a sostituire la forza lavoro, si intensificano gli interventi tesi a restaurare ambiti di supersfruttamento ancora in una società salariale che intensifica le forme contrattuali atipiche (part-time, formazione-lavoro, a termine, ecc.). Questo è dovuto principalmente al nuovo sistema economico, che produce quote sempre più elevate di ricchezza con quote sempre più basse di lavoro; ai processi di informatizzazione che producono un grande risparmio di forza lavoro, permettendo così la diminuzione dell’organico dei lavoratori permanenti a tutto vantaggio di coloro che 18
lavorano in modo precario e a tempo parziale e creando un esercito di lavoratori di riserva in pianta stabile; un incremento continuo della produttività del lavoro che realizza ricchezza destinata a remunerare solo il fattore capitale nelle sue diverse forme e che non ritorna al fattore lavoro in alcun modo (né in termini di aumento dell’occupazione e di diminuzione della disoccupazione, né in termini di riduzione dell’orario di lavoro, né miglioramenti o almeno mantenimento di forme di salario indiretto e differito attraverso lo Stato sociale).
La disoccupazione, la flessibilità e la precarizzazione di salari e delle forme di lavoro, i tagli allo Stato sociale, diventano così fenomeni strutturali, perché è la crisi che ha connotati strutturali e il capitale per uscirne tenta la strada della finanziarizzazione, della scomparsa del lavoro regolamentato e a tempo indeterminato ma non del lavoro salariato e subordinato. Cambiano le modalità e gli assetti organizzativi ma si è sempre nello stesso impianto classico del modo di produzione capitalistico, basato sullo sfruttamento del lavoro salariato, sull’estorsione sempre più intensa di plusvalore.
È evidente che la classe operaia di fabbrica, o fordista, sia in forte diminuzione ma questo non cambia i rapporti di classe, in quanto il lavoro salariato rimane alla base della produzione capitalista che fa della estrazione di pluslavoro la sua ragione fondante.
Nonostante l’ideologia predominante nella nostra società, il lavoro subordinato aumenta, togliendo quote al lavoro autonomo il quale si trasforma in lavoro subordinato anch’esso, nonostante la parvenza di autonomia giuridica che rimane.
Cambia il contenuto del lavoro che segue i percorsi delle trasformazioni produttive, passando dunque da lavoro normale più o meno qualificato a lavoro intellettuale, comunque subordinato. La natura salariata del lavoro si accentua con la flessibilità e la precarizzazione che rafforzano l’estrazione di pluslavoro con il ricatto e la instabilità sociale dei singoli lavoratori.
Questa modifica nei paesi capitalisti avanzati sembrerebbe risolvere il problema della forza che la classe operaia ha dimostrato nella fase storica precedente. Ma se si amplia la visione ad una dimensione internazionale la realtà della classe nel suo insieme appare ben più complessa. Infatti, se i lavoratori dei paesi più sviluppati vivono una condizione diversa dal passato, ma non del tutto se si analizzano nei particolari i dati statistici ufficiali, i lavoratori addetti alla produzione di merci, l’operaio massa degli anni ’70, crescono in modo impetuoso nelle prime periferie dei blocchi economici in via di costituzione. Il Messico e le “maquiladoras” dell’America Latina, l’Europa dell’Est, la Cina e i paesi asiatici, sono le periferie operaie che una volta stavano a Milano, o Torino, o Detroit.
È vero, il capitale con lo sviluppo delle forze produttive ha sconfitto la vecchia classe operaia fordista, ma al prezzo di far crescere il lavoro salariato e di riprodurre la classe operaia nelle nuove periferie continentali.
Anche qui lo schematismo non ci sarebbe d’aiuto se, ad esempio, fossimo portati a pensare che l’aumento in periferia della classe operaia fordista sia di per sè rivoluzionario come nel passato.
Infatti, va rilevato che per la prima volta nella storia del capitalismo la classe operaia addetta alla produzione di merci non sta più nel cuore dello sviluppo, come è accaduto fino alla grande fabbrica fordista degli anni ’70 che rappresentava il luogo della massima produttività. Nel cuore dello sviluppo c’è oggi un’altra tipologia di lavoratore, sempre subordinato ma con caratteristiche diverse dal lavoratore manuale che ha assunto un carattere più marginale nei processi di terziarizzazione dell’economia e nella produzione ad alto contenuto “immateriale” oggi predominante.
Questo è il “NOVUM” della classe con il quale fare i conti in una prospettiva di ripresa del conflitto di classe e della riaffermazione di una soggettività antagonista.
Non possiamo certo affermare che su questo siamo aiutati da esperienze storicamente precedenti. Modifica della composizione di classe e dimensione concretamente internazionale della classe lavoratrice, riproposizione oggettivamente più ampia della contraddizione capitale-lavoro ed indebolimento della soggettività politica; questi sono i caratteri assunti dalla classe lavoratrice e con i quali siamo chiamati a fare i conti nella fase storica attuale.
8. UNA TESI DA SOSTENERE
In questa parte ci siamo concentrati su una sintetica analisi relativa alla oggettività.
Le parti sviluppate, dalla guerra alla nuova composizione di classe, portano alla conclusione, certamente parziale e discutibile, che, a soli dieci anni dalla fine di un modello di società alternativa, lo sviluppo capitalistico mostra sempre più crepe e difficoltà, addirittura in assenza di un antagonista dichiarato come lo sono stati la classe operaia ed il campo socialista del XX secolo.
Previsioni non se ne possono certo fare, né si possono sposare ipotesi catastrofiste che spesso circolano tra la sinistra comunista e non solo.
Quello che ci sembra di capire è che gli eventi iniziati dagli anni ’90 stanno portando ad un aumento delle contraddizioni, da quelle più direttamente di classe a quelle interimperialiste, che potrebbero ricreare la condizione oggettiva, di nuovo per la prima volta dopo la fine dell’URSS, per far rinascere la necessità di un superamento del sistema sociale capitalista. D’altra parte l’affermazione dello slogan “no global” di “un altro mondo è possibile” non è nient’altro che un riflesso di questa nuova condizione. Alla creazione di questa ci sembra spingano le tendenze attuali, che però non porteranno automaticamente ad una risposta positiva se non si crea una soggettività antagonista, condizione indispensabile per trovare uno sbocco alle contraddizioni che si stanno accumulando.
CREDITS
Immagine in evidenza: Uncle Sam’s Birthday
Autore: The U.S. National Archives, 4 luglio 1918.
Licenza: Pubblic Domain
Immagine originale ridimensionata e ritagliata