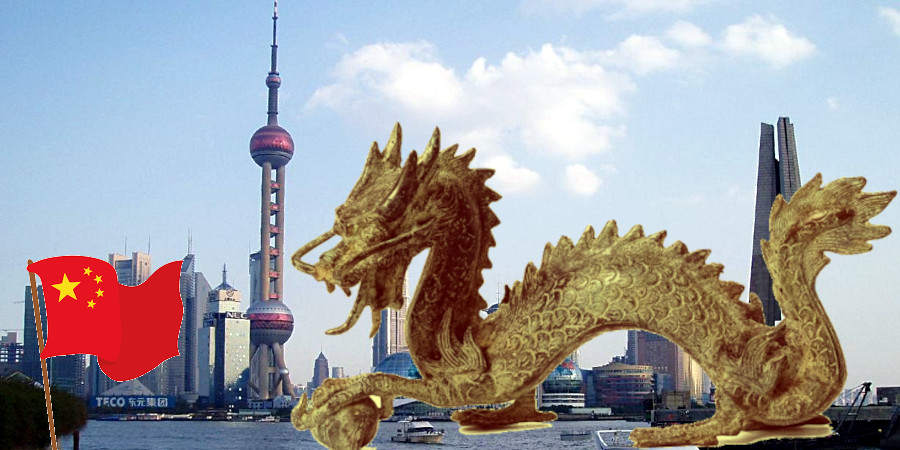L’ignoranza teorica di marxismo e la non meditata azione politica
Gianfranco Pala (Contributo al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
È né più né meno che un inganno sobillare il popolo
senza offrirgli nessun fondamento solido e meditato per la sua azione.
Risvegliare speranze fantastiche (non di altro si era parlato),
lungi dal favorire la salvezza di coloro che soffrono,
porterebbe inevitabilmente alla loro rovina:
rivolgersi ai lavoratori senza possedere idee
rigorosamente scientifiche e teorie ben concrete
significa giocare in modo vuoto e incosciente con la propaganda,
creando una situazione in cui da un lato un apostolo predica,
dall’altro un gregge di somari lo sta a sentire a bocca aperta:
apostoli assurdi e assurdi discepoli.
In un paese civilizzato non si può realizzare nulla
senza teorie ben solide e concrete;
e finora, infatti, nulla è stato realizzato
se non fracasso ed esplosioni improvvise e dannose,
se non iniziative che condurranno alla completa rovina
la causa per la quale ci battiamo.
L’ignoranza non ha mai giovato a nessuno!
[Karl Marx, Colloqui (cur. H.M. Enzensberger – Annenkov su Weitling)]
1. Un paradosso
che si erge di fronte a tutti noi può servire bene come metafora iniziale. Oggi, date le drammatiche condizioni del pianeta, forse è meglio provare a salvare l’“acqua”, pulendola, e non il “bambino”, perché solo in questa maniera, forse, anche lui potrà sopravvivere, altrimenti nulla potrà procedere. L’acqua potabile, che per noi è “pesante” come l’essere, è l’analisi del modo di produzione capitalistico che Marx ha sviluppato, oggettivamente e “cinicamente”, direbbe Lenin; il bambino – il sedicente marxismo, fuor di metafora – è stato reso così “leggero” che ha continuato a sguazzare sempre più nell’acqua non solo sporca ma anche molto inquinata. È cresciuto, sì, ma è cresciuto in un ambiente sempre più lontano e distaccato da quella pulizia, da quella “potabilità”, che pesa come un macigno, ora ignorata e sempre più rigettata.
La metafora nella sua interezza non ha, ovviamente, un senso preciso e corretto per la fisica nucleare; ma vale la pena svilupparla (menzionando per competenza alcune definizioni di esperti, così da concluderla rapidamente). Occorre l’acqua pesante per far sì che essa impedisca che la reazione a catena diventi incontrollabile. Costringendo gli elementi in spazi sempre più ristretti, ognuno di essi tende a muoversi in maniera unica e coerente, diventando un unico grande “organo”; si crea così una direzione, non più caotica e con versi opposti che si annullano dialetticamente. Seguendo per grandi linee ciò che dicono gli esperti, è indispensabile destabilizzare la materia inquinante presente nell’acqua grezza, separando dall’acqua i solidi pesanti che tenderanno a depositarsi, rendendo così necessario un drenaggio periodico dell’acqua reflua per mantenere pulita la “base”. Il marxismo, che ha la parte di unico “grande organo” in questo tropo, ha bisogno per la sua base, per mantenere pulita la sua acqua, che siano periodicamente fatti precipitare i corpi inquinanti.
Per i comunisti, dunque, i corpi inquinanti sono quelli dei “bambini” simil-marxisti. Nelle tesi di apertura di questo incontro si afferma nettamente che l’intellighenzia della cosiddetta “sinistra” non è capace di comprendere. O pure non vuole capire, ché per essa è scomodo, poiché andrebbe contro gli interessi costituiti e l’ideologia della classe dominante, la qual cosa per l’“asinistra” (di oggi e di ieri) è disdicevole. Il documento della rete dei comunisti fa giustamente un’osservazione evidente, e cioè che negli ultimi decenni le prese di posizione di questa specie di pseudo-sinistra internazionale sono il frutto di elaborazioni teoriche niente affatto elevate. Definirle “teoriche”, pertanto, è pure troppo. Ciò che occorre, si dice, è perciò un alto livello teorico, quel livello che latita da troppo tempo. Perfettamente d’accordo.
Senonché per noi, per tutta la sinistra di classe, per il comunismo, questo alto livello teorico di partenza c’è già: è il “peso” dell’analisi fondata da Marx. Ora si tratta di rintracciare la pregnanza attuale di quell’analisi, “ripulendo” quanto – poco o tanto – di significativo ha apportato in séguito storicamente il marxismo non parolaio. Come ha qui notato Vladimiro Giacché, chiacchierare sul fatto che “un altro mondo è possibile”, senza spiegare che cosa ciò voglia realmente dire e senza concretamente e concettualmente discutere dei rapporti di proprietà, non significa niente: per Marx vuol dire “risvegliare speranze fantastiche, giocare in modo vuoto e incosciente con la propaganda”. Tale vaghezza populistica denota totale latitanza della ragione, stravolgimento della storia e occultamento della violenza intrinseca al dominio economico del capitale
Incamminarsi sulla strada, per niente agevole, di una tale critica impone anche di relegare in un angolo i “bambini”, figli o nipotini illegittimi di un marxismo minore, evanescente e dileguantesi, mettendoli in condizioni almeno di non nuocere. Non occorre salvare codesti “bambini” leggeri: è meglio che sia la loro “insostenibile leggerezza” a essere buttata, perché piuttosto è all’“acqua” che deve essere tolta la sporcizia e l’inquinamento, mondandola per restituirle la veridicità. Invece si fanno dibattiti e convegni professorali, da “socialismo della cattedra” come si diceva una volta, che hanno come obiettivo strumentale ogni forma di “revisionismo” (vetero o neo, socialdemocratico o storico, e via demonizzando il comunismo).
Come si fa a considerare marxisti o compagni, sia pure semplici “compagni di strada”, quanti non perdono occasione per declamare le loro “trovate” [per sbaglio dalla tastiera era uscito scritto “troiate”, ma andava bene lo stesso …] di fatto contro il comunismo, gabellandole per “interpretazioni” del marxismo? Come si può continuare a ritenere marxismo, una pseudoteoria che: elimina la forma delle classi; sopprime la rivoluzione; considera un ferro vecchio il materialismo storico; ritiene errata o superata la distinzione dialettica tra struttura e sovrastruttura; ignora perciò, manco a dirlo, che cosa sia la dialettica; isola la circolazione dalla produzione e separa il lavoro dal valore, per mettere al suo posto una indefinibile “moneta”; non considera le condizioni delle forze produttive del lavoro sociale distaccandole dai rapporti di proprietà, ecc.?
Non sono, queste, solo esemplificazioni; fandonie simili e molte altre ancora sono “autentiche”, sempre nel campo dell’asinistra e non dei nemici di classe, e si possono sentire dalla bocca di eminenti dirigenti o leggere in programmi di paludati convegni, o anche in libri e articoli pubblicati insieme a scrivani conservatori o dichiaratamente fascisti per … confrontarsi con loro! È pertanto da condividere l’esigenza posta da questo incontro di rivendicare concetti come quello di classe e lotta di classe, in funzione dell’attività di lavoro erogato in questo sistema sociale, senza sovrapporre descrizioni di stampo giornalistico, aggrappate a suadenti immagini sociologiche e movimentistiche di “identità” o “appartenenza”, di “moltitudine” o “fine del lavoro”; così, come il contrapporre imperialismo a “globalizzazione”, ecc.: tutto ciò è più che meritorio.
Il concetto di classe ha tantissime sfaccettature che attraversano anche il modo di produzione capitalistico; è bensì a esso interno, ma non comincia e non si esaurisce con esso. Occorre perciò conoscerne assai bene le peculiarità – “il socialismo pratico consiste in una corretta conoscenza del modo di produzione capitalistico in tutti i suoi vari aspetti”, scriveva Friedrich Engels, concludendo La questione delle abitazioni – senza recedere alle ricordate mode interessate, fomentate dalla classe dominante. In tutte le formazioni economiche sociali in cui predomini la proprietà privata cominciano a formarsi storicamente diverse classi sociali distinte e contrapposte, ma solo nell’organizzazione capitalistica il lavoro in veste di proletariato acquisisce formalmente in sé stesso un’entità autonoma. Tuttavia, la coscienza di ciò, per il lavoro salariato, necessita di un tempo incommensurabilmente più lungo.
Di qui discendono alcune considerazioni. Da un lato, non è possibile presumere che oggi – ancora “dopo il novecento” – non continui a prevalere e non domini più il capitale, nella sua forma imperialistica. Quindi, la lotta della classe borghese, tuttora egemone, tende a contrastare e combattere tutto ciò che si richiama legittimamente al comunismo, in quanto esso potrebbe essere in prospettiva il modo di produzione dominante in una formazione economica sociale antitetica al modo capitalistico. Finché è la borghesia a “dettar legge” – a esercitare, cioè, la sua dittatura – il concetto di comunismo è l’unica forma antagonistica scientificamente possibile: si tratta di combattere i rapporti di proprietà e di produzione moderni, nient’altro, che riproducono bensì se stessi, ma insieme alla loro antitesi.
D’altro lato, nel modo di produzione socialista (anche quando non ancora dominante) – come si dirà tra poco per la teoria del valore, che non ha “persistenza” in quanto tale oltre l’attuale società – non si possono configurare le categorie del capitale, che è un’organizzazione sociale affatto diversa. Pertanto, una delle troppe conseguenze distorte, dovute alla “fiducia” di quasi tutto il movimento comunista del xx secolo è consistito nel “credere” nell’“irreversibilità del socialismo”. Indubbiamente si è trattato di uno dei non pochi errori teorici (scientifici e politici) che hanno avuto il sopravvento popolare su quanti, in minoranza, hanno provato a criticare codesta lettura, come altre assai poco marxista.
2. La teoria marxista
– da Engels e Marx a Lenin – a fianco e a sostegno della prassi politica, è stata con frequenza richiamata da diversi intervenuti a questo convegno. Nella citata vasta panoramica di Giacché emerge in particolare una constatazione: le contraddizioni della società capitalistica illustrate dal marxismo e sintetizzate nei “punti” indicati da Lenin per l’imperialismo del capitale dell’inizio del novecento “sono ancora tutte lì”. Soltanto il “beato mondo dell’ideologia dominante” può negare la tendenza alla diminuzione del tasso di profitto, l’impoverimento crescente, l’aumento dello sfruttamento, l’eccedenza di forza-lavoro, la socializzazione del lavoro, l’estensione del mercato mondiale, l’ampliamento anche qualitativo del commercio estero, l’impiego di capitali altrui, lo scambio ineguale, ecc. Per inventarsi inesistenti pace e libertà l’ideologia dominante non esita attribuire questo “successo” alla presunta “fine” di comunismo e marxismo.
Il compito della teoria – segnatamente per tutti noi, qui, quella marxista – è precisamente di servire da analisi e da guida per “una solida e meditata azione politica”. Nel xxi secolo, dopo la “storia del novecento”, è possibile scrollare di dosso dalla teoria marxiana tutte quelle superfetazioni che le si sono incrostate sul groppone; dall’esperienza della Comune alle rivoluzioni sovietica e maoista, fino alle molteplici contraddizioni che rispettivamente ne sono seguite, tocca oggi alla società cinese contemporanea essere passata al microscopio critico delle categorie marxiane e comuniste.
Senonché il dramma, per i motivi detti di carenza della ragione, è che l’antagonismo sociale e popolare è sempre più deprivato di consapevolezza scientifica, di coscienza di classe; quella antitesi è stata rabbassata a ribellione o rivolta, rabbia o disperazione, annegando il comunismo nell’acqua “mossa” inquinata da identità, etnìe, fideismi, immaterialità, comunicazione di massa esteriore, nuovismi, ecc. Oggi si può forse intravedere qualcosa con maggiore chiarezza che dieci o vent’anni fa, ma solo se si sconfigge il sonno coscienziale, concependo l’enorme gravità planetaria attuale, pur senza accedere a un incombente catastrofismo bellico, ambientale e culturale. Con un gioco di prestidigitazione la produzione con i rapporti sociali che essa presuppone sono stati fatti scomparire; il loro ripristino può rappresentare un buon punto di partenza.
A noi, dunque, non resta che prendere in esame gli strumenti di analisi critica di Marx e del marxismo. Senza estendere il campo dell’analisi all’enorme massa di indagini marxiane, qui si vuole cogliere e sviluppare un’indicazione emersa, contraddittoriamente, sia in questo che in precedenti incontri della Rdc: concentrarsi sulla considerazione della centralità della teoria del valore (che Marx denotava addirittura come “legge”, ineluttabile come una seconda natura). Si è detto “contraddittoriamente” perché anche nella lettura di Marx si sono evidenziati fraintendimenti sul significato stesso di valore, e del lavoro che materialmente ne sta alla base. È essenziale capire il senso autentico che Marx ha dato a tutta la sua teoria in quanto base scientifica dell’attività politica. Non c’è una sua “teoria” cha abbia un aspetto solo formale, e soprattutto accademico. La politica è una scienza, non un’improvvisazione popolare, moralistica e legalitaria.
In particolare, l’analisi del profitto – nel suo legame con il plusvalore – ha il solo scopo di dimostrare scientificamente l’origine di esso nello sfruttamento del lavoro. Insomma, una chiave di volta dell’intera teoria marxiana sta nella lettura sociale e politica della trasformazione del valore in prezzi di produzione e non nell’asfissiante secolare fissazione dei “marxologi” sui sistemi matematici della serie inaugurata da Böhm-Bawerk e Bortkevič. È vano chiedere agli “interpreti” di Marx quale sia il rapporto di questo problema – a prescindere dal ricordato esecrabile riduttivismo formalistico – con la considerazione sociale, non certo “morale”, dello sfruttamento la cui corretta soluzione analitica data da Marx è totalmente misconosciuta, quasi che fosse assente. Qui – in funzione della dimostrazione scientifica dello sfruttamento – si vuole anzitutto richiamare l’attenzione di quanti si reputano marxisti al fondamentale ruolo e significato teorico di questa “trasformazione” [di trasformazioni ce ne sono tantissime!; tras/forma/zione vuol dire mutamento di forma, e quella in esame, dal valore alle successive figure di prezzo, è una delle tante trasformazioni analizzate da Marx nel movimento del capitale, non certo l’unica e assoluta].
Il criterio seguito da Marx nell’analisi del lungo svolgimento processuale dai valori – la loro sostanza, le loro grandezze, le loro figure fino a quelle monetarie dei diversi tipi di prezzo – consiste nell’esporlo come “forma di movimento” per seguire il mutamento di forme adeguate ai contenuti, senza mutilarne minimamente l’intero corpo analitico. Il nucleo centrale dell’analisi marxiana riguarda la teoria del valore (e, ovviamente, del plusvalore, trattandosi di produzione capitalistica di merci, con forza-lavoro salariata). La trasformazione di quell’analisi nella spiegazione della formazione dei prezzi richiama immediatamente il “fenomeno” dello sfruttamento capitalistico (quello “preistorico”, con la sua parvenza “naturale”, non presenta problemi teorici).
È appunto questo sfruttamento capitalistico che trova la sua spiegazione scientifica precisamente in questa trasformazione dei valori in prezzi di produzione, ovverosia, in ultima analisi, proprio nel significato politico sociale della teoria del valore nella lettura datane da Marx. Anche questa circostanza è sufficiente da sola a motivarne la “demonizzazione” borghese, fin dalla sua base teorica con la riduzione intellettualistica a mero algoritmo algebrico: la dimensione sociale viene fatta sparire e la dimostrazione scientifica dello sfruttamento obliterata e considerata “ideologia comunista”.
Aurelio Macchioro già oltre trent’anni fa, nell’Introduzione da lui scritta, per la Utet, al I libro di Il Capitale di Marx, rilevava a proposito del III libro come il “mercato” in genere, e in particolare l’annosa questione politica e sociale dello sfruttamento, dallo stesso Marx fosse trattata in stretta connessione con la teoria della trasformazione dei valori in prezzi di produzione. Infatti, chi conosce il marxismo non può rabbassare la faccenda a una mera condizione di coerenza “formalmente formale” (avrebbe detto Marx medesimo); rappresentando banalmente il sistema come un problema algebrico di equazioni in equilibrio, lo si è imputato anche di cervellotici errori di calcolo, sulle orme dei “modellini” bawerk-bortkevičiani anche da parte di improbabili “intellettuali marxologi”.
Eppure, la stragrande maggioranza di coloro che hanno “creduto” (giacché di fede si tratta) di schierarsi dalla parte del marxismo, hanno in realtà avuto come costante riferimento, sia pure “critico”, la cosiddetta “trasformazione” dovuta esclusivamente a quegli autori liberali, e non certo a Marx, fondamentalmente ignorato. Occorre rintracciare altrove ilfondamento concettuale – la ragione – di tali problemi e dei fenomeni economici in generale [si veda il commento di Luca Michelini nel saggio (in corso di stampa) La storia del pensiero economico come critica dell’economia politica: il marxismo di Aurelio Macchioro]. Anche per Marx – sosteneva Macchioro – “razionalità non significa coerenza formale ma significa coerenza genetica”.
3. La produzione capitalistica
della ricchezza – che comporta plusvalore o sfruttamento – è, proprio per questi motivi, il luogo della lotta delle classi moderne (che la matematica, ovviamente, non può spiegare); tale processo deve essere analizzato solo con le categorie scientifiche della “teoria della trasformazione”. Si ricordi preliminarmente che, in questo peculiare contesto di mutamento di forma, occorre in primo luogo procedere alla trasformazione del tasso di plusvalore in tasso di profitto, il cui passaggio implica appunto l’introduzione della loro differenza relazionale in relazione al capitale variabile o al capitale totale; poi quella delle rispettive masse, e solo nella terza fase quella “mitica” e fraintesa del valore-in-prezzi.
Il plusvalore (ossia, il prodotto del pluslavoro non pagato) è sempre più spasmodicamente appropriato come profitto dai capitalisti, entro la produzione se ancora possibile, o tramite la speculazione. Anche nel modo di produzione capitalistico così si riproduce in maniera allargata la basilare differenza di classe tra proprietari e non proprietari, ovverosia la questione dei rapporti di proprietà (e dei rapporti di forza). Il salario, la parte pagata del “lavoro”, deriva precisamente dalla contraddizione dei “rapporti di proprietà”. Nel capitalismo, e soltanto in esso, la forza-lavoro è l’unica merce di “proprietà” dei lavoratori, prima che da essi sia venduta per un salario, il quale diviene il loro “reddito” soltanto dopo che il salario è nato come capitale variabile. In quanto merce continuamente riprodotta, essa è venduta ad altri – ossia, letteralmente alienata – dai lavoratori, loro proprietari originari, ai datori di “posti” di lavoro (non di lavoro, come erroneamente si dice, perché il lavoro come attività vien “dato” dai lavoratori medesimi).
Codesta merce peculiare è dunque l’“unica” che nel modo di produzione capitalistico non è prodotta dal capitale, cioè non è una merce capitalistica (sono bensì merci capitalistiche i mezzi di sussistenza che i lavoratori debbono comprare con il loro reddito salariale per riprodurre la forza-lavoro stessa). In generale, sinteticamente il salario:- è relativo agli altri redditi e soprattutto al profitto (in quanto reddito esso stesso prima di essere trasformato in nuovo capitale);- svela l’imbroglio della richiesta (anche “a sinistra”) di un salario minimo (sì che Marx ne deve ricordare il suo essere già “minimo” per la “logica” capitalistica);- è nominale, cioè necessariamente pagato come prezzo in equivalente monetario;- è correttamente concepito come materiale, ossia in base alla consistenza delle merci, in quanto ricchezza, valori d’uso, necessarie alla vita dei salariati;- insomma, per dirlo con una semplice proposizione, il salario è salario sociale.
La composizione di ciò che costituisce, nella media sociale, i mezzi di sussistenza necessari alla riproduzione della forza-lavoro, deve essere data, conosciuta da colui che studia dall’esterno l’economia del capitale. Non interessa all’“agente” di esso al quale, sopraffatto dai libri contabili, non può importare altro che il costo monetario del salario (il suo valore di scambio trasformato nel prezzo). Viceversa, la consistenza materiale delle merci necessarie alla vita della classe lavoratrice riguarda direttamente soltanto il lavoro salariato.
È ovvio che il valore dei mezzi di sussistenza (a volume dato), il cui costo è espresso mediante i prezzi di produzione, necessariamente debba cambiare secondo il livello trasformato dei prezzi stessi. In simili casi artefatti, il potere d’acquisto (come specificamente si dirà appresso) dei salariati ne risulterebbe conseguentemente alterato, poiché a prezzi diversi non è affatto detto che il dato salario nominale possa trasformarsi nei mezzi di sussistenza di cui è costituito il salario materiale.
In siffatte condizioni, chiunque vede che il livello di qualsiasi prezzo per ogni merce della sussistenza sarebbe del tutto indifferente per i lavoratori ai quali fosse garantito il salario materiale socialmente e storicamente determinato. Viceversa, il salario nominale monetario è soggetto per definizione a ogni sorta di speculazione e truffa sui prezzi dei beni necessari da parte dei padroni. Mentre il salario materiale non potrebbe minimamente essere toccato da nessuna variazione dei prezzi, la quale in quanto tale riguarda esclusivamente la diversa spartizione del plusvalore tra i capitalisti (i “fratelli nemici”, come li chiamava Marx). Con il salario nominale, anziché reale e materiale, infatti non c’è propriamente “salario”, se si finge che codesto improprio “salario”, lungi dal rappresentare l’alienazione (vendita ad altri) della forza-lavoro, sia la retribuzione del lavoro svolto, come se si trattasse di una partecipazione del lavoratore alla merce da lui prodotta, anziché della sua dipendenza dal padrone.
Il salario propriamente detto, che nasce come capitale (capitale variabile), vien fatto invece apparire immediatamente nella sua forma di reddito. Anche gli economisti sraffiani, neoricardiani-senza-valore, consentono a tale supponente “salario” di poter variare sull’intera gamma del reddito nazionale (da niente a tutto), includendovi anche una parte di plusvalore (che Sraffa chiama indistintamente “sovrappiù”), in cui i lavoratori salariati possano liberamente fruire anche di una parte del profitto dei padroni da cui dipendono! [A es., la questione reale della cosiddetta “scala mobile” sarebbe tutta qui ricondotta; rispetto al salario materiale, l’inflazione ha la medesima spiegazione della “trasformazione”: a parità di composizione materiale del salario, una modificazione del livello dei prezzi che sia solo nominale non ha concettualmente nessuna conseguenza sul potere d’acquisto dei laoratori; di qui il colossale imbroglio di quella che era detta “scala mobile” e del supponente “rientro dall’inflazione” ottenuto surrettiziamente riducendo il salario (materiale)].
Il problema del divario tra salario nominale monetario e salario materiale risiede precisamente qui. Per massimizzare il tasso di profitto, che deriva soltanto dall’uso del lavoro non pagato (sfruttamento), l’azione padronale sui prezzi (specificamente sui generi di prima necessità) è rivolta a vanificare il significato e l’acquisizione pratica del salario materiale e del valore della forza-lavoro; ciò avviene per l’intercessione della trasformazione del valore nei prezzi di produzione. L’economia politica procede in tale maniera solo per non spiegare l’origine sociale del profitto nel plusvalore, per non parlare di pluslavoro non pagato e di sfruttamento capitalistico: e a questo punto, del lavoro erogato e dello sfruttamento non si ha più alcuna traccia esplicita. È questo il significato politico e sociale, e non formalistico, della cosiddetta “trasformazione”. Così si viene a disperdere l’unica possibile base scientifica della teoria dello sfruttamento capitalistico (tanto che anche i riformisti parlano solo di un “immorale” supersfruttamento del lavoro).
Fatte queste necessarie precisazioni sul salario, converrà riprendere in esame lo svolgimento del processo teorico-pratico della “trasformazione” dal suo inizio: il valore. Le fandonie propalate dal capitale fanno parte della lotta della classe contrapposta, nemica non avversaria. Le sue tesi sono tutte essenzialmente sbagliate, anche se tragicamente seguite da stuoli di accademici, con l’unico intento di abbattere la marxiana teoria del valore e del plusvalore. Fin dal 1868 agli anticomunisti, come notato da seguaci del francese Bastiat, era chiaro che “la confutazione della teoria del valore è il solo fine che si pone chi combatte Marx; infatti, se viene ammesso questo assioma [sic], si devono concedere a Marx quasi tutte le conclusioni, dedotte con la logica più serrata”. Paradossalmente, tuttavia, esse contengono a volte descrizioni – a contrario – quasi “corrette”, trattandosi pur sempre nei dettagli del funzionamento concreto del modo di produzione capitalistico.
Appunto: ridurre ogni teoria scientifica perfettamente costruita – come la deduzione dei prezzi di produzione dalle grandezze di valore o la tendenza del tasso del profitto a cadere per gli esiti delle crisi ricorrenti – ad “assioma”, che si vorrebbe asserito in funzione di fragili fondamenta ideologiche, chiarisce gli intenti del capitale. Contro ciò si erge la rivalutazione dell’aspetto teorico-pratico del marxismo da cui si intende muovere. Tuttavia sono soprattutto nocive le storture concresciute nelle deformazioni dei Tui – accademiche e intellettualistiche dell’“asinistra” – generate in vitro da quanti hanno costantemente operato e agiscono in ogni istante per squalificare il “comunismo” e, in esso, l’analisi marxista che è l’unica scientificamente inoppugnabile. Dio, se ci fosse, potrebbe pensare pure ai nemici, ma dagli “amici” dobbiamo guardarci noi!
4. La teoria del valore
altro non è che la spiegazione scientifica del processo capitalistico nel suo svolgimento logico, e parimenti nella sua determinazione storica, nell’autosviluppo del suo concetto. Basterebbe non dimenticare questo punto di partenza, concettualmente “semplice”, per non cadere poi nelle trappole formalistiche della cosiddetta “trasformazione”. Il rapporto di valore, che è l’essenza della forma-merce, si compie e si eleva dialetticamente nel rapporto di capitale. Esso conserva il rapporto di valore, ma lo supera come rapporto di plusvalore (forma specifica capitalistica dello sfruttamento del lavoro altrui).
La merce e il denaro si sviluppano in capitale e il lavoro in lavoro salariato. Quest’ultimo, nella figura della merce forza-lavoro è determinato dal valore, come ogni altra merce; ma non è la forza-lavoro che determina il valore delle merci, bensì il lavoro (ossia il peculiare valore d’uso di tale merce), misurato immediatamente tramite il tempo. Tuttavia è necessario procedere per stadi successivi, rammentando anzitutto il processo di svolgimento marxiano, in base al quale il valore, sviluppandosi dal prodotto, giunge storicamente a determinare anche il capitale.
Marx stesso sull’argomento ripete che le forme logiche del concetto (secondo Hegel) non sono recipienti morti, per un sapere superfluo, storico descrittivo. In realtà, esse sono “forme del concreto, lo spirito vivente del reale”. Scrivendo a Engels (il 2 aprile 1858) sul “capitale in generale: valore”, Marx aveva precisato che la sua analisi “per quanto astrazione, è un’astrazione storica, che appunto poteva essere fatta soltanto sulla base di un determinato sviluppo economico della società”. Lo sviluppo di codesta “forma astratta” soltanto può spiegare la trasformazione in prezzi (monetari, di produzione, monopolistici, ecc.).
In effetti, qui si tratta di plusvalore che si mostra come profitto, quindi di valori che si trasformano in prezzi, cioè “valore come quantità di lavoro; tempo come misura del lavoro”, concludeva Marx in quella lettera a Engels sul Capitale. “Il valore d’uso – considerato sia oggettivamente come effettualità del lavoro, sia obiettivamente come utilità del prodotto – appare qui semplicemente come premessa materiale del valore, che per il momento resta completamente estranea alla determinazione della forma economica. Il valore come tale non ha altra “materia” che il lavoro stesso. Questa determinazione del valore non è altro che la forma più astratta della ricchezza borghese”. La base oggettiva – si pensi alla consistenza materiale dei mezzi di sussistenza per il salario – in quanto effettualità del lavoro è semplice ma insostituibile e irrinunciabile “premessa”, che tuttavia non attiene direttamente alla forma economica.
Le forme sviluppate della ricchezza borghese non forniscono alcun significato esplicativo se non sono fondate sulla loro “forma più astratta”: il valore, appunto. Senonché diventa quasi inspiegabile il motivo per cui, prima di comprendere questo fondamento e anzi prescindendone, tanti “marxisti” non esitino a buttarsi a capo fitto nei formalismi, voluti dal pensiero positivistico di contro alla logica dialettica dello svolgimento dell’intero processo che ne è sotteso e che la presuppone.
Secondo Marx, il lavoro è “la sola fonte del valore” precisamente in quanto è l’unica “fonte attiva del valore d’uso” [cfr., per tutti gli altri luoghi possibili, Tp, q.XV, f.861]. Questa apparentemente banale constatazione – “rilevabile per via puramente empirica”, dicevano Engels e Marx – vuole affermare semplicemente quello che dice: e cioè che soltanto nel valore, nella sua sostanza, in quanto sviluppo logico e storico del valore d’uso, è rintracciabile la prima origine “materiale” di lavoro. E ciò è dirimente, perché in qualunque forma di prezzo quella “premessa” è perduta. Ovverosia, soltanto con la complessa analisi del valore come sostanza comune dei prodotti ridotti a merce è possibile risalire al contenuto materiale di lavoro; la controprova più evidente è che tutta l’economia politica borghese nega quell’unicità di contenuto.
La questione si complica poiché la forma di merce del prodotto, ossia la sua scambiabilità sulla base del “valore” o di qualsivoglia “prezzo”, è affatto generale e ancestrale. Le trasformazioni storiche della forma di merce – trasposte nel loro processo logico – consentono dunque di delineare la possibile prosecuzione del movimento stesso di tale forma. Nella storia del mercato mondiale, la merce appare dunque come maturità, sviluppo, socializzazione reale, finché il livello di contraddizione del processo di svolgimento della merce determina storicamente il mutamento delle formazioni economiche sociali e dei rapporti di proprietà pervenendo alle loro forme capitalistiche.
Ancorché non tutte le merci siano capitale, il capitale è merce. Il plusvalore diviene la verità – compiuta sul piano storico e logico adeguato al suo dominio – del valore, giacché lo scopo di valorizzazione del capitale stesso si mostra in quanto produzione di valore contenente plusvalore.
L’adeguatezza universale della forma astratta del lavoro, raggiunta col massimo sviluppo della merce su scala mondiale, ossia con lo svolgimento storico del modo di produzione capitalistico, si manifesta in questo come riduzione a merce anche della forza-lavoro (o capacità di lavoro, in generale), ossia della trasformazione del lavoro in lavoro salariato. Quest’ultimo rapporto è il risultato d’un lungo svolgimento storico precedente, il cui processo fa leva sulla primigenia separazione tra il produttore lavoratore e il proprietario delle condizioni oggettive della produzione stessa; lo sfruttamento del lavoro, che ne consegue, comincia con la sottomissione in schiavitù degli sconfitti. Ma la forma capitalistica (per ora finale) dello sfruttamento nasce soltanto laddove il possessore dei mezzi di produzione e di sussistenza trova sul mercato il libero lavoratore come venditore della sua forza-lavoro. Il rapporto tra capitale e lavoro salariato integra perciò lo sfruttamento in questa forma specifica, non in generale.
Non bisogna mai dimenticare che tutto il programma scientifico di Marx (come testimonia anche il titolo della sua opera storica, Teorie sul plusvalore) verte proprio sull’origine del profitto entro lo scambio di tutte le merci capitalistiche, inclusa la forza-lavoro; per definizione, anche quest’ultimo scambio è supposto equo. Spiegare lo “sfruttamento” sulla base di una presupposta ineguaglianza giuridica, di una predominanza di casta (classe), l’una sull’altra, sarebbe banale e non tratterebbe dello sfruttamento capitalistico in forma scientifica. La cosiddetta “trasformazione del valore in prezzi” – nella formulazione di Marx – significa proprio questo, ovverosia risalire al valore, cioè alla base “materiale” di lavoro che è in esso; ciò implica, attraverso il passaggio dal plusvalore al profitto spiegare, anche attraverso i prezzi, proprio lo sfruttamento capitalistico. È la realtà storica pratica del capitale (che presuppone anche il denaro come sua forma) che ne implica il prezzo. E non è questione di risolvere un sistema algebrico di equazioni in equilibrio.
Il nòcciolo di tutta il problema sta nella “scoperta” marxiana della forza-lavoro come merce. Quale altra ragione avrebbe potuto avere Marx, se non questa, per sviluppare lo svolgimento dei prezzi di produzione capitalistici, fin dal loro primo stadio, a partire dal valore, al fine di motivare l’origine del profitto nello sfruttamento del lavoro altrui? La questione sostanziale è da rintracciare nella rammentata definizione – marxiana, va da sé – di salario materiale.
5. Il limite assoluto
del plusvalore – ossia della parte di valore che costituisce il plusvalore – è dato e costituisce un vincolo invalicabile rappresentato dal lavoro non pagato rispetto a quello pagato: questo è quanto precisa esplicitamente Marx [cfr. C, III.50]. Tutto il significato politico della questione della “trasformazione del valore in prezzi di produzione” è racchiuso in ciò. La base scientifica è semplicemente contenuta in tutte le informazioni date: quantità di mezzi di produzione, prodotti e lavoro vivo, e massa materiale dei mezzi di sussistenza. Esse permettono di definire univocamente il tasso medio di sfruttamento prevalente nel sistema del capitale, determinato e calcolabile esattamente, e non inteso come giudizio “moralistico”.
In condizioni storiche sociali date, coerentemente anche le quantità di mezzi di sussistenza, che costituiscono il salario materiale, non possono pertanto che essere date. Quest’ultima conoscenza – la composizione merceologica media del salario materiale (che peraltro richiede un numero di informazioni uguale a quello di qualunque sistema di prezzi) – è così sufficiente per determinare tutte le “grandezze” che si desiderino o che occorrano direttamente nel sistema reale.
Ciò vuol chiaramente dire che il plusprodotto in cui risiede il plusvalore – ossia la differenza tra quelle masse [prodotto meno mezzi di produzione e di sussistenza] è parimenti dato: quali che siano i “pesi” (grandezze e forme di valore o prezzi di qualsiasi tipo) adottati, esso non può cambiare. Il limite assoluto del plusvalore, come detto, è un vincolo invalicabile. In altri termini, infatti, nessun prezzo comunque attribuito ai mezzi di sussistenza può mai, in quanto tale, alterare la loro massa materiale riferita al lavoro. Ovverosia, ogni alterazione delle ragioni di scambio delle merci non tocca affatto la consistenza materiale del salario e di conseguenza neppure quella del plusprodotto totale – e quindi dello sfruttamento del lavoro altrui – ma modifica soltanto le quote attraverso i “valori” (o prezzi) delle parti del plusprodotto medesimo.
È per questo che anche tale questione riguarda unicamente i diversi criteri di spartizione (o ripartizione) del plusvalore tra capitalisti, entro la classe borghese. Il proletariato, il salario dei lavoratori, non c’entra assolutamente niente in tutto ciò – nella “trasformazione”. È quindi chiarito, dato il “limite assoluto”, come concettualmente codesta diversa ripartizione incida unicamente sui capitalisti, ma non tocchi affatto la nozione di misura dello sfruttamento del proletariato come classe. Nel modo di produzione capitalistico, qualsiasi ripartizione del plusvalore tra “fratelli nemici” trova suo fondamento e spiegazione scientifica nello sfruttamento del lavoro salariato che la precede.
Capire in siffatta maniera l’origine dei reali prezzi capitalistici delle merci significa perciò comprendere – non in termini dogmatici – anche l’origine sociale del profitto. Se si afferra, ricostruendo concettualmente il movimento che dai prezzi empirici consente di risalire al lavoro (altrui), alla loro sostanza di valore, questa “trasformazione” assume quella chiarezza che disvela ogni ambiguità di classe della borghesia, e che per ciò stesso essa non vuole che sia detta. Il pluslavoro altrui non pagato ne rappresenta la clausola. In base a questo principio invalicabile per la distinzione tra salario e plusvalore, l’affermazione di un qualunque sistema di prezzi (indifferentemente diverso da quello delle grandezze di valore calcolate), per la sola ripartizione del plusvalore stesso tra i molti capitalisti, equivale a stabilire un sistema di pesi corrispondente alla regola di ripartizione del plusvalore (nella figura sociale del profitto, e, prima di esso, del tasso di profitto).
L’importanza nell’intero processo di svolgimento delle diverse forme di valore stesse è che ogni sistema di prezzi (di produzione o altri) così calcolato corrisponde a una precisa “regola di ripartizione” del plusvalore, socialmente presupposta. La diversificazione di tasso di profitto e massa di profitto, quali che siano, è assicurata in ultima analisi proprio da quei prezzi che fanno pervenire al compimento di tutti gli scambi. Pertanto, una data ripartizione si può avere, alternativamente e con l’identico risultato, sia deliberando simultaneamente le quote di prodotto netto spettanti a ciascuno (a es., come attraverso la pratica dell’“ammasso” di ricchezze), sia attraverso il corrispondente sistema di prezzi.
Usualmente, il passaggio ai prezzi di produzione dai valori – data la diversa composizione del capitale nei vari settori – comporta, proprio attraverso quei prezzi, il trasferimento di parte del plusvalore dai settori a più bassa composizione verso quelli a più alta. Perciò, grazie a prezzi di produzione adeguati, il rammentato trasferimento di plusvalore dai settori a più bassa verso quelli a più alta composizione del capitale è già di per sé indice della maggior forza di questi ultimi.
Nella discendenza di tutti i prezzi capitalistici, presi assieme, dal lavoro altrui non pagato, sta il segreto della “trasformazione” del valore – e del plusvalore derivante dallo sfruttamento dei lavoratori – in prezzi di produzione di qualsiasi tipo. Potrebbe accadere, e ciò in effetti avviene ricorrentemente, in particolare in epoca non concorrenziale e imperialistica, che i tassi difformi di profitto vìolino il “limite invalicabile”, se un numero troppo grande di monopolisti volesse appropriarsi di quote di plusvalore la cui somma eccedesse l’ammontare disponibile, superando il vincolo complessivo di plusvalore.
In tal caso simili “pesi”, i prezzi corrispondenti da costoro imposti, non sarebbero compatibili con l’equilibrio richiesto a priori e non sarebbero pertanto adeguati a redistribuire il plusvalore esaustivamente tra i capitalisti in base alla regola convenuta. Quei prezzi provocherebbero così un’inflazione (una “spirale inflazionistica”, che dipende solo dalle caratteristiche monopolistiche del sistema) la quale, concettualmente, non inciderebbe affatto sui mezzi di sussistenza che costituiscono il salario materiale.
Marx chiarisce ulteriormente il significato dell’intero processo di mutamento di forma dai valori ricorrendo al caso di prezzi di monopolio (corrispondenti a un tasso di profitto che non è generale, e ovviamente, per definizione, non concorrenziale). “Se il livellamento del plusvalore al profitto medio incontra ostacoli in monopoli artificiali o naturali, sì da rendere possibile un prezzo di monopolio superiore al prezzo di produzione e al valore delle merci, su cui il monopolio esercita la sua azione, i limiti dati dal valore delle merci non sarebbero per questo soppressi. Il prezzo di monopolio di determinate merci trasferirebbe semplicemente alle merci aventi prezzi di monopolio una parte del profitto degli altri produttori di merce. La ripartizione del plusvalore tra le diverse sfere di produzione subirebbe indirettamente una perturbazione locale, che però lascerebbe invariati i limiti di questo plusvalore stesso” [C, III.50].
I “limiti di valore” rimangono invalicabili a causa della basilare consistenza materiale, e si avrebbe semplicemente “trasferimento di plusvalore e profitto” (tramite il sistema dei prezzi). Per chi voglia comprendere appieno il significato politico e teorico della “trasformazione”, sia del plusvalore in profitti sia del valore in prezzi, che è il medesimo processo, basti osservare come nel citato passo del Capitale si parli espressamente di “perturbazione locale” che lascia “invariati i limiti del plusvalore”.
I prezzi, dunque, quali che essi siano e come che siano determinati e calcolati, servono unicamente a spartire in maniera diversa il plusvalore tra i soli capitalisti. Nel loro concetto, essi lasciano invariato il “salario materiale”: una casa o un chilo di pane sempre quella casa e quel chilo di pane sono, e nessun prezzo può alterarli. A meno si voglia far leva sul mutato potere d’acquisto del “salario nominale”, il che vorrebbe dire che quella casa o quel pane non si potrebbero più comprare nelle medesime precedenti proporzioni. Proprio di una simile circostanza si avvantaggiano i capitalisti per intaccare il potere d’acquisto dei lavoratori e, con esso, il salario materiale; ma serve loro per gestire una crisi che come tale già c’è. Ma si tratta solo di una “risposta” che può avvenire soltanto dopo che la “trasformazione” in prezzi abbia precedentemente operato.
6. Il potere d’acquisto
(livello dei prezzi) per i lavoratori salariati, ha due conseguenze principali relative ai contestatissimi problemi dell’impoverimento e del consumo, che sono temi così vasti da richiedere una trattazione specifica.
L’impoverimento, a dispetto delle reiterate confutazioni da parte dell’ideologia dominante, tese a invalidare l’analisi teorica marxista, è assoluto; ovviamente, rimane vero che esso è comunque relativo, cioè espresso in confronto con l’aumento della ricchezza e del pil mondiale, e con il livello di vita dei più ricchi. Basti pensare ad alcune circostanze. Negli ultimi 35 anni, quelli dell’ultima crisi mondiale prolungata e sostanzialmente ininterrotta, la crescita del pil mondiale si è praticamente più che dimezzata in media (dal 5-6% degli anni 1950-60, al 2-2,5% fino a oggi, con aumento della disoccupazione). Questo è avvenuto nonostante la sporadica alta crescita “netta” ora di un paese (a es. Giappone) ora dell’altro (oggi Cina o India), aggravando anche i livelli medi di vita delle masse popolari mondiali e perciò l’impoverimento.
Si tenga presente comunque che la crescita della ricchezza mondiale avviene nella sua forma capitalistica, cioè con l’uso intenso della forza-lavoro; ciò è incompatibile con ogni altra possibile finalità “alternativa” (… socialista?), non solo nell’uso dei prodotti, ma in primo luogo anche nelle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa). Inoltre, quasi 2 miliardi di persone “vivono” – sopravvivono! – con l’equivalente [ppp: power purchasing parity, parità di potere d’acquisto], secondo i prezzi del posto, di due dollari al giorno!, e un miliardo spesso muore per fame, sete e malattie; infine, le statistiche dicono che metà della popolazione mondiale ha complessivamente la stessa ricchezza delle prime più ricche 500 famiglie al mondo!
Tutto questo non nega certo i grandi miglioramenti storici del livello di vita, comportato dal capitalismo nel suo “cómpito” storico. Ma l’indubitabile accrescimento del crescente divario tra povertà e ricchezza è problema dell’economia mondiale [mercato mondiale]; in termini materiali, nei paesi dominanti imperialistici e rispetto alla classe capitalistica internazionale, la situazione è tale che la povertà si riscontra in maniera assoluta e crescente, soprattutto nei periodi di crisi. E ciò non avviene solo nelle zone disastrate del pianeta ma anche all’interno delle aree imperialistiche, particolarmente nelle metropoli.
In questo contesto interviene, soprattutto in termini ideologici, la dogmatica del consumo, che assume così un ruolo affatto particolare, mercantile, nel modo di produzione capitalistico. Qui, infatti, non si produce per l’uso ma per la valorizzazione, ovverosia è il valore di scambio col plusvalore che predomina sul valore d’uso. Ne discende, come si preciserà, che il cosiddetto “risparmio”, in quanto complementare al “consumo”, è un termine economicamente privo di senso. È bene caratterizzare le diverse tipologie di consumo nel capitalismo per soppesarne il significato con il passaggio ai prezzi delle merci. Il consumo finale della popolazione, costituita in massima parte da lavoratori salariati (anche se, reddito a parte, in posizione di funzionari o dirigenti) serve per la trasformazione di tutte le merci acquistate in mezzi di sussistenza necessari alla riproduzione (storica e sociale, e non solo “biologica”) della forza-lavoro. Un’altra parte del consumo è quella che ha per scopo ultimo l’investimento, ossia la valorizzazione del capitale e cioè la sua accumulazione.
In entrambi i casi si tratta di consumo produttivo (“personale” nel primo caso, “oggettivo” nel secondo) poiché è finalizzato alla riproduzione materiale e sociale della ricchezza: o attraverso la riproduzione della capacità di lavoro [forza-lavoro] delle persone, o pure di quella dei mezzi di produzione (impianti, macchinari, materie prime, ecc.). In altri termini, si tratta di una produzione che rientra ogni volta, direttamente (come mezzi di produzione, capitale costante, che non crea nuovo valore) o indirettamente (come mezzi di sussistenza tramite il filtro rappresentato dal “lavoro vivo”, capitale variabile, in quanto fonte del plusvalore, ossia dello sfruttamento dei lavoratori) nel ciclo produttivo stesso.
Come accennato, ora è chiaro come il salario, prima di essere reddito spendibile da parte dei lavoratori, sia capitale nelle casse dei padroni, e serva ai capitalisti per comprare e pagare la forza-lavoro (quella parte chiamata appunto “capitale variabile”). Per il “consumo produttivo” personale, necessario alla riproduzione della capacità di lavoro, qualsiasi atto di “risparmio” non consiste in altro che in un differimento del consumo stesso, per acquistare o riparare oggetti più duraturi o costosi, o pure per spostare lontanamente nel tempo di vita l’acquisto di oggetti necessari alla sussistenza futura (pensioni, trattamenti di quiescenza, tfr).
Invece, per il “consumo produttivo” oggettivo dei mezzi di produzione, ogni atto di “risparmio” su di essi altro non è altro che nuovo investimento (presente o futuro), ossia accumulazione di profitto (plusvalore) in nuovo capitale, in quanto autovalorizzazione del capitale preesistente. È questa l’unica possibile destinazione coerentemente funzionale della produzione, cioè reinvestimento e accumulazione di capitale. Il capitale singolo può essere insufficiente da solo per il reinvestimento, sì da doversi cumulare con altri piccoli capitali per raggiungere lo scopo dell’investimento, oppure impossibilitato a trasformarsi in nuovo capitale a causa di una crisi, assumendo così la mera apparenza del “risparmio”, ma solo da parte dei capitalisti.
È qui che interviene la rammentata considerazione – fraintesa anche dall’asinistra e dallo pseudomarxiasmo – del salario in quanto originariamente “capitale”; il salario, infatti, contraddittoriamente costituisce anzitutto un costo per la classe dei capitalisti. L’aumento del salario complessivo della classe dei lavoratori (il loro maggior potere d’acquisto) è però al contempo un maggior costo per l’intera classe dei capitalisti (diminuzione dei suoi profitti complessivi). Quello che un capitalista può guadagnare, vendendo maggiori quantità della sua merce, lo perde un altro capitalista, che deve necessariamente venderne di meno: si trasferisce soltanto la ricchezza prodotta all’interno di un sistema economico, o di un paese oppure tra paesi diversi.
La contraddizione del maggior consumo dei lavoratori non può costituire, pertanto, una soluzione per la tenuta dei profitti dei capitalisti, poiché allo stesso tempo esso rappresenta un costo. Il consumo può intervenire a favore dell’egemonia del profitto solo se è accompagnato da una nuova accumulazione con crescita della produzione e dell’occupazione, ovverosia del profitto stesso, in misura proporzionalmente maggiore del consumo salariale. A parità di condizioni, perciò, l’unico “consumo efficace” per i capitalisti è quello degli altri capitalisti agenti come tali, soggetti della medesima classe: entrambe le parti che producono plusvalore.
L’unica garanzia della possibilità di riprodurre all’infinito – e l’infinità della crescita è la peculiarità esclusiva del modo di produzione capitalistico – il capitale complessivo. La possibilità di realizzare la quota di profitti contenuta nelle merci capitalistiche prodotte sta dunque solo nella reciproca vendita delle rispettive merci, ciascuna delle quali contenga la quota di lavoro non pagato (plusvalore) dei propri lavoratori sfruttati. Marx definiva tale processo capitalistico, contraddittorio realmente in quella realtà irrazionale, “produzione per la produzione”, produzione fine a se stessa. Al di fuori dei due casi esaminati di riproduzione del sistema, in ogni altra circostanza si tratta di consumo improduttivo. La produzione a esso destinata esce definitivamente dal ciclo riproduttivo, riguarda prodotti di lusso o comunque storicamente non necessari alla sopravvivenza della società, quale che essa sia; si tratta soltanto di trasferimento della ricchezza già prodotta.
Al pari di ciò che si verifica per il consumo improduttivo, ricade nello stesso principio di trasferimento di ricchezza anche l’intervento pubblico con il cosiddetto “stato sociale”. Senonché occorre vedere a carico di chi sia codesta spesa “pubblica”. Storicamente, in generale, si sa bene che lo “stato sociale” è pagato col salario di lavoratori per altri lavoratori (sistema fiscale, tassazione e debito pubblico), mai dai profitti. La distribuzione del reddito tra salariati e padroni tende negli anni a rimanere tendenzialmente invariata; anzi, nelle più o meno lunghe fasi di crisi, è la quota salariale complessiva (per l’aumento della disoccupazione e per il sottopagamento del lavoro – la marxiana “riserva di lavoratori”) a decrescere rispetto ai profitti. Anche in altri momenti economicamente difficili pur se non critici, è sempre il lavoro a rimetterci di più e per primo.
La riflessione sul ruolo del cosiddetto “stato sociale” (“sociale” paradossalmente anche se la “società” statale è del capitale) nasce dalla circostanza che codesta attività è in apparenza pubblica. “Socialmente” è legata all’esistenza e al “benessere” dei cittadini (o, meglio, alla loro sussistenza e assistenza), poiché una socialità reale di massa non c’è. Spesso ci sono da rispettare norme e condizioni sulle politiche salariali, produttive e monetarie; tali regole sono rivolte a salvaguardare le più pericolose situazioni mondiali di miseria, in ordine però a garantire la concorrenza sul mercato mondiale da parte delle imprese operanti in zone a più onerosi costi salariali. Quest’ultimo, quindi, è il ruolo internazionale assegnato allo “stato sociale” in tutto il pianeta dal neocorporativismo mondiale, forma sempre più adeguata all’attuale fase dell’imperialismo. È un’integrazione salariale indiretta. Innanzitutto, giusto l’insegnamento marxiano, ciò va a favore del capitale variabile dei costi delle imprese, forma originaria del reddito che diviene poi salario dei lavoratori.
In effetti “stato sociale” altro non risulta essere che una metonimia per ciò che poc’anzi si è definito “salario sociale”: ossia, per il salario propriamente detto riferito all’intera classe, in termini reali e materiali. Dal momento che tutte le spese sociali dello stato borghese – come ha insegnato l’assistenzialismo dato ai “poveri”, almeno quello dal xviii secolo in poi – sono finalizzate a integrare le varie forme possibili dei costi salariali previsti per il capitale variabile (quelli diretti superiori al minimo, quelli indiretti gravanti sulla fiscalità generale e su quella specifica, e quelli differiti o futuri), quelle medesime spese per le corrispondenti componenti salariali sono sostenute dallo stato per conto del capitale.
Allora si impone la domanda: da dove vengono i soldi? La risposta a tale domanda è volutamente vaga. Senonché basta poco per verificare che, a tutt’oggi, le spese dello “stato sociale” sono a carico di tutti gli altri salariati dell’economia, come mero trasferimento: interno, dai meno disagiati ai più discriminati; o esterno, come briciole del plusvalore passato all’“aristocrazia operaia” degli stati imperialistici dai proletari dei paesi oppressi. Si è appena ricordato che non si è mai assistito a una riduzione dei profitti. Ciononostante sembra restare apparentemente valida l’idea di integrazione salariale indiretta per i più bisognosi.
È una questione molto dibattuta con i supposti keynesiani-di-sinistra, fautori di questa parte della spesa pubblica, come se si trattasse di miglioramenti salariali netti. Ma non è così. Senza l’indicazione della fonte di trasferimento entro il monte salari mondiale complessivo, e senza la denuncia più esplicita di ciò, il discorso sul cosiddetto “stato sociale” (o su altre sostituzioni fiscali) è fuorviante. Fermandosi alla funzione nazionale (o sovranazionale) dello stato, lo “scambio ineguale” ai danni dei paesi dominati e lo sfruttamento dei loro proletari, tramuta la spesa statale connessa in amplificazione della sua funzione imperialistica. Praticamente tutta l’asinistra, consapevole o no, cade in questa trappola.
7. Il mutamento di forma
da plusvalore e valore a profitto e prezzi,appena descritto, è il motivo per cui Marx spiega tale trasformazione per stadi, fasi successive. Anche i “prezzi di produzione” definiti nella prima fase, rispetto al lavoro contenuto similmente ai valori da cui provengono, sono funzioni positive del tempo di pluslavoro non pagato. Analogamente, il tasso generale di plusvalore [o di sfruttamento] è perfettamente determinabile e calcolabile univocamente. L’algoritmo necessario è semplicissimo e serve per esprimere numericamente quel tasso in funzione della quantità di pluslavoro. Ciò cancella tutte le frottole dette e scritte in merito alla presunta erroneità e insufficienza dei dati per conoscere esattamente lo sfruttamento perpetrato dalla classe capitalistica sulla classe lavoratrice.
Attraverso tale procedimento è facile rintracciare lo sfruttamento capitalistico di classe, e non quello individuale che analiticamente non interessa. È sufficiente considerare che, anche se i termini “trasformati” tendono a nasconderlo – per il tramite della “trasformazione” – anche tasso di profitto e prezzi, sono messi in relazione con le masse di mezzi di produzione e di sussistenza e direttamente, è ovvio, con le quantità date di quel medesimo pluslavoro. Solo attraverso il processo di trasformazione del valore in prezzi di produzione, perciò, è possibile vedere razionalmente il permanere del carattere di sfruttamento che da lavoro e pluslavoro, attraverso valore e plusvalore, trapassa anche in prezzi e profitto. Se c’era bisogno di fornire una motivazione di classe all’altrimenti noiosa “trasformazione” equilibristica, questa è più che sufficiente.
La prima fase, dunque, rappresenta il livello – a questo punto pure necessariamente formale – sufficiente per rintracciare lo sfruttamento anche nei prezzi di produzione. Si ricordi che le informazioni di partenza sono le stesse per entrambi i problemi, sia in termini di valore sia in termini di prezzi (ai dati di base, se ne aggiungono altri relativi alla circolazione). Quindi, ciò che a questo stadio importa è la determinazione del concetto – non necessariamente il calcolo – dei valori (grandezze e forme) delle merci capitalistiche; ciò ha anche indotto in errore molti esegeti. Qualsiasi svolgimento ulteriore dei prezzi, in altre forme via via sviluppate (prezzi di riproduzione, non concorrenziali, monopolistici, politici, ecc.) non cambia, perciò, neppure formalmente, i risultati raggiunti in questo primo stadio.
Per tali “semplicissimi” motivi, Marx circoscrive la sua esposizione al primo passaggio – “la prima trasformazione del plusvalore in profitto”, come dice lui stesso – senza far operare il rovesciamento o inversione. Le condizioni date, si ricordi bene, impongono l’assenza funzionalmente “astratta” della considerazione di mutamenti tecnici, di valore o tanto meno dovuti a crisi. Perciò non deve operare il rovesciamento dei prezzi stessi sui costi di produzione, come molti marxologi vorrebbero pretendere quasi a manifestare la “fretta” di anticipare risultati che invece sono implicitamente inscritti nel problema in se stesso. Il “concetto” che serve è già posto compiutamente a questo primo livello; dopo ci sarebbero, necessariamente, ulteriori modificazioni “aritmetiche”, come è proprio Marx ad avvertire. Ciò non inficia neppure quantitativamente, essendo diversi i contesti e le esigenze, la teoria dell’origine sociale del profitto: al contrario, anzi, la esalta.
Nella prima fase della trasformazione, dunque, la differenza sussiste ancora solo tra tassi e non tra masse. Senonché, il plusvalore nella nuova forma di profitto “rinnega” la sua origine, e il nuovo tasso (del profitto) – corrispondente ai prezzi di produzione – può così oscurare o travisare proprio l’origine sociale del plusvalore. Questa conseguenza dovrebbe chiarire l’importanza politica, e non accademica, della cosiddetta “trasformazione”. Nelle parole di Marx, è “ciò di cui il capitalista e anche l’economista, non si rendono conto”, ignorando il fondamento di valore nella sua stessa “materia” (la quantità di lavoro contenuto nelle merci), prima di poter parlare di prezzi (di produzione o di mercato).
È per questo che Marx, indipendentemente dalla fase di analisi svolta, tratta espressamente della “trasformazione” di tasso di plusvalore, plusvalore, valore rispettivamente in tasso di profitto, profitto, prezzi di produzione, come detto in quest’ordine logico preciso, al quale deve necessariamente corrispondere anche l’algoritmo formale poi sviluppato. A qualunque stadio della “trasformazione” in questione, perciò, per la determinazione del tasso di profitto e dei prezzi di produzione non occorre calcolare le grandezze di valore. Basta conservare i dati originari di partenza. È bene precisare che il “calcolo” di quelle grandezze, infatti, risponde alla regola di ripartizione basata sulla proporzionalità al tempo di lavoro.
Quello dei prezzi di produzione – che esprime la nuova forma che è nella stessa sostanza di lavoro – pone, invece, la proporzionalità al capitale complessivamente anticipato. Perciò il calcolo delle grandezze di valore conduce a un “risultato” che come tale elimina irreversibilmente tutte le informazioni necessarie per l’altra determinazione. Per tale motivo, in generale anche per le ulteriori determinazioni, occorre muoversi “in parallelo” (e non “in serie”, per usare una metafora elettrica). È da un identico insieme di dati, e non dai loro calcoli già compiuti, che è necessario partire per la determinatezza concettuale dei pesi adeguati volta a volta alla regola di ripartizione stabilita. Tutto il processo così illustrato costituisce una ragione sufficiente per sostenere che questo mutamento di forma per Marx stesso non è inessenziale, accidentale o sbagliato.
Dire che il “problema non esiste” – come i “critici critici” ritengono di dover sostenere – equivale a rincorrere la chimera di una modificazione continua nel tempo delle condizioni della produzione che sono invece date (o quello dell’esistenza della crisi, che è reale ma che in prima istanza non va considerata). Proprio dall’invarianza dei dati di partenza discendono i differenti “prezzi” dei successivi stadi dell’iterazione del calcolo; se le condizioni variassero – come realmente variano – la devianza dei prezzi dai valori sarebbe semmai ancora maggiore, ma la causa prima della loro differenza affonda le proprie radici nella datità iniziale. Precisamente supponendo tale invarianza si formano prezzi, anche come grandezze, diversi dai valori, che sono essi stessi “ideali”, come Marx avverte, e non “reali”. Il problema marxiano esiste, proprio in quanto inevitabile determinazione di una forma (prezzo) mutata rispetto a quella logicamente precedente (valore). Quello che “non esiste” è invece il vuoto problema di bawerk-bortkevičiano cui viceversa hanno acceduto inconsapevolmente anche, al polo opposto, i marxologi di tutto il mondo.
La spartizione del plusvalore tra i molti capitalisti segue la separazione di classe tra proprietari e salariati; è perciò da Marx un concetto posto e, in quanto tale, presupposto ai prezzi, quale spiegazione scientifica della specificità dello sfruttamento capitalistico. Questo, infatti, deve precedere logicamente la ricerca di qualunque particolare forma di prezzo, modificazione dei costi, mutamento tecnologico, vendibilità (valore di mercato) o crisi. Il significato politico teorico – e logico formale a un tempo – di questa “trasformazione” non patisce variazioni a séguito di quei successivi ulteriori (eventuali, ma storicamente necessari) movimenti.
Le teorie dominanti si articolano sulla ricerca di “prezzi di equilibrio”, ad hoc, puramente empiriche, rispondenti a casi particolari e mai generali, non rispondenti ad alcun realismo, e incapaci di rappresentare il complessivo operare effettivo del modo di produzione capitalistico, e perciò crollano. Viceversa la teoria di Marx – qui in particolare, se ben interpretata, la cosiddetta “trasformazione” del III libro del Capitale – non ha un tale obiettivo “contabile”.
Senza la teoria del valore e del plusvalore, nell’accezione marxiana, tutti gli economisti restano dominati dall’ideologia borghese. La finalità peculiare del sistema capitalistico – merce, valore e plusvalore e l’“infinità” della sua accumulazione – non viene distinta in nulla dagli economisti rispetto a quella delle epoche precedenti, tanto che, anche nell’asinistra, si sente ripetere spesso che il fine è ancòra e sempre il soddisfacimento dei bisogni e il consumo (per i manuali borghesi è sovranità-del-consumatore). La differenza specifica del processo capitalistico di produzione, rispetto a quello delle società precedenti, è da costoro annullato facendo semplicemente astrazione da tutte tali differenze e ignorando le contraddizioni del capitalismo stesso.
8. Lo sfruttamento capitalistico
ha la sua unica coerente e corretta spiegazione scientifica – e non una romantica accusa moralistica di “ingiustizia” – nella “trasformazione”, dal tasso di plusvalore in tasso di profitto, per giungere fino a quella del valore nei prezzi di produzione (riproduzione e circolazione). La teoria di Marx, tutta intera e nello specifico la parte riferita al “problema” in esame, deve essere letta e può essere pienamente compresa solo in funzione dell’azione politica che la determina e la muove. Molti “marxisti” potranno dire che tutto questo è noto. E dovrebbe esserlo.
Ma allora c’è da chiedersi perché mai proprio essi si siano fatti attrarre dall’economia borghese con i suoi insulsi equilibrismi su equazioncelle e calcoletti. Un siffatto impianto formale risponde, sì, alle esigenze di quanti abbiano come loro obiettivo quello di affossare Marx, la sua teoria del valore e del plusvalore e, conseguentemente, anche il “problema della trasformazione”. Ma chi vuole tener fermo al marxismo e al complesso delle sue precise condizioni di svolgimento teorico e pratico, fino ai vari sistemi di prezzi, per spiegare lo sfruttamento capitalistico, non può trovare neppure un singolo suo errore di calcolo, poiché simili errori “emergono” soltanto in ossequio alle ipotesi arbitrarie e inadeguate dell’impostazione dominante. Ne va del “comunismo”.
Perciò la tormentosa obiezione secondo cui i “conti non tornano” si affida solo alla maniera – sbagliata – in cui tali “conti” sono impostati (quelli che derivano dal formalismo borghese). Essi, infatti, sono espressi sul mancato riconoscimento dell’unicità del lavoro come fonte del valore (quantità di lavoro socialmente erogate nella produzione), prima, e della composizione del salario materiale come data (volume dei mezzi di sussistenza storicamente necessari), poi. Si è visto che qualora entrambe codeste condizioni siano rigorosamente rispettate, non c’è calcolo marxiano che faccia una piega [comprese definizione del tasso di profitto, doppie somme di plusvalore e profitto o di valori e prezzi, circolarità reale della riproduzione sociale, iterazione del calcolo, stadi successivi dell’analisi, ecc.].Non c’è dunque nulla di errato e anomalo in tutto ciò, ma solo l’ordinaria valorizzazione, diversamente ripartita tra la classe dominante. Nessuno può più svilire il cosiddetto “problema della trasformazione”, ignorandone l’esistenza o riducendolo a calcolo formalistico o rabbassandolo a mero dogma, se non in forza della avversa ideologia dominante. Ciò si è visto proprio attraverso la maniera in cui i “marxologi” hanno subìto l’accettazione del dibattito accademico, eventualmente a contrario, si è detto, imposto da Böhm Bawerk e Bortkevič al triste “problema della trasformazione”. In simile attitudine, in realtà, non è possibile rintracciare alcun significato, pratico e scientifico a un tempo, “politico” nel senso alto della lotta di classe. Finché non si fuoriesce da quel circolo vizioso è inutile dibattere sulla loro sterile erudita “trasformazione”. “Designare col nome di fraternità universale lo sfruttamento giunto al suo stadio internazionale, è un’idea che poteva avere origine solo in seno alla borghesia” – concludeva Marx, discorrendo del libero scambio.
Il riferimento sistematico alla teoria delle classi e alla lotta di classe indica dialetticamente che ogni processo di trasformazione rivoluzionaria supera negandoli entrambi i termini che imprimono il movimento al processo in esame. Non si vede quale altra spiegazione scientifica, diversa dalla produzione di plusvalore, potrebbe darsi alla proposizione secondo cui la proprietà privata di classe come classe è la principale forma di negazione, conservazione e superamento, fin qui manifestatasi nella storia, della proprietà privata individuale. Ecco perché la “trasformazione” – questa trasformazione del tasso di plusvalore in tasso di profitto e del valore in prezzo di produzione – assume significato politico e non formale di spiegazione scientifica dello sfruttamento.
Quanto condiviso all’inizio circa la necessità di ritrovare un’elaborazione teorica elevata è stato qui confermato dal nesso dello studio, apparentemente astratto, della “trasformazione” unitamente alla dimostrazione concretissima dello sfruttamento. Peraltro non è una connessione casuale o secondaria per sostenere il ruolo non accademicamente vuoto della teoria a fondamento “meditato per l’azione”. La altrimenti logora diatriba sul “problema della trasformazione”, così riletta “politicamente”, rappresenta in realtà un nodo teorico marxiano fondamentale. Tale connessione ha al suo centro, non a caso, la forza-lavoro come merce, la sua compravendita e soprattutto il suo uso capitalistico.
Sembra un paradosso dover richiedere ad alta voce il “diritto a essere sfruttati”: ovvero, per i lavoratori, anzitutto il diritto a vendere adeguatamente al suo valore la propria forza-lavoro. Basti immaginare che cosa potrebbe significare per i padroni: dover pagare tutti i costi effettivi (presenti e futuri, fiscali e contributivi) inerenti la loro attività; non poter fruire di privilegi su tributi e interessi possibili, complementarmente alla riduzione dei salari; essere invece obbligati a rispettare le norme giuridiche vigenti (veridicità dei bilanci, normativa finanziaria su acquisizioni, investimenti, gestioni borsistiche, ecc.); dover evitare provvedimenti straordinari di copertura finanziaria (una tantum, finte dismissioni di attività da parte dell’amministrazione pubblica coperte con partite di giro “creative”, e via truccando), ecc. ecc.
Già questo sarebbe “eversivo”, se non rivoluzionario, per il sistema. Figurarsi che reazione si susciterebbe se i lavoratori entrassero nel merito dell’uso capitalistico della loro forza-lavoro, nel cui merito i padroni da sempre dicono “vietato l’ingresso agli estranei”. E si tratta soltanto di una questione interna al capitalismo, come il “mercato del lavoro”: con rivendicazioni “riformiste”, a proposito della monetizzazione e della normativa dello scambio, o di impronta “rivoluzionaria” circa le modalità dell’uso. Ebbene tutti questi e altri risvolti – economici, giuridici, istituzionali, politici in generale – potrebbero derivare esclusivamente da una decisa presa di posizione sul corretto significato della forza-lavoro come merce.
Dunque, la rivendicazione del valore della forza-lavoro rappresenta una chiave di volta per i lavoratori salariati, come base elementare di un “programma” di lotta, anzitutto sindacale, che parta dalla loro posizione di classe antagonistica nella società del capitale (ciò che Engels e Marx, fin dal Manifesto del partito comunista, chiamavano “programma minimo”, in fasi che non presentavano le condizioni per una presa rivoluzionaria di potere, e tanto meno per costruire una “transizione” di tipo socialista). La vendita della forza-lavoro merce in quanto tale è una questione sindacale, non è immediatamente politica e guarda unicamente alla posizione sociale dei lavoratori, evocando però i rapporti di proprietà dei lavoratori salariati.
Epperò in quest’ottica anche il programma di classe della strategia sindacale non può non fondarsi sulle condizioni oggettive di lavoro che si riferiscono alla generalità dei rapporti col capitale. Affinché il possessore della forza-lavoro la venda come merce, egli deve poterne disporre, quindi essere libero proprietario della propria capacità di lavoro, della propria persona. Il processo sociale, la specificità della composizione di classe della formazione sociale capitalistica, la coscienza di ciò, si comprendono a partire dalla considerazione che il lavoratore salariato deve vendere la sua capacità di lavoro ad altri, alienarla per un salario. Ma per poter fare ciò, il lavoratore deve mettere pro tempore – come già aveva osservato Hegel prima di Marx – la propria volontà a disposizione della classe capitalistica, la quale può così sfruttare la forza-lavoro altrui: e se il “valore” ha la potenzialità di mostrare tutto ciò, il “prezzo” lo nasconde.
Il carattere dirompente di tale minima posizione implica, tuttavia, una consapevolezza collettiva, una chiara coscienza di classe. È proprio tale genere di coscienza che tutta la borghesia vuole continuamente annullare. Il rabbassamento dell’attività lavorativa (uso) e della compravendita della forza-lavoro (scambio) a problemi individuali, che cioè riguardano ogni singolo lavoratore, costituisce la premessa metodologica per svuotare il rapporto tra lavoro e capitale di qualsiasi carattere di classe. Nell’ideologia la dimensione del rapporto di classe è fatta scomparire, affinché sia annullata la coscienza della classe proletaria, in maniera che rimanga operante, sotto le mentite spoglie della “libertà”, solo quella borghese.
Nella pratica capitalistica, storica e quotidiana, quell’ideologia serve appunto per sostenere il presunto “interesse comune” di lavoro e capitale. Tutto ciò rimanda alla moderna riedizione del corporativismo [il neocorporativismo] per sottomettere le posizioni dei lavoratori al comando del capitale e ottenere il pieno controllo del proletariato da parte dello stato della borghesia, coartandone pure il “consenso”. Il consenso così estorto ai lavoratori per la politica (economica, ma non solo) padronale ha raggiunto l’obiettivo cercato: disarmare il proletariato, demonizzare la conflittualità, cercare l’armonia e la pace socialein un’ottica sempre più sottratta alla contrapposizione delle classi e, quindi, alla lotta di classe dei lavoratori.
Ciò che in realtà è “neocorporativismo” è proposto con nomi diversi e suadenti: “concertazione” (confindustria e sindacati), “triangolazione” (quei due stessi più lo stato), “consociativismo” (per dare l’idea del perseguimento di intenti sociali condivisi), ecc. Nonostante gli aspetti prevalentemente “sindacali”, almeno in quanto riferibili al “lavoro”, gli elementi qualificanti sono sempre stati di carattere politico. Nel secondo dopoguerra le tendenze ideologiche democraticistiche del neocorporativismo hanno largamente prevalso in tutti i paesi imperialistici usciti dal conflitto bellico, pretendendo anche di assumere un “colore di sinistra”.
La questione è presentata dai sicofanti della borghesia in maniera del tutto differente, come se effettivamente tra lavoratori e capitalisti (e stato) possa esserci identità di punti di vista. Perfino una qualsiasi “dottrina” economica tradizionale sostiene il contrario, giacché quanto meno sul mero piano distributivo pone l’aumento della quota di profitto in opposizione a quella del salario. La teoria marxiana che lega trasformazione a sfruttamento, al contrario, parte dalla dimostrazione analitica, prima economica che politica, dell’antagonismo di classe. Ed è quanto serve per risanare l’acqua e il bambino.