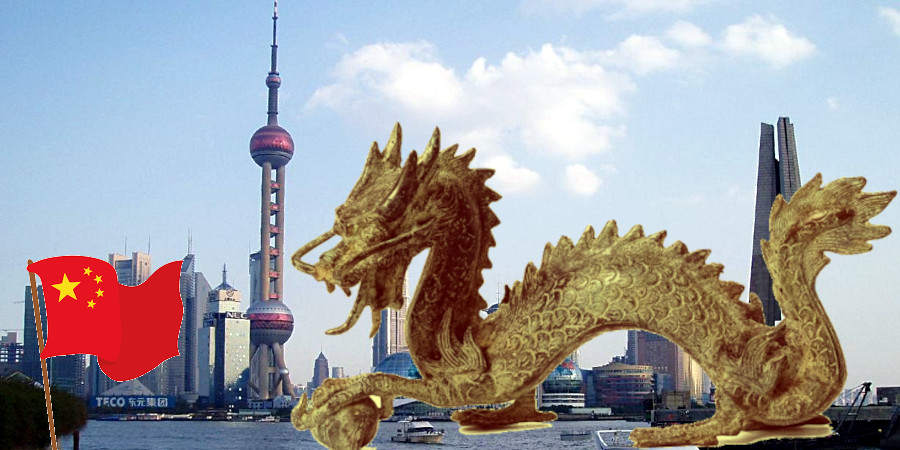Giorgio Gattei (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
“Il migliore,
il peggiore”
(G. Tomolo)
1. Il comunismo all’ordine del giorno
Per comprendere la storia del Novecento come una unità logica (e non soltanto cronologica) dotata di senso, può essere comodo partire dall’idea di successo ch’essa sia interamente compresa nella esperienza del comunismo realizzato: essendo «certo che l’era 1917-1991 va vista come unità» (Nolte, p. 66), ne segue che «la storia del secolo breve, così come definito in questo libro, coincide virtualmente con la durata dello Stato nato dalla Rivoluzione d’Ottobre» (Hobsbawm, p. 72). Sarebbe questa la sua principale differenza da quel “lungo Ottocento” che aveva preso il via dal 1789 e che del comunismo aveva invece conosciuto soltanto la contrapposizione sul piano delle idee, a meno delle brevi insurrezioni parigine fallite nel 1848 e nel 1871.
Tuttavia una simile datazione occulta la causa scatenante della rivoluzione d’Ottobre, che è una rivoluzione che non nasce “a freddo” ma come conseguenza del trauma della Grande Guerra (1914-1918) nella quale le borghesie ottocentesche europee si sono volontariamente “suicidate”: attraverso circostanze concatenate, di cui però gli storici non sono ancora venuti bene a capo, i diversi capitalismi nazionali si sono ritrovati nell’agosto 1914 l’un contro l’altro armati, sacrificando fino al 1918 sui campi di battaglia le masse contadine e proletarie mobilitate nella prima “guerra di materiali”, quasi che fossero appena “carne da cannone”. È stata quindi la Grande Guerra, piuttosto che la rivoluzione d’Ottobre, ad introdurre al Novecento, questo secolo qualitativamente ben diverso dal precedente per la perdita della sicurezza di sé di cui invece l’Ottocento si era orgogliosamente, ma pure presuntuosamente, nutrito. La svolta è stato ben colta da Antonio Gramsci in un corrispondenza giornalistica del 1916: «la nostra civiltà, quella in mezzo alla quale abbiamo vissuto sino all’anno di grazia 1914 e che derivava in retta linea dalla rivoluzione francese, è stata fatalmente condannata a morte dalla conflagrazione europea, che è appunto un avvenimento in tutto corrispondente a quello dell’89. Là si posero le basi del sistema borghese, qui oggi si lavora a distruggerlo… Tutti i valori umani, non meno di tutti gli istituti morali e giuridici del vecchio mondo, sono stati capovolti, scardinati, irreparabilmente compromessi. È un nuovo ordinamento, una nuova fondazione del vivere civile, quella che urge dichiarare e attuare… Prepariamoci ad assicurarne l’avvento» (Gramsci, pp. 21-22).
Tuttavia la Grande Guerra avrebbe anche potuto concludersi con una pace di sola redistribuzione imperialistica (alla maniera delle guerre napoleoniche) se Lenin non avesse saputo cogliere il valore di sofferenza di tanta umanità maciullata nell’”inutile strage” lanciando la parola d’ordine rivoluzionaria della trasformazione della guerra imperialistica in guerra civile “per porre fine a tutte le guerre”. È stata questa parola d’ordine che ha cambiato il corso delle cose: fattasi corpo e sangue nella vittoriosa rivoluzione d’Ottobre e poi ripetuta ancora una volta nel corpo e nel sangue dei diversi tentativi falliti di “fare come in Russia” nell’Europa post-bellica, essa ha introdotto nella storia il fattore straordinario della guerra di classe, quella guerra civile ideologica che (a detta di Cari Schmitt nella Teoria del partigiano) è la sola «guerra vera perché si fonda sulla inimicizia assoluta. Tutto il resto è gioco convenzionale… Essa trova la sua giustificazione e il suo senso proprio in questa volontà di arrivare alle estreme conseguenze. La sola questione che resta è dunque questa: esiste un nemico assoluto, e chi è in concreto? Per Lenin la risposta era immediata, e la sua superiorità su tutti gli altri socialisti e marxisti deriva proprio dall’aver preso sul serio il concetto di inimicizia assoluta. 11 suo nemico assoluto, vero, era I avversario di classe, il borghese, il capitalista occidentale e il di lui ordine sociale in ogni paese ove fosse al potere» (Schmitt, p. 40). E ancora: «nel 1914 popoli e governi europei entrarono barcollando nella prima Guerra Mondiale senza avere una inimicizia reale. L’inimicizia reale sorse solamente dalla guerra stessa, cominciata come una guerra convenzionale interstatuale sulla base del diritto internazionale europeo e conclusa come guerra civile mondiale dell’inimicizia rivoluzionaria di classe» (idem, pp. 75-76).
Il successo della rivoluzione leninista in Russia, a dispetto dell’intervento militare concentrico degli Alleati (1918-1920), doveva poi aggiungere un ulteriore elemento di solidità alla prospettiva del comunismo “all’ordine del giorno”, perché questa volta, a differenza delle convulsioni rivoluzionarie dell’ottocento, la sfida avrebbe avuto la sponda di una intero Stato – l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – che avrebbe sfidato il capitalismo sul suo stesso terreno di supremazia, ossia il governo materiale dell’economia. Nell’Unione Sovietica si sarebbe infatti attuato un esperimento storico “totalmente altro” dal capitalismo, fondato sulla proprietà pubblica, invece che privata, dei mezzi di produzione, sul direzione pianificata in sostituzione dell’anarchia del mercato e sulla dittatura del proletariato al posto della “tirannide borghese”. Era questo valore di frattura traumatica concreta rispetto a tutto il decorso storico precedente che Ernst Nolte ha voluto sottolineare, rispetto a certa «storiografia del dettaglio» intesa a ridurre la rivoluzione sovietica a fenomeno regionale al quale andrebbe attribuito significato soltanto per la grandezza e la forza del paese, come «un fenomeno del tutto nuovo nella storia universale: era la prima vittoria duratura dell’ideologia più recente e però dalle radici lontanissime, quella della “pace”, della “liberazione”, della globalizzazione, in una parola dell’universalismo militante o della Sinistra eterna» (Nolte, p. 52). Era rispetto a questa “Sinistra eterna” che il capitalismo avrebbe potuto battersi soltanto in una “lotta a morte”.
2. La controrivoluzione anti-comunista
La grandezza della sfida al capitalismo autorizzava l’intensità della risposta: all’inimicizia assoluta del comunismo si sarebbe dovuto opporre l’inimicizia, altrettanto assoluta, del fascismo, questo “regime reazionario di massa” necessario a stroncare l’eccessivo protagonismo politico dei proletariato di sinistra post-bellico. Ma quale il prezzo da pagare? Pur di difendere almeno l’economia di mercato il capitalismo avrebbe accettato, dove necessario, di rinunciare alla democrazia politica formale per affidarsi alla guida di un Capo assoluto, comunque declinato (duce, fürher o caudillo). A detta di Ernst Nolte, «il fascismo fu dunque, nell’Europa extra-russa, il fenomeno politico di maggior novità, tanto diverso, nonostante un’innegabile affinità, dal nazionalismo e dall’antisocialismo d’anteguerra, quanto il suo principale nemico, il comunismo della Terza Internazionale, si distingueva, nonostante l’evidente parentela, dal socialismo d’anteguerra. Fu così che nell’Europa successiva alla prima guerra mondiale si fronteggiarono due partiti della guerra civile che prevedevano nel loro programma l’annientamento del nemico e dei quali l’uno era organizzato in Stato dal 1917, mentre l’altro trovò la sua prima espressione statale soli nel 1922 con la marcia su Roma e la presa di potere del partito nazionale fascista sotto il suo duce Benito Mussolini» (Nolte, p. 57).
Si sa che l’esempio fece scuola, tanto che a partire dal 1924 si poteva già parlare di una stabilizzazione capitalistica europea, parallela alla stabilizzazione sovietica seguita agli anni durissimi del “comunismo di guerra”. Ovviamente il focolaio dell’insurrezione bolscevica non era stato spento, però era già stato contenuto entro un rigido cordone sanitario di stati fascisti o para-fascisti che andavano dalla Polonia all’Ungheria e alla Romania. Ridotto così il comunismo ad “un solo paese’’, una lungimirante e paziente azione di logoramento (non ancora chiamata “guerra fredda”) l’avrebbe alla lunga eliminato dal Novecento e dalla storia.
Purtroppo non ci fu tutto il tempo che sarebbe stato necessario. Lo scoppio della Grande Crisi (1929- 1933) venne a resuscitare i peggiori fantasmi di ripresa della rivoluzione comunista. Come le democrazie borghesi si erano politicamente “suicidate” nel 1914, adesso era l’anarchia del mercato a fallire clamorosamente, quasi a mostrare che al capitalismo non restava futuro. Nel pieno della crisi l’esperimento comunista ridiventava l’esempio, contrapponendo ad «un’America ricca, ma impoverita dall’incapacità di controllare l’economia, una Unione Sovietica povera, che però organizzava il progresso della produzione con uno sforzo di volontà e ragione» (Furet, p. 179). Ancora una volta bisognava correre ai ripari, ma questa volta come? Non certamente con la soluzione fascista che, se aveva risolto le difficoltà politiche imponendo la dittatura, aveva però lasciato in piedi quella economia liberista ora al collasso. A fronte deH’incombere di una disoccupazione di massa, che avrebbe potuto riarmare ideologicamente le masse proletarie nella prospettiva degli “indomani che cantano”, si richiedeva un rimedio ben più forte che salvasse il capitalismo dai movimenti convulsivi del suo stesso mercato.
Questo rimedio è stato il nazismo, una esagerazione del fascismo che portava all’estremo la contraddizione, interna al capitalismo, del mercato e della democrazia sopprimendoli equamente (si fa naturalmente per dire…) entrambi. Infatti, nella logica del nazismo, il capitalismo poteva essere salvato dalla propria auto-distruzione solo sacrificando, insieme alla democrazia borghese sostituita dalla dittatura del partito unico (come già aveva fatto il fascismo), pure la libertà del mercato, da rimpiazzarsi con i “piani quinquennali” coercitivi dello Stato nazional-socialista. Ma “senza democrazia formale” e “senza economia di mercato” non erano misure che s’assomigliavano agli strumenti utilizzati dal comunismo? Solo all’apparenza, perché adesso erano strumenti di cui si serviva cinicamente lo stesso “grande capitale” pur di trovare soluzione alla propria crisi storica di sovrapproduzione. Infatti l’identità totalitaria del comando politico ed economico sia nel comunismo che nel nazismo non deve far dimenticare la ben diversa “natura di classe” dei due regimi, che in Russia era proletaria, mentre rimaneva capitalistica in Germania. La differenza era così radicale da connotare all’incontrario le rispettive forme di mobilitazione delle masse, che a Mosca erano agitate dalla bandiera rossa dell’internazionalismo operaio, mentre a Berlino marciavano dietro la svastica del nazionalismo razzista, tal ché ben differente ne risultò il rispettivo “nemico del popolo” che fu “il borghese per Lenin, l’ebreo per Hitler” (F. Furet). La differenza non è di poco conto: il Gulag non potrà mai essere equiparabile ai Lager e l’olocausto è nazista soltanto.
Se a tanto prezzo il capitalismo tedesco evitò la convulsione rivoluzionaria, l’esasperazione geopolitica del nazismo doveva però provocare un clamoroso riposizionamento degli schieramenti fino allora in conflitto. Questo riposizionamento non è però tanto rappresentato dal “patto scellerato” realizzato nel 1939 tra nazismo e comunismo nel nome di una presunta comune “identità totalitaria” (come piace tanto al revisionismo storico), quanto piuttosto dalla sorprendente unità antifascista di pochi anni successiva, quando cioè la nuova guerra di rivincita scatenata da Hitler contro le democrazie imperialistiche di Francia ed Inghilterra (1939-1941) venne ad investire pure l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti, così che da europea si fece mondiale (1941-1945). Si videro allora le democrazie liberali, in un’alleanza veramente “contro-natura di classe”, schierarsi al fianco del comunismo, addirittura stalinista, pur di schiacciare la mostruosità nazi-fascista che le minacciava. Il fatto è che le mire imperialistiche del “Terzo Reich millenario”, alleato (questa volta sì secondo natura) al fascismo giapponese, avevano preso a muoversi nella logica di una “guerra di redistribuzione” che avrebbe voluto escludere l’Inghilterra dal continente europeo e gli Stati Uniti dall’area del Pacifico. Ciò non era ammissibile né per Washington né per Londra, i cui governi capitalistici, ammettendo il fallimento della strategia di contenimento del comunismo a mezzo dei “fascismi prezzolati”, si riposizionarono velocemente a fianco della Russia aggredita come ai tempi della Grande Guerra e quasi che la rivoluzione sovietica non fosse mai avvenuta.
3. La sfida del Warfare
Era però evidente che l’unità antifascista era del tutto strumentale. Finita la “grande guerra antifascista” l’inimicizia assoluta tra capitalismo e comunismo doveva infatti riemergere violentemente separando con una cortina di ferro (efficace slogan nazista furbescamente recuperato da Churchill) il cosiddetto “mondo libero”, passato sotto la guida degli Stati Uniti per l’esaurimento economico e politico della Gran Bretagna, dal “blocco socialista” che, sull’onda della vittoria militare, era straripato fino al centro d’Europa ma che dal 1949 comprendeva pure la Cina, ponendo così termine all’isolamento del comunismo “in un solo paese”.
Dal canto loro gli Stati Uniti erano riusciti ad uscire dalla Grande Depressione soltanto con l’entrata in guerra. Nella sua Teoria generale John Maynard Keynes l’aveva previsto: quando la domanda dei privati è insufficiente ad assorbire l’intera offerta (come era stato dal 1929 in poi) solo una spesa statale adeguata può risolvere la crisi di sovrapproduzione. Ma siccome l’opinione pubblica benpensante è costitutivamente contraria alla spesa pubblica (specialmente se impiegata “a far buche per terra”, com’egli aveva paradossalmente suggerito), è giocoforza utilizzarne l’unica variante che non trova opposizione, ossia la spesa militare verso la quale, nel nome della sacrosanta salvezza della patria, nessuno può mai dirsi contrario. Infatti – scriveva – «la costruzione di piramidi, i terremoti, perfino le guerre possono servire ad accrescere la ricchezza, se l’educazione dei nostri governanti secondo i principi dell’economia classica impedisce che si compia qualcosa di meglio» (Keynes, p. 114). Gli Stati Uniti si erano convertiti tardivamente alla spesa bellica, trascinativi dai guerrafondai giapponesi, ma poi se ne erano trovati così bene, sia in termini di crescita del reddito che di occupazione (ma si ricordi che il territorio americano non fu mai campo di battaglia), che quando la guerra mondiale finì non videro altra soluzione per mantenere la prosperità guadagnata che riprenderla al più presto. Ma questa volta, a scanso di ricadute depressive, avrebbe dovuto essere una guerra permanente. Certo, ma come organizzare una guerra “per sempre”?
Non si sa chi abbia avuto l’idea (se mai qualcuno l’ha avuta o non è stata invece soltanto la forza delle cose…), ma la soluzione necessaria alla bisogna è risuonata nel 1949 nelle pagine del romanzo visionario 1984 di George Orwell, dove s’immaginava, in un mondo più vecchio di trent’anni, una Oceania governata dal Grande Fratello in continuo conflitto con Eurasia ed Estasia perché la pace veniva sempre rimandata. Il fatto è che in Oceania «la guerra è pace» o, per meglio dire, guadagno: per «mantenere in moto le ruote dell’industria senza tuttavia che si accrescesse la reale ricchezza del mondo, i beni dovevano essere prodotti, ma non dovevano essere distribuiti. Ed in pratica, l’unico modo per raggiungere quel risultato era di mantenersi perpetuamente in guerra. L’atto essenziale della guerra non consiste tanto nella distruzione di vite umane quanto nella distruzione dei prodotti del lavoro umano… Quando poi le armi per la guerra non vengono propriamente distrutte le une dalle altre, la produzione delle stesse costituisce anch’essa un modo assai conveniente di spendere l’energia senza produrre nulla che possa essere consumato… Né importa che la guerra ci sia realmente, e dal momento che non è possibile. per nessuna delle parti, una vittoria decisiva, non importa nemmeno se la guerra va bene o va male. La sola cosa indispensabile è che esista tale stato di guerra» (Orwell, pp. 218-219). «Allorché la guerra diventa letteralmente ininterrotta, cessa nel contempo di essere pericolosa… Ma sebbene irreale, non per questo è destituita di significato. Sfrutta in modo totale le eccedenze dei beni di consumo e aiuta, nel contempo, a conservare quella particolare atmosfera mentale che si richiede a una società organizzata gerarchicamente. La guerra, come si vede, non è altro che un affare di politica interna» (idem, pp. 224-226).
Questa era la soluzione. La spesa militare americana postbellica, che aveva toccato il minimo nel 1947, prese poi ad salire sull’onda della invenzione della guerra fredda, una furbesca maniera politica per essere continuamente in guerra senza mai trapassare alle vie di fatto (almeno tra i due grandi “blocchi” perché lungo le zone del confine asiatico non sono mancate sanguinose “guerre locali”, come in Corea dal 1950 al 1953 con risultato di parità, poi in Vietnam al 1965 al 1975 con sconfitta americana e infine in Afghanistan dai 1979 al 1987 con sconfitta sovietica). Più oltre non era possibile andare per la “mutua distruzione assicurata” dal possesso reciproco dell’arma nucleare che alimentava una frenetica corsa agli armamenti a pro’ di quel “complesso militare-industriale” che Eisenhower doveva denunciare pubblicamente nel 1953. Ma c’era poco da fare: il capitalismo aveva prodotto il suo Warfare State (lo stato del “guerr-essere”) dove «finalmente alla domanda: Per che cosa lo stato potrebbe spendere abbastanza per impedire al sistema di affondare nel pantano della depressione?, il capitalismo monopolistico aveva apparentemente trovato la risposta: Per armamenti, per più armamenti, per sempre più armamenti» (Baran e Sweezy, p. 179).
4. L’azzardo del Welfare
C’era però anche dell’altro. Sotto la nuova direzione americana del “mondo libero” sarebbe cambiata la natura stessa della sfida da portare al comunismo. Abbandonate le soluzioni reazionarie, care agli inglesi, dimostratesi controproducenti, all’ombra dell”’equilibrio del terrore nucleare” il capitalismo avrebbe preso a misurarsi in una competizione pacifica con l’avversario a colpi di “più mercato” – e alla lunga avrebbe vinto chi avesse guadagnato più consenso d’opinione pubblica distribuendo meglio le merci ai consumatori.
Gli Stati Uniti partivano avvantaggiati, essendo già approdati alla “produzione di massa” consentita dall’introduzione rivoluzionaria della catena di montaggio e dalla sostituzione dei vecchi operai di mestiere, ancora dotati di forte specializzazione ed orgoglio professionale del loro produrre, con operai di linea “senza qualità”, perché forza-lavoro generica e astratta, che trovavano la loro unica motivazione comportamentale nella remunerazione salariale necessaria per accedere alla novità della società dei consumi opulenti (come allora si chiamavano). Il meccanismo, che prese ad essere esportato fuori dagli Stati Uniti a partire dagli anni ‘50, funzionava più o meno così: nelle fabbriche fordiste l’accrescimento della produttività dava luogo ad una offerta crescente di merci che trovava inizialmente corrispettivo in una spesa pubblica keynesiana che assicurava il raggiungimento del pieno impiego. Allontanato il ricatto della disoccupazione, i lavoratori potevano irrigidire le loro rivendicazioni salariali, rispetto alle quali la controparte poteva opporsi a fatica (siccome la catena di montaggio operava in continuo, i lavoratori non potevano mancare e quindi bisognava “chiudere” con loro a pena della “fermata” della produzione). Da qui lo spostamento progressivo del potere contrattuale verso il lavoro con l’effetto di una politica di “alti salari”, sia diretti che differiti, che accresceva la domanda dei privati stimolando ulteriormente l’offerta in un inedito “circolo virtuoso” deH’economia.
È stato grazie a questo formidabile “compromesso fordista-keynesiano” che è scaturita la combinazione vincente del Welfare State (lo stato del ben-essere): una combinazione di produzione di massa con consumi, sia pubblici che privati, altrettanto di massa cui era affidato il compito di mostrare tutta la superiorità dell’inedito “neo-capitalismo” rispetto alla vecchiezza del comunismo realizzato. Infatti a che pro attendere un ipotetico “paradiso dei lavoratori” quando erano già disponibili le meraviglie della “cuccagna dei consumatori”?
La politica economica del Welfare aveva però un costo che si scatenò nel corso degli anni ‘70. Il mantenimento, a colpi di spesa pubblica, della piena occupazione non avrebbe prodotto una avanzata delle rivendicazioni retributive tale da minacciare le compatibilità d’equilibrio del sistema? La crescita inarrestabile dei salari non avrebbe finito per schiacciare il profitto? Ovviamente sì. E allora, per risollevarne le sorti, si è giocata la carta della rincorsa inflazionistica dei prezzi, pur di recuperare sul terreno del salario reale (il potere d’acquisto effettivo dei lavoratori) quanto si era costretti a cedere in termini di salario monetario. È stato così che. pur di resistere nella grande partita del Novecento, il capitalismo “affluente” ha sopportato la “croce deH’inflazione’’ dapprima strisciante e poi addirittura a due cifre. Tanto era il prezzo da pagare, ma solo fino al termine del comunismo e non più oltre.
5. La caduta del comunismo realizzato
Il crollo dell’Unione Sovietica tra 1989 e 1991 resta a tutt’oggi «uno dei grandi misteri dell’economia politica» (Krugman, p. 16). Come mai è accaduto che l’esperienza storica concreta della “dittatura del proletariato’’ è potuta scomparire dalla scena storica senza un lamento? Si sa che a monte c’è stata la bruciante sconfitta dell’Afghanistan, il Vietnam dei sovietici, però la fuga dal Vietnam non aveva portato alla fine ingloriosa dell’imperialismo americano. Quindi ci deve essere dell’altro. E quest’altro può essere ritrovato nella crescente delusione verso l’economia di piano da parte dei consumatori sovietici, che alla fine ha lasciato il comunismo senza più difensori.
Si può dire che quella delusione sia stata conseguenza alla lunga della scelta della industrializzazione forzata, introdotta da Stalin nel 1928, che aveva imposto lo sviluppo accelerato dell’industria pesante a scapito della produzione dei beni di consumo (l’industria leggera). Al momento la scelta era stata obbligata ed essa era ben servita all’Unione Sovietica per reggere, pochi anni dopo, all’urto della macchina militare nazista e poi in seguito per competere con successo nella “corsa agli armamenti” con l’imperialismo americano. Quando però si è passati alla “coesistenza pacifica”, ad un occidente capitalistico ormai lanciato nella “corsa al consumismo” assicurato dal Welfare State, il “blocco sovietico” avrebbe dovuto rispondere di pari moneta, ponendo così fine alla “supremazia dell’acciaio” (Stalin non vuol forse dire acciaio?) per aprire la pianificazione anche alla produzione dei beni di consumo. Va detto che Malenkov nel 1955 e poi anche Kruscev nel 1964 si erano provati ad invertire la tendenza, ma erano stati subito fermati e destituiti. Il fatto è che si erano costituiti tali “interessi pesanti” dentro le nomenklature di partito e di piano da non consentire alcun decollo di una industria leggera di massa. Negli anni di Breznev l’economia sovietica era poi precipitata in un ristagno produttivo tale per cui occorrevano sempre più beni capitali per produrre un equivalente ammontare di beni di consumo. E siccome nel contempo aveva preso a calare il saggio di crescita degli investimenti, la scarsità dell’offerta che ne conseguiva, che in un’economia di mercato avrebbe preso l’aspetto dell’aumento dei prezzi, nell’economia pianificata si manifestava sotto la forma odiosa degli scaffali dei negozi desolatamente vuoti.
E stato così che progressivamente quei cittadini sovietici, che non riuscivano a diventare consumatori, ne trassero la deduzione obbligata: se non c’era democrazia in politica, ci fosse almeno consumismo in economia, ma se la “dittatura del proletariato” non assicurava il consumismo, allora niente più comunismo. Quando poi l’Unione Sovietica a seguito dell’incidente di Chernobyl (l’Hiroshima dei sovietici) nel 1985 ha perso la sfida della guerra fredda (con un autogol, dunque, niente affatto per una rete dell’avversario!), l’economia è precipitata in una katastrojka che ha deliziato i commentatori occidentali e che [‘”ultimo comunista” Gorbaciov ha cercato di contrastare offrendo… democrazia! Ma ormai non c’era più nulla da fare: i suoi concittadini volevano soltanto le merci – e già la “cortina di ferro” franava tra l’entusiasmo di una popolazione pronta a precipitarsi nei negozi d’occidente per fare shopping. Pur di trattenerli, Gorbaciov doveva promettere nel maggio 1990 che «ci occorre il mercato», sanzionando con tanta dichiarazione di fallimento il termine dell’esperienza dell’economia di piano sovietica. E così quel “comunismo realizzato”, che aveva resistito tanto eroicamente al brutale assalto nazi-fascista, si è arreso al consumismo capitalistico, chiudendo con una fine non certo gloriosa il “secolo breve” del Novecento.
6. La vendetta del capitalismo
Anche i sistemi economici possono essere vendicativi. Nel corso del Novecento il capitalismo aveva veramente temuto di dover soccombere a quella repubblica sovietica che dalla torre del Cremlino sventolava senza posa (perché mossa da un ventilatore nascosto) la bandiera rossa della rivoluzione comunista. L’ammaina-bandiera del 1991 gli ha tolto ogni preoccupazione: adesso che i proletari non avevano più patria, il capitalismo era per sempre, tanto che qualcuno ha potuto vedere nella caduta del muro di Berlino la conclusione dell’intera vicenda umana perché pervenuta alla generalizzazione planetaria, con «nessun barbaro alle porte» (Fukuyama, p. 102), dei caratteri distintivi del capitalismo: l’economia di mercato da una parte e la democrazia liberale dall’altra, che sono la fine della storia perché ne sono il fine.
A questo punto potevano essere ritirate tutte quelle garanzie di Welfare che si erano dovute concedere per vincere la sfida contro il comunismo. E ciò si è fatto con un processo di demolizione sistematica e puntuale che ha preso il via proprio a partire da quella “catena di montaggio” che, con la sua cadenzata regolarità, aveva trasformato i lavoratori in una componente rigidamente necessaria alla produzione dotandoli di una capacità di ricatto insopportabile. È stata questa la rivoluzione della produzione flessibile (altrettanto dirompente quanto la rivoluzione taylorista) che ha permesso, grazie all’informatizzazione di macchine polivalenti a controllo numerico, di trasformare l’offerta di merci, che nella catena di montaggio era ininterrotta e rivolta al magazzino, in una produzione ad intermittenza “rivolta al cliente” senza per questo perdere la convenienza della dimensione di massa. Infatti con la produzione flessibile è l’offerta a seguire la domanda (e non più precederla, come nel fordismo) potendo quindi farsi altrettanto variabile di questa. Ma se si può produrre solo quando e come vogliono i consumatori, allora la manodopera deve essere richiesta solo quando necessario e si può licenziarla subito dopo. Sulla base di questa nuova logica del produrre il contratto di lavoro non può più essere a tempo indeterminato, ma deve farsi occasionale e precario trasformando la manodopera in una massa di lavoratori “usa-e-getta”. Con ciò finiscono le garanzie del posto fisso e dell’occupazione assicurata “dalla culla alla tomba”, sostituite dall’incertezza dell’occupazione e del reddito che sono tipiche di una società generale del rischio che a stento nasconde la voglia di rivincita di un capitalismo deciso a non scendere più a patti con i propri dipendenti.
A queste condizioni non è più nemmeno necessario farsi concorrenza in termini di produttività crescente del lavoro (come negli anni del compromesso fordista), potendo competere a colpi di riduzioni del costo della manodopera. Tramonta la stagione degli “alti salari”, mentre le statistiche hanno preso a documentare uno spostamento del reddito verso i profitti e le rendite che non ha precedenti nella storia. 1 salari mostrano invece solo dinamiche al ribasso dove ogni nuova generazione sta peggio della precedente, giusta la prospettiva del Workfare State (lo “stato del lavor-essere”), miserabile sostituto rancoroso del fin troppo a lungo sopportato Welfare State. Perfino il “compromesso keynesiano” può essere revocato. Perché mai la spesa pubblica dovrebbe essere finanziata in deficit? Essa va adeguata alle entrate fiscali, e siccome è diventato di dominio comune lo slogan “meno tasse per tutti”, ne consegue l’obiettivo strategico di una riduzione progressiva delle spese dello stato, in particolare di quelle spese sociali che assicurano ai cittadini una retribuzione indiretta mediante i meccanismi redistributivi dell’assistenza e del pensionamento. Ma che ognuno si paghi la sua pensione e le proprie assicurazioni! Al salario sborsato dal capitalista privato non deve più aggiungersi alcuna integrazione pubblica, così che i lavoratori finiscano per dipendere per la loro sopravvivenza presente e futura esclusivamente dalla generosità dei propri (com’è che si fanno chiamare?) datori di lavoro.
Chi sa di economia, vede però a questo punto aprirsi una minaccia. Una politica di bassi salari e di riduzione della spesa pubblica non resuscita il pericolo di una crisi di sovra-produzione per la voragine che si apre tra una offerta in aumento e i consumi pubblici e privati in diminuzione? Certo che no, se dall’armamentario delle ricette d’intervento statale keynesiano non viene dismesso l”’ultimo rimedio”,
che era però anche il più amaro, della spesa militare, l’unica spesa pubblica considerata da tutti e da sempre rispettabile. Così il Warfare State (lo “stato del guerr-essere”) sopravvive al Novecento per fare da criminale compagno al Workfare State allo scopo di tamponarne i vuoti che provoca nella domanda aggregata.
Insomma. per concludere il tutto che dire? Che, se ai tempi del “compromesso fordista-keynesiano” gli alti salari e la spesa sociale avevano operato in sintonia per mostrare come il capitalismo fosse infinitamente migliore del “comunismo realizzato”, adesso che il comunismo non c’è più si può gettare alle ortiche quella maschera bonaria indossata per forza maggiore. Si possono ricombinare elementi di dispotismo ottocentesco, come i bassi salari, e di aggressività novecentesca, come la spesa militare, per passarli intatti al nuovo XXI secolo. Però a questo capitalismo del Duemila senza più remore, che oggi si presenta quasi come il negativo del precedente, sarebbe utile dare da subito il nome più acconcio. E qui avanzo una proposta: se nella seconda metà del Novecento il capitalismo è stato Welfare State, ossia “stato del benessere”, questo si annuncia senza alcun dubbio come lo Stato del malessere, di cui resta soltanto da valutare quanto potrà durare. Ma di questo ci parlerà sicuramente la storia a venire.
Opere Citate
- P. Baran e P. Sweezy, Il capitale monopolistico, Torino, 1968.
- F. Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, 1992.
- F. Furet, Il passato di una illusione, Milano, 1997.
- A. Gramsci, Scritti 1915-1921, Milano, 1968
- E J. Hobsbawm, Il secolo breve, Milano, 1995.
- J. M. Keynes, Occupazione, interesse e moneta. Teoria generale, Torino 1947.
- P. Krugman, Il ritomo dell’economia della depressione, Milano, 1999.
- E. Nolte, Gli anni della violenza, Milano, 1995.
- G. Orwell, 1984, Milano, 1983.
- C. Schmitt, Teoria del partigiano, Milano, 1981