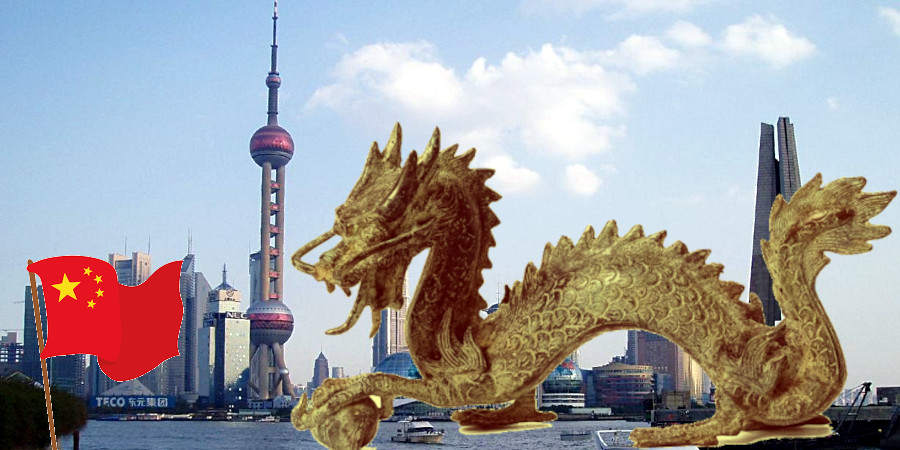Andrea Catone (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
La storia del comunismo del ‘900 non si riduce a quella dell’URSS, ma la rivoluzione d’ottobre e la costituzione dell’URSS, l’esperienza della “costruzione del socialismo”, sono un fattore fondamentale e fondante di quella storia, sia dei partiti comunisti in Europa occidentale, in Asia, Africa e America latina, che delle rivoluzioni cinese, vietnamita, cubana, che si sviluppano secondo una propria autonoma linea. Vi è un legame reciproco e reciproca responsabilità nelle vittorie e nelle sconfitte. Come l’URSS incise sulla storia dei partiti comunisti, anche i successi o gli insuccessi di quei partiti pesarono sulla vicenda sovietica. Basti pensare alle conseguenze che ebbe sulla scelta della “costruzione del socialismo in un paese singolarmente preso” la sconfitta dei tentativi rivoluzionari degli anni venti nei paesi degli imperi centrali, in cui la gravissima crisi postbellica dischiudeva le possibilità di una conquista del potere statale.
Che cosa fossero lo stato e la società scaturiti dalla rivoluzione bolscevica del 1917 (la “natura sociale dell’URSS”) è stata una delle questioni più dibattute e controverse all’interno del marxismo del ‘900; non implicava soltanto problemi di analisi sociale, politica, storica, ma un’opzione politica, uno schierarsi per il presente e il futuro. Esprimersi sull’URSS per tutti i partiti comunisti e le formazioni marxiste nel corso del ‘900 significava immediatamente indicare la propria collocazione politica. E non solo nella politica internazionale – si pensi agli anni 1970-80, quando il partito comunista cinese, considerando l’URSS “socialimperialista”, con caratteri più aggressivi deU’imperialismo USA, sostenne in Asia e Africa, dall’Afghanistan all’Angola, formazioni reazionarie e anticomuniste – ma soprattutto una collocazione identitaria (con conseguenze anche sulle scelte di politica interna).
Se si volessero solo elencare i principali studi pubblicati nel corso degli oltre 70 anni di esistenza dell’URSS occorrerebbero centinaia di pagine. L’URSS è stata studiata a fondo, anche vivisezionata, nei suoi meccanismi politici, economici, sociali, la sua politica estera; non era affatto un continente sconosciuto.
Cosa è cambiato oggi rispetto a 15 anni fa? La fine dell’URSS ha sgomberato il campo dal problema dello schierarsi e del collocarsi in campo internazionale. Questo consente di liberare la valutazione e l’analisi dell’URSS da esigenze tattiche immediate, di schieramento. Rimane tuttavia aperta l’altra questione, che tocca corde molto più profonde e coinvolge l’identità comunista. Per cui continuano a scattare su questo argomento reazioni di difesa o di sprezzante rigetto. La questione di una valutazione del ruolo dell’URSS e del comunismo novecentesco rimane una questione forte, fondativa di identità.
Quale rapporto devono intrattenere coloro che oggi si richiamano al comunismo con l’esperienza storica del comunismo novecentesco? Non si tratta solo di separare, come il titolo del convegno suggerisce, il bambino dall’acqua sporca, o di individuare ciò che è vivo e ciò che è morto, ciò che va conservato e sviluppato e ciò che va rigettato. Insomma, gli insegnamenti che si possono trarre da un’esperienza. Trarre insegnamenti, apprendere da un’esperienza, è indubbiamente utile. Ma la questione è più profonda. Perché in primo luogo si tratta – alla base – di prendere posizione e decidere se si condividono le radici di quell’esperienza o se le si ripudia. È una questione di eredità storica. Se la si accetta o la si rifiuta. I figli non possono scegliersi i propri padri naturali, ma possono rifiutarne o accettarne l’eredità. Accettare l’eredità non significa prendere tutto per buono. Si possono separare in quell’eredità i beni più preziosi, i gioielli di famiglia, e scartare ciò che non è essenziale o attuale, i ferrivecchi, il superfluo. Ma la prima questione è l’accettazione dell’eredità. Riconoscere i propri padri non significa assolverli da colpe o responsabilità gravi, da cui si prendono le debite distanze, riconoscendosi tuttavia egualmente eredi, in continuità storica con essi.
Accettare o rigettare l’eredità dell’esperienza storica del comunismo del ‘900: il primo grande discrimine è proprio qui. Se guardare a quella storia come alla propria storia, alle proprie origini, o disconoscerla. In buona parte è in atto il disconoscimento: la stessa definizione di “rifondazione comunista” significa cercare altre fondamenta, altre basi. Significa collocare quella storia all’interno di altre categorie e spazi che non sono quelli del comunismo, ma altro: l’impiego della categoria di “totalitarismo” funge ottimamente allo scopo. Iscrivere il comunismo del ‘900 nella categoria di “totalitarismo”, sorta per designare fascismo e nazismo, equivale a dire che essa è stata un’altra storia: del capitalismo, o della regressione, dell’aberrazione, dell’involuzione. L’impiego della categoria di “totalitarismo” non è affatto innocente. Significa iscrivere il comunismo sovietico, che è stato parte essenziale, determinante e fondante del comunismo del ‘900, in una storia altra, fuori del movimento operaio, della lotta delle classi.
Ma che cosa è stato il comunismo del ‘900? Per la prima volta nella storia universale le “classi subalterne” hanno provato a costruire – con una coscienza del fine mai vista – una loro società. Né gli schiavi dell’antichità, né i contadini del feudalesimo erano riusciti nelle loro ribellioni ad organizzare una forma nuova di società. Nel panorama della storia mondiale, il comunismo del ‘900 – osservato dalla distanza temporale dell’oggi – appare un’anticipazione ed un’accelerazione straordinaria. Questa esperienza avviata con la rivoluzione d’ottobre ha cambiato il corso della storia mondiale. Ha costretto i dominanti a misurarsi sul terreno dei diritti sociali, della uguaglianza e della giustizia, del diritto del lavoro e al lavoro. Ha aperto questioni prima inimmaginabili, quale quella della autorganizzazione della società di liberi ed eguali, in precedenza affrontate solo nelle anticipazioni utopiche.
Ad onta di tutti i tentativi di rimuovere e affossare la storia del comunismo novecentesco, essa è una pietra miliare nella storia dell’umanità, indipendentemente dal fatto che la rivoluzione sia stata sconfitta. La storia comunista dei ‘900 è parte fondamentale del patrimonio storico dell’umanità; nella costituzione della soggettività contemporanea, al pari della rivoluzione francese, essa è un dato non eliminabile, non rimovibile. La coscienza che questa storia costituisce un patrimonio imprescindibile della soggettività politica, ideologica, culturale, di chiunque intenda pensare e agire per la trasformazione sociale consapevolmente diretta, deve guidarne Io studio. I comunisti in particolare, ma non essi soltanto, non possono che considerarla come parte integrante della costituzione della loro soggettività e identità, e devono perciò appropriarsene consapevolmente. Nessuna soggettività politica di trasformazione sociale e rivoluzionaria può seriamente costituirsi senza la riappropriazione della storia comunista del ‘900, il punto più alto della storia di emancipazione delle classi subalterne, al di là di aberrazioni, errori, arretramenti oggettivi e soggettivi.
Da questa consapevolezza bisogna partire per lo studio di questa storia, considerarla come un proprio patrimonio da riscoprire e di cui riappropriarsi. Non si tratta perciò soltanto di guardare a questa storia, ai suoi successi e alle sue sconfitte, per poter agire nel presente e nell’elaborazione di una propria strategia, in modo da trarre insegnamenti da essa. Ciò è certamente importante e utile, ma bisogna guardarsi da un uso strumentale, da un banale utilitarismo che rischia di portare ad un pedissequo esercizio di separazione del grano dal loglio, ma senza la comprensione dialettica della totalità di questa storia.
L’operazione di comprensione non è giustificazionismo storico, ma implica un punto di vista che guarda la foresta e non i singoli alberi, che coglie il movimento profondo della storia. Se si invoca il recupero della storia comunista del ‘900 in nome dell’azione pratica concreta immediata, se ne svilisce la portata e il significato profondo di costruzione della soggettività e identità comunista. Questa storia va studiata e di essa bisogna riappropriarsi non soltanto e non soprattutto in nome di un obiettivo pratico immediato o a medio termine, ma come momento essenziale della lotta per la costruzione della soggettività comunista. È questa una questione dirimente. È il complesso di questa storia che ci serve. Le valutazioni e le analisi sulle scelte e le pratiche dei comunisti e sul modo in cui i processi sono stati attivati, differiscono e differiranno, ma la questione oggi dirimente tra comunisti e anticomunisti è il modo in cui si considera il complesso di quella storia, indipendentemente da singoli momenti.
Negli ultimi tempi a questo proposito le posizioni si sono notevolmente chiarite: da un lato abbiamo una posizione netta di rifiuto totale di questa storia, condannata in toto. Ma, poiché diventa oggettivamente difficile, ad onta di tutte le acrobazie verbali, buttare in pattumiera un secolo di storia di lotte sociali e politiche e di esperienze di organizzazione di nuove forme di stato e di società, è sempre più frequente il ricorso alla rimozione o alla demonizzazione.
L’operazione reazionaria in corso ha lo scopo di cancellare dalla memoria stessa del proletariato e dei comunisti la grande esperienza storica del comunismo del ‘900. mettere una pietra tombale sulle discussioni e i dibattiti che su di essa, ancora negli anni 1960-1980 si svolgevano anche in campo borghese. Cancellare la memoria di questa esperienza grande e terribile è operazione culturale e politica con il fine – più o meno dichiarato – di annullare l’identità e soggettività comuniste. A differenza degli anni passati, gli studi sull’esperienza sovietica sono oggi ristretti e limitati alla cerchia di pochi “archeologi”. Si tende soprattutto ad evitare che si sviluppi un dibattito politico-culturale, al di là delle litanie sugli orrori, la dittatura, il totalitarismo.
Negli anni immediatamente successivi alla dissoluzione dell’URSS, o come è invalso nel linguaggio corrente, alla “caduta del comunismo”, si sono avuti diversi lavori che hanno cercato di tracciare un bilancio conclusivo dell’esperienza storica del comunismo novecentesco. La produzione più cospicua non è stata però da parte marxista o comunista, che ha cercato di trarre un bilancio critico per rilanciare il comunismo. Né in Italia, dove prevalsero i veti dei dirigenti del PRC che non vollero mai affrontare con la forza di uno studio serio la questione, salvo poi deciderla a colpi di maggioranze in brevi tesi congressuali che liquidavano tutto il comunismo novecentesco, né altrove, dove i partiti comunisti ebbero probabilmente problemi analoghi. Per cui ci siamo trovati di fronte a due approcci che erano o la difesa dell’esperienza del comunismo novecentesco, ma senza approfondimenti, oppure la liquidazione.
Nel complesso, i marxisti cercarono di porre degli argini alla deriva anticomunista, ma, salvo qualche eccezione, prevalse l’intervento difensivo – necessario ma non sufficiente – rispetto agli attacchi sempre più virulenti e all’azione che sul piano culturale il revisionismo storico dispiegava con i libri di Furet e il “Libro nero del comunismo”, apparsi in Francia proprio in coincidenza con 1’80° anniversario della rivoluzione d’ottobre.
Affrontare questa storia non può essere operazione asettica e “imparziale”. Implica un punto di vista da cui gli eventi si osservano, una presa di posizione, una simpatia, nel senso etimologico del termine, un sentirsi parte. L’analisi, lo studio, il confronto a tutto campo potranno essere produttivi se si guarderà a questa storia con simpatia, cioè sentendola come storia propria, come eredità riconosciuta, con cui fare i conti, ma da non rigettare. Ciò non significa giustificare a tutti i costi, chiudere gli occhi dinanzi a fatti e misfatti, ma muoversi alla comprensione di un complicatissimo processo storico che ha preso le mosse da soggetti che si sono posti il compito di organizzare una nuova società fondata sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione.
Bisogna riprendere e sviluppare lo studio dell’esperienza comunista nel ‘900, nella consapevolezza che non siamo assolutamente all’anno zero, ma abbiamo alle spalle – prima del quasi deserto degli ultimi 15 anni – una mole notevolissima di studi, analisi, dibattiti all’interno delle forze marxiste e fuori di esse, che sarebbe assurdo e antiscientifico pretendere di cancellare con un tratto di penna (cadendo tra l’altro nella prevedibile illusione di scoprire ciò che già molti anni fa è stato detto forse anche meglio).
Si cercherà qui schematicamente di enucleare alcune grandi questioni.
1. L’esperienza storica delle rivoluzioni socialiste
può, nella diversità di alcuni fattori culturali e storici, di sensibilità, di grado diverso di civiltà e di sviluppo delle forze produttive, essere riassunta nei tratti seguenti:
- Conquista del potere politico da parte del partito comunista (o di formazioni rivoluzionarie che, come nel caso di Cuba, si organizzeranno successivamente in partito comunista);
- Espropriazione della grande proprietà terriera e dei grandi capitali industriali e bancari da parte dello stato diretto e gestito da forze comuniste;
- Gestione da parte dello stato, attraverso suoi organi, della quasi totalità (comunque della parte largamente preponderante) delle attività economiche;
- Pianificazione delle attività economiche da parte degli organismi statali del piano;
- Distribuzione del prodotto sociale attraverso il salario, i fondi sociali per case, scuole, asili, ospedali, trasporti.
- Frequente sovrapposizione o fusione, nell’esplicazione delle funzioni economiche, di organismi di stato e di partito (al punto da far parlare di “partito-stato”). Il partito comunista non svolgeva solo la funzione politica dirigente, ma anche quella di gestore e amministratore della proprietà pubblica.
2. Da dove partire per una comprensione del movimento comunista del ‘900?
Non ci si può esimere dal fare i conti con la pesantissima sconfitta del 1989-1991. Dopo soli 15 anni di transizione violenta al mercato capitalistico un buon numero di paesi ex socialisti dell’Europa centro-orientale è stato ammesso nel club dell’unione europea, e nella Federazione russa sono state distrutte tutte le principali istituzioni costruite in 70 anni di potere comunista. Ma, quel che più pesa, sono le modalità con cui è avvenuto il tracollo dei partiti comunisti in URSS e nei paesi socialisti dell’Europa centro-orientale, travolti dal dissenso o da una mancanza di consenso attivo delle popolazioni.
Negli anni ‘90 i principali centri di analisi economica e finanziaria delle banche definivano – e pour cause! – “economie di transizione” quelle dei paesi ex socialisti dell’Europa centro-orientale, a riprova del fatto che i comunisti al potere avevano apportato modificazioni profonde nella struttura economico- sociale e non bastava il cambio del potere politico per trasformarle in economie capitalistiche. Il confronto con un’altra celebre restaurazione, quella post-napoleonica in Europa, può portare a concludere sulla fragilità delle trasformazioni socialiste attuate nei paesi dell’Europa centro-orientale e sulla vitalità e forza di attrazione del capitalismo attuale. La restaurazione del Congresso di Vienna riuscì a riportare i sovrani sui loro troni, ma non potè restaurare la vecchia società aristocratica: le forze borghesi che si erano sviluppate nella rivoluzione francese non furono travolte, ma anzi riuscirono a tenere e svilupparsi anche dentro la camicia di forza dello stato assolutistico. Invece ciò non è accaduto con le società socialiste, le cui strutture hanno resistito relativamente poco tempo alla perdita del potere politico. A differenza della storia della borghesia, quella del socialismo ci dice che le trasformazioni economico-sociali nate grazie al potere politico, periscono con esso.
Parliamo di sconfitta, ma si potrebbe parlare anche di tradimento dei generali. Non vi è stato uno scontro in campo aperto tra eserciti che si affrontavano, ma tutto è accaduto perché i capi di un esercito si sono arresi, anzi, sono passati dall’altra parte. Nella sconfitta è stato determinante il ruolo soggettivo, della direzione del PCUS, di Gorbaciov. Tutti gli altri fattori di crisi – economica, sociale – appaiono secondari rispetto alla caduta della soggettività rivoluzionaria. A riprova di ciò la resistenza di altre realtà, come Cuba, che aveva problemi economici ben maggiori di quelli dell’URSS.
Una rivoluzione comunista non si dà senza organizzazione politica cosciente. La società socialista stessa, il modo di produzione dei produttori associati richiede soggetti consapevoli e attivi. L’instaurazione di un’economia socialista richiede necessariamente direzione politica. Non si pianifica nulla senza un’organizzazione cosciente e rivolta a un fine. La società socialista è in re ipsa una società politica, non si affida alla spontaneità del mercato, il ruolo della direzione politica è in essa determinante. Ma ciò implica la costituzione di un “popolo” comunista, di una civiltà orientata da valori e da fini fondati sul primato del collettivo. Non si tratta semplicemente di dirigere uomini, ma di formare uomini che hanno contratto come una seconda natura il primato del collettivo e l’abitudine ad organizzare un’economia fondata sulla proprietà sociale. “L’uomo è il capitale più prezioso”. Questa è una posta in gioco fondamentale. La caduta ideale e ideologica è stata uno dei fattori non secondari della crisi. La responsabilità dei gruppi dirigenti che hanno favorito o promosso la disgregazione ideologica è enorme.
3. Grosso modo, una periodizzazione della storia comunista del ‘900
potrebbe avere le seguenti partizioni:
1917-1949. In conseguenza delle due grandi guerre interimperialistiche mondiali i partiti comunisti conquistano il potere politico in Russia, Cina ed Europa centro-orientale e balcanica.
1949-1975. Consolidamento e sviluppo degli stati socialisti, con la costituzione di un “campo socialista”, polo d’attrazione per le lotte antimperialiste e anticoloniali, dall’Egitto all’Algeria, fino alla vittoria del Vietnam e l’indipendenza di Angola e Mozambico. Tuttavia questo periodo, pur registrando alti ritmi di sviluppo delle economie socialiste e successi nel campo dell’istruzione, della sanità, delle infrastrutture e modernizzazione di paesi arretrati, è segnato da una grave crisi deH’internazionalismo. Dopo lo scisma jugoslavo (1948), quello ben più grave della Cina popolare (a partire dagli anni 1960), fino alla guerra tra Cina e Vietnam nel 1980. Inoltre, in diversi paesi dell’Europa centro-orientale si hanno crisi e rivolte: Berlino (1953); Budapest, Varsavia (1956); Praga (1968); Polonia, con la creazione del “sindacato indipendente” Solidamosc (anni 1970).
1975-1985. Declino dei ritmi di sviluppo e stagnazione. Si accentua la crisi del rapporto tra partiti comunisti al potere e masse.
1986-1991. Inizio della perestrojka gorbacioviana, che innesca o accelera processi di disorganizzazione dell’economia e della società, fino al crollo del potere politico dei partiti comunisti nei paesi dell’Europa centro-orientale (1989) e alla dissoluzione dell’URSS (1991).
1991-2004. La transizione dall’economia socialista a quella capitalista privata e delle istituzioni statali socialiste in liberal-democratiche si compie con grandissima sofferenza sociale, ma senza rilevante opposizione di massa.
Ma, osservata dal punto di vista del confronto tra capitalismo e socialismo, potrebbe essere semplificata in due fasi;
1917-1949. Il socialismo avanza grazie alle divisioni del campo imperialista nelle due guerre mondiali interimperialistiche.
1949-1989. Nonostante resistenze e alcune vittorie, il socialismo subisce i colpi della guerra fredda. Il fronte imperialistico è unito, il fronte comunista è diviso.
Lo stato sovietico è stato attaccato sin dalla sua nascita e la guerra di classe contro il comunismo è stata portata esasperatamente nel secondo dopoguerra, non appena il fronte imperialistico si è ricompattato. Si può osservare che le rivoluzioni comuniste sono riuscite a conquistare e mantenere il potere politico essenzialmente quando il fronte imperialista è stato diviso al punto tale da scatenare due guerre mondiali: l’avanzata del movimento comunista si è avuta con la prima guerra mondiale e con la seconda. Entrambe queste guerre sono state guerre interimperialistiche e le forze della rivoluzione hanno potuto inserirsi vittoriosamente e utilmente in questo scontro. Per fermare il movimento operaio la borghesia ha alimentato il fascismo, che a sua volta ha posto le basi per una nuova guerra interimperialistica. Dal 1917 al 1949, anno in cui il partito comunista cinese prende il potere in Cina, è stato questo il periodo delle grandi rivoluzioni socialiste.
Dopo il 1945, a differenza che nella prima metà del ‘900, le contraddizioni interimperialistiche divengono secondarie rispetto alla contraddizione con il campo socialista per la paura del comunismo: molto più che nella prima metà del ‘900, infatti, la vittoria dei partiti comunisti in Europa centro-orientale e in Cina si presenta come un fenomeno espansivo, che può – partendo anche dalla periferia del mondo – accerchiare le cittadelle capitalistiche e portare la rivoluzione al successo. Il capitalismo internazionale non può in questo caso permettersi divisioni. Di fronte al nemico comune, le contraddizioni interimperialistiche devono cedere il passo all’accordo. E l’arbitro potente del capitalismo internazionale è rappresentato dagli USA, alla cui ombra si sviluppano tutti i principali paesi capitalistici nel secondo dopoguerra, dall’Europa occidentale al Giappone. La guerra mondiale al comunismo viene combattuta con diverse armi e su più fronti, dalla guerra aperta (Corea, Vietnam), a quella “a bassa intensità” – squadroni della morte e contras in America Latina – al colpo di stato militare – Cile 1973 – al sostegno a tutte le forze anticomuniste all’interno dei paesi socialisti.
A differenza che nella prima metà del ‘900, quando i comunisti erano stati capaci di inserirsi con successo nelle contraddizioni capitalistiche, nella seconda metà del ‘900 avviene il contrario, ed è l’imperialismo che si muove in modo sostanzialmente compatto contro il comunismo. 11 colpo da maestro riesce nei primi anni ‘70, quando la contraddizione politico-ideologica tra Cina e URSS diviene il punto di forza della politica degli USA. Il decennio è caratterizzato da un crescendo di attacchi contro l’URSS. A livello mondiale la divisione tra Cina e URSS ha un effetto a catena e rende molto più difficile la lotta di liberazione anticoloniale.
Alla metà degli anni ‘70 – vittoria del Vietnam sugli USA; fine del regime di Salazar e avvio di un processo rivoluzionario in Portogallo; avanzata dei movimenti anticoloniali anche nell’Africa meridionale; sviluppo di movimenti di lotta sociale e politica in alcuni paesi dell’occidente come l’Italia – il fronte antimperialista e socialista mondiale sembra aver toccato il suo apogeo e le forze capitante arretrare.
Ma in realtà le cose stanno diversamente. Il capitale mondiale si sta riorganizzando e individua una strategia a tutto campo che impone il controllo più diretto del capitale sul salariato in Occidente, disgrega le organizzazioni operaie, riesce ad imporsi con una propaganda martellante e insinuante. Fa egemonia. Si presenta col volto democratico dei “diritti umani” contro la “dittatura comunista”. L’URSS comincia pesantemente a perdere le sue battaglie sullo scacchiere internazionale, e adotta una strategia (che si rivelerà estremamente costosa e poco sostenibile) di confronto sul piano militare. Il tracollo del 1989-91 giunge tuttavia rapido e inatteso. Ma era stato preceduto da altre sconfitte. La più grave è la rottura dell’unità del campo socialista, tra Cina e URSS, e la mancanza di un centro internazionale comunista, che coordinasse le lotte su scala mondiale. A ciò va aggiunto l’arretramento dei partiti comunisti in Occidente, la loro rinuncia ad un progetto alternativo di trasformazione socialista della società. Le forze comuniste sono state disgregate e disperse, oppure hanno abbandonato la prospettiva di costruzione di una comunità di stati socialisti. L’egemonia capitalista si è potentemente rafforzata negli anni ottanta, in tutti i paesi. Ai programmi di Reagan e Thatcher si è risposto debolmente, e lì dove si è affrontato lo scontro, si è stati sconfitti.
4. Comunismo, internazionalismo, nazionalismo.
Uno dei problemi non risolti del comunismo novecentesco è stato quello dei rapporti internazionali tra partiti comunisti e tra paesi socialisti. La storia non procede in modo uniforme. Il mondo del primo ‘900 è costituito da un pugno di paesi industrialmente sviluppati, con una ricca e articolata società civile, che sfruttano e dominano paesi arretrati. Il colonialismo e l’imperialismo sono le forme economico-politiche attraverso cui il capitale internazionalizza i suoi rapporti. Dominio e dipendenza. Come lo risolvono i paesi socialisti? Dovrebbe essere con la cooperazione, lo scambio uguale, o anche e meglio, il sostegno gratuito del più sviluppato al meno sviluppato. Qualcosa del genere si verifica in parte, ma in modo contrastato e contraddittorio. E, soprattutto, il “mercato comune” dei paesi socialisti costituitosi nel secondo dopoguerra funziona in modo piuttosto distorto, l’integrazione economica tra paesi socialisti non decolla. Gli stati socialisti dell’Europa dell’est non si sono fusi in una superiore unione di paesi socialisti, con una pianificazione centrale di tutta la produzione e gli scambi. (D’altronde, se la stessa pianificazione all’interno dell’URSS non aveva risolto gli squilibri tra aree economiche, come si poteva pensare di dar vita ad un’integrazione sviluppata tra paesi con grandi differenze socio-economiche e culturali?). Le condizioni in cui il comunismo si afferma nel secondo dopoguerra nella fase della sua massima espansione sono ancora immature, le differenze di sviluppo dei vari paesi troppo elevate. All’internazionalismo cooperante e solidale si oppone il nazionalismo particolaristico. Su questo fanno leva gli USA.
Mentre nel secondo dopoguerra l’imperialismo è stato sostanzialmente unito – l’affare di Suez nel 1956 può considerarsi l’episodio più rilevante di contraddizioni nel suo campo: da allora gli USA affermarono la loro superiorità indiscussa contro ogni velleità di vecchie potenze coloniali – il comunismo è stato piuttosto diviso. Sin dallo scisma di Tito (1948) la borghesia mondiale ha compreso di poter giocare sulle divisioni del campo socialista.
Le cause di fondo di questa divisione non risiedono tanto nel contrasto ideologico-politico, nello “scontro tra marxismo-leninismo e revisionismo”, nelle strategie della rivoluzione mondiale. Tanto nello scisma titino, che in quello cinese e albanese, o nella politica autonomistica rivendicata dal rumeno Ceausescu negli anni ’70-’80, le ragioni più profonde vanno ricercate nel nazionalismo dei gruppi dirigenti dei nuovi paesi socialisti come nella “politica di egemonia’’ dell’URSS che riprende direttrici di espansione della vecchia Russia.
Nel momento in cui dei partiti comunisti conquistano il potere statale, ereditano dal precedente stato le direttrici, i problemi propri dello stato, della sua storia, del modo in cui si rapporta con gli stati confinanti. Questioni che derivano non solo dalla sua struttura economico-sociale, ma dal suo essere Stato con confini e sovranità territoriale da tutelare (è per questo che la politica estera ha una sua continuità pur nel cambio dei governi). Questo è un limite oggettivo della fase storica in cui la transizione ad un’organizzazione economico-sociale fondata sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione passa attraverso la conquista del potere statale. Assumendo il potere statale, il partito comunista assume anche i problemi specifici di quella statualità.
Lo stato è un prodotto storico ben anteriore al comunismo, così come lo è la nazione. Questa non può essere cancellata o superata immediatamente nella struttura economico-sociale socialista, che si avvale anzi di essa, che si realizza all’interno della forma storica nazionale. Nella sua forma concreta e storicamente determinata, il proletariato non è apolide. E per essere internazionalista deve essere un soggetto nazionale. La nazione passa attraverso la forma dello stato nazionale – già realizzato, o come aspirazione dei popoli che non lo hanno, che sono oppressi da stati plurinazionali, ad averne uno, ad “auto- determinarsi”. Non si può ignorare che storicamente vi è stata e vi è una contraddizione tra stati e anche tra nazioni, tra popoli. Se è responsabilità delle classi dominanti dei singoli stati la guerra per l’espansione e l’egemonia a danno di altri, non ci si può però illudere che il conflitto non abbia investito e non investa i popoli stessi, la loro storia, il loro carattere nazionale. La guerra li coinvolge e li avvolge, li plasma, plasma una loro identità nazionale che si contrappone ad altre identità.
La questione nazionale non può essere aggirata. Il movimento comunista l’ha affrontata, ma l’ha poi anche troppo ottimisticamente sottovalutata. L’identità nazionale è un’identità molto forte, più forte di quella di classe. Sia la nazione che la classe sono astrazioni, costruzioni frutto di una ideologia, che le pensa e le organizza. L’identità di classe esiste come classe per sé, cosciente, e per avere coscienza di classe occorre un’operazione consapevole di adesione al marxismo. La coscienza di classe non è spontanea. Non lo è neppure la coscienza nazionale. Ma è più facile costruire identità nazionale che identità di classe. Quest’ultima abbisogna di una mediazione più complessa e, soprattutto, la coscienza di classe può essere trasmessa solo dall’ideologia comunista, che è praticata da chi è all’opposizione, che non ha il potere e i mezzi di propaganda. L’acquisizione di una coscienza di classe antagonista al capitale richiede determinazione, volontà di opposizione. La coscienza nazionale si respira sin dall’infanzia, dalla scuola di base al tifo per la propria “nazionale” nelle competizioni sportive. Appare “spontaneo” riconoscersi nella bandiera nazionale che “è di tutti”. La lingua nazionale è un fattore fortissimo di identificazione. Poi c’è la religione-tradizione. Tutti gli apparati ideologici dello stato borghese concorrono a formare l’identità nazionale. La coscienza di classe richiede invece l’esperienza del lavoro e dell’esclusione dai luoghi dorati dei dominanti e l’azione di formazione e organizzazione dei partiti e sindacati di ispirazione marxista.
Nella dissoluzione degli stati che accompagna la sconfitta storica del 1989-1991, dalla Jugoslavia al- l’URSS, la bandiera della nazione ha sopraffatto quella della classe. La questione nazionale riemerge con forza e ritornano le differenze storiche, le antiche contrapposizioni. URSS e Jugoslavia sono implose con le contrapposizioni nazionali e i rispettivi proletariati si sono fatti una guerra violenta. L’internazionalismo comunista, l’amicizia tra i popoli, la druzhba narodou, è saltata, come un coperchio mal sistemato, nello spazio di un mattino.
L’internazionalismo è stato molto difficile da praticare non per una malvagità o pretese egemoniche di alcuni dirigenti ambiziosi, del loro essere intrisi di ideologia borghese e non comunista (vi è certamente anche questo), ma anche per il dato oggettivo del concreto processo di sviluppo storico diseguale delle diverse culture nazionali, del modo in cui si è costituita la soggettività politica nazionale.
Nell’era della guerra fredda il nazionalismo è stato usato come leva per scardinare il sistema sovietico, soprattutto nei paesi dell’Europa centro-orientale, dove le rivolte antisovietiche, da Berlino a Varsavia, passando per Budapest e Praga, furono anticomuniste e al contempo antirusse, e forse – è il caso della Polonia – prima antirusse e poi anticomuniste. Ma ciò è dovuto al modo in cui si costituirono le “democrazie popolari”, dove fu determinante l’appoggio sostanzioso dell’armata rossa ai partiti comunisti locali per la conquista del potere politico.
Il dramma del movimento comunista internazionale è stata la sua divisione, su cui il capitale ha saputo inserirsi e scardinare il sistema socialista.
5. II problema irrisolto dello sviluppo di un’economia socialista.
La sconfitta epocale del 1989-91 è stato il risultato dell’azione congiunta di molteplici fattori. Quello politico-culturale ha certo avuto un grande peso. Ma la caduta di consenso dei partiti comunisti al potere aveva anche cause strutturali: il rallentamento e la stagnazione dell’economia, le disfunzioni esasperanti nella distribuzione dei beni di consumo, la spesso scadente qualità dei prodotti, gli sprechi, le strozzature nell’attività produttiva, la distanza crescente rispetto al capitalismo occidentale, che invece gli alti tassi di sviluppo registrati in URSS e nelle democrazie popolari negli anni 1950-1960 sembravano poter colmare. Lungi dal funzionare in modo pianificato, le economie di tipo sovietico manifestano, dopo la fase di intensa ricostruzione postbellica e di rapido passaggio nei paesi balcanici da economie agricolo-industriali ad economie industriali-agricole, crescenti segni di crisi. Sulle disfunzioni delle economie di tipo sovietico esiste una vasta letteratura scientifica prodotta sia dalle accademie dei paesi socialisti, sia dal “marxismo critico” dell’est e dell’ovest. Si possono ricordare anche gli studi di Carlo Boffito, Rita di Leo, Alee Nove, tra gli anni 1970-1980, i quali non si concludono assolutamente con una condanna senza appello del meccanismo economico sovietico. Sullo studio del quale un’avvertenza preliminare è d’obbligo: vanno evitati i giudizi schematici e affrettati che dominarono la scena politica del crepuscolo dell’URSS, quando una schiera di economisti che aveva fatto il passaggio di campo propose come unica soluzione l’azzeramento di tutto quanto era stato costruito in 70 anni per approdare al “libero mercato” e alla proprietà privata.
I problemi economici che conobbe il socialismo sovietico e poi, di riflesso, quello delle democrazie popolari, derivavano tanto dal dover affrontare, nella teoria e nella pratica, un campo completamente nuovo e mai sperimentato nella storia dell’umanità – l’organizzazione di un’economia pianificata centralmente e fondata sulla proprietà pubblica delle industrie e della terra – quanto dalle condizioni storiche concrete in cui tale grandiosa impresa veniva tentata. L’arretratezza dell’economia russa rispetto al capitalismo occidentale, nonostante le riforme borghesi di fine ‘800 e primo ‘900, era enorme. La scelta di passare alla fine degli anni venti dalla NEP alla “costruzione del socialismo” comportò la sovrapposizione e la fusione di due obiettivi – costruzione del socialismo e sviluppo delle forze produttive. L’industrializzazione, la produzione di mezzi di produzione, divenne, per un’intensa fase storica, obiettivo prioritario rispetto alla produzione di beni di consumo, secondo gli schemi di riproduzione capitalistica esposti da Marx nel II libro del Capitale. Nel giro di due piani quinquennali l’URSS conobbe negli anni trenta la sua rivoluzione industriale, che le consentì di dotarsi di un apparato produttivo capace di produrre acciaio, carri armati ed aerei in numero e qualità tali da poter vincere militarmente – anche se a un prezzo umano altissimo – la moderna industrializzata Germania hitleriana.
Le questioni di teoria e pratica economica furono ampiamente dibattute e discusse in URSS tra gli anni ‘40 e ‘50, con l’intervento dello stesso Stalin che raccolse in un opuscolo le sue riflessioni sui problemi economici del socialismo. Ma, superata la fase dell’accumulazione economica iniziale e dell’industrializzazione di base, e poi, negli anni cinquanta, della rapida ricostruzione postbellica, l’URSS non riuscì a trovare un modello di sviluppo efficace, adeguato alle esigenze di una nuova fase della società sovietica. Il primo modello aveva funzionato per il passaggio dall’arretratezza all’industrializzazione e fu studiato anche da paesi dell’Asia e dell’Africa. Ma le riforme economiche alla metà degli anni sessanta non riuscirono a dar vita ad un sistema economico altrettanto efficace per una seconda fase di sviluppo di una società industriale urbana. I critici di sinistra vi videro una controrivoluzione guidata da una nuova borghesia di manager e direttori d’impresa che spostava l’economia sovietica sui binari del capitalismo. La questione è più complicata e il ricorso ad alcune categorie del valore non è necessariamente indice, in una società di transizione, di passaggio al capitalismo. Per operare la transizione reale al capitalismo, come si è visto dopo il 1989-91, sono stati necessari ben altri cambiamenti e interventi nei rapporti di proprietà, è stata necessaria la privatizzazione di tutto l’apparato industriale.
Lo studio della produzione teorica e dei problemi dell’economia delI’URSS e delle democrazie popolari dovrebbe rimanere una questione aperta e una fonte preziosa per chiunque si ponga l’obiettivo di un’organizzazione economica socialista. L’esperienza economica sovietica non va assolutamente liquidata come un cumulo di macerie. Le svolte impresse dai dirigenti del partito comunista cinese alla fine degli anni settanta e poi, più decisamente, nei decenni successivi, comunque le si voglia giudicare, prendono le mosse anche dallo studio dei problemi dell’economia sovietica.
6. Deficit di democrazia
Se il capitalismo ha dimostrato nel corso della sua ormai plurisecolare storia di potersi sviluppare sotto regimi fascisti altrettanto bene che nell’involucro delle liberal-democrazie oggi prevalenti, la questione della democrazia – nel senso forte, etimologico del termine – è invece discriminante per il socialismo.
Ma l’esperienza comunista del XX secolo è stata caratterizzata da un letale deficit di democrazia. Ci si riferisce qui non alle forme del parlamentarismo liberal-democratico, ma allo sviluppo di soviet-consigli, collettivi di lavoratori con il potere di assumere decisioni nell’attività economica e politica. Se la proprietà socialista è effettivamente tale, su di essa deve poter disporre tutta la società. Ma questo richiede come minimo ciò che Gramsci chiamava “progresso intellettuale di massa”, una società i cui membri abbiano acquisito la preparazione politica, culturale e tecnica, oltre che l’abitudine a gestire la proprietà sociale. In assenza di ciò finisce con l’imporsi un’élite di esperti capaci di gestire la produzione e lo stato. È la legge ferrea delle oligarchie di Roberto Michels. L’arretratezza e l’immaturità delle condizioni russe, insieme con l’emergenza della guerra civile, provocarono la rapida estinzione dei soviet di fabbrica. I luoghi e gli spazi delle decisioni economiche e politiche si restrinsero. La peculiarità della rivoluzione russa portò ad un sostanziale, e successivamente anche formale, monopartitismo. Il partito comunista divenne di fatto l’unico soggetto dell’economia e dello stato. L’esigenza di accentrare il potere in una fase di gravissimo pericolo per la rivoluzione giustificò questo passo. Del resto, c’era l’illustre precedente dei giacobini nella rivoluzione francese. Poi il modello si è perpetuato e riprodotto sotto l’urgenza di uno stato d’emergenza permanente, determinato dall’assedio delle potenze imperialiste. Da soluzione provvisoria passa a forma stabile e sistematica del potere sovietico.
Finché si mantiene viva all’interno del partito comunista la partecipazione politica e operano nella società sindacati e associazioni di massa, quella sovietica si presenta come una democrazia sostanziale di tipo nuovo, alternativa rispetto alle forme del parlamentarismo liberal-democratico. Ma se si riduce o scompare la dialettica politica e la democrazia interna nel partito comunista, se vengono svuotati del potere decisionale i soviet, i sindacati, i collettivi di lavoro e le altre organizzazioni di massa, la dittatura del proletariato nella forma del monopartitismo comunista si trasforma in potere oligarchico. Si determina una frattura tra dirigenti e diretti, governanti e governati. E ciò, oltre ad essere molto poco consono ad una società socialista, provoca una serie di effetti collaterali che alla lunga indeboliscono e incancreniscono lo stato. La selezione dei gruppi dirigenti non avviene sulla base della preparazione e capacità politica, ma in base a criteri di fedeltà ai vertici del partito, che tendono sempre più a staccarsi dalla situazione reale del paese, abituandosi a sentire solo le buone notizie che solerti cortigiani forniscono loro, mentre le masse si estraniano dalla politica e si passivizzano, rinchiudendosi nel privato. È questo il quadro della società sovietica nel periodo brezneviano, durante il quale aumentano i fenomeni di demotivazione e di allontanamento dalla politica attiva e la lotta politica tra opzioni diverse di politica interna, estera, o su scelte economico-sociali, non avviene alla luce del sole, ma nelle chiuse stanze di un ristretto gruppo di potere, per penetrare nei cui segreti è stata inventata in Occidente quella strana disciplina chiamata “cremlinologia”.
Questa passivizzazione delle masse indotta dall’atrofizzazione della democrazia socialista e dal distacco abissale tra dirigenti e diretti è stata fatale quando dal vertice del PCUS è stato avviato un contraddittorio processo, la cosiddetta perestrojka, che ha portato alla disarticolazione del meccanismo economico della pianificazione e alla distruzione dello stato stesso sorto con la rivoluzione d’ottobre, con il sopravvento di forze apertamente filocapitaliste, fautrici del rapido e violento smantellamento di tutta la struttura deH’economia pubblica e della pianificazione. Di fronte alla controrivoluzione del 1991, con la messa al bando del PCUS e la successiva dichiarazione di morte dell’Unione sovietica – lo stato che, con tutti i limiti di cui si è detto, garantiva comunque un’esistenza dignitosa ai cittadini sovietici di tutte le repubbliche dell’Unione, come ha potuto sperimentare amaramente e tragicamente dopo la sua dissoluzione la grande maggioranza di essi, buttati sul lastrico, immiseriti e ridotti in condizioni inimmaginabili, al punto da considerare il periodo brezneviano un’età dell’oro – le masse sovietiche sono rimaste in gran parte passive, non hanno difeso il partito e lo stato, lasciando campo libero alle forze borghesi, non particolarmente numerose, ma attive e ben organizzate, grazie anche – ma ciò è nell’ordine prevedibile delle cose – ai lauti finanziamenti dei loro sponsor occidentali.
Queste sono alcune delle grandi questioni sul tappeto. L’attacco indiscriminato al comunismo e a tutta l’esperienza sovietica de! periodo staliniano ha reso opaca la conoscenza effettiva di quel che si muoveva in questa società. Nella categoria di totalitarismo tutto diventa repressione e gulag. La parziale apertura degli archivi sovietici ha riaperto un campo molto vasto di ricerche. Ciò che emerge anche dalla pubblicazione parziale di documenti selezionati da studiosi che non si collocano sul versante comunista. è una realtà di uomini in carne ed ossa molto più complessa e assolutamente non riducibile alla sola cifra, dominante oggi, della repressione e del totalitarismo.
Vi è un grande lavoro da svolgere, con particolare attenzione alla storia. Un lavoro di ricerca e analisi. ma anche di pubblicazione di testi, di organizzazione e promozione di luoghi e momenti collettivi di studio e dibattito, nella consapevolezza che esso è vitale per la prospettiva comunista non meno dell’organizzazione e della lotta politica.