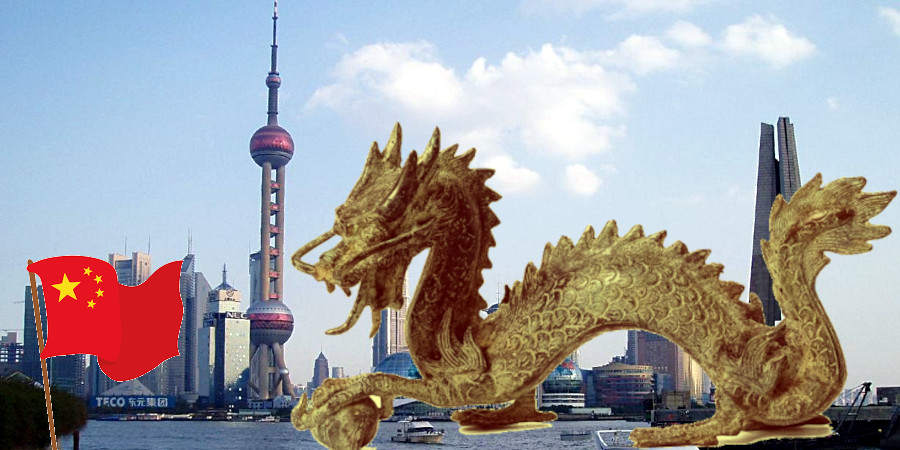Note per una discussione sul socialismo
Fausto Sorini (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
Impostare una riflessione sull’esperienza storica di costruzione del socialismo nel ‘900, sui suoi esiti, sulle prospettive presenti e future del socialismo è questione di fondo dell’identità dei comunisti oggi, delle ragioni non contingenti della loro stessa esistenza.
Il tema è complesso e controverso e va trattato con spirito aperto, con piena disponibilità all’apprendimento reciproco.
Vorrei proporre in proposito alcuni considerazioni preliminari e assolutamente provvisorie per questa ricerca.
1. Tutta la riflessione di Marx e di Engels è legata all’idea che il socialismo si sarebbe affermato innanzitutto nei paesi capitalistici più sviluppati. Dove cioè sarebbe stato il capitalismo stesso, nello stadio più avanzato del suo sviluppo, a risolvere problemi quali l’efficienza della produzione, l’aumento della produttività del lavoro, il dinamismo indotto dalla concorrenza e dal mercato, l’innovazione scientifica e tecnologica. Affermandosi in questi paesi, nei punti alti dello sviluppo, il socialismo avrebbe poi trainato il resto del mondo, le colonie, i paesi più arretrati dal punto di vista dello sviluppo delle forze produttive.
Non solo. Marx legava la possibilità del superamento del mercato (prevedibile in una fase avanzata della transizione al comunismo) non soltanto all’esistenza della proprietà sociale, ma anche ad un elevatissimo livello di sviluppo delle forze produttive e dell’automazione del lavoro, in cui l’uomo avrebbe partecipato sempre meno direttamente alla produzione materiale. Ciò avrebbe dovuto avere come presupposto uno sviluppo della scienza e della tecnica ad un livello che in verità non è stato ancora oggi raggiunto in alcuna parte del mondo. E che certamente non era proprio delle prime esperienze di tipo socialista sperimentate nel ‘900, né di quelle ancora in corso nel 21° secolo, ma che appartiene ad un futuro non ravvicinato.
Marx dirà in proposito: “lo sviluppo delle forze produttive…è un presupposto pratico (del socialismo – NdR) assolutamente necessario, anche perché senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda”.
È assente in Marx e in Engels, al di là di qualche cenno frammentario, privo di pregnanza teorica generale, una riflessione sistematica sulle problematiche di una transizione al socialismo che fosse potuta iniziare nei paesi più arretrati.
2. Questo approccio cambia in Lenin e in tutto il movimento comunista del ‘900.
Con la sua analisi sull’imperialismo, Lenin elabora una nuova teoria della rivoluzione proletaria. Nella fase imperialista, infatti, le singole economie nazionali hanno cessato di essere delle unità relativamente autosufficienti, per diventate anelli della catena unica dell’economia mondiale: il mercato è mondiale, i conflitti e le guerre stesse assumono un carattere mondiale. La questione della rivoluzione va dunque sempre più considerata non sulla sola base dello sviluppo economico e politico e dei rapporti di forza esistenti in ogni singolo paese o in una serie di paesi più avanzati, ma sulla base e in riferimento a un sistema mondiale.
In questo quadro, ciò che è decisivo per Lenin è che il sistema, considerato nel suo insieme, è maturo per trasformazioni in senso socialista. La rivoluzione può quindi cominciare, nel sistema imperialistico, non necessariamente là dove l’industria è più sviluppata, la scienza e la tecnologia più evolute, il proletariato più numeroso, ecc.; ma là dove la catena dell’imperialismo risulta più debole, dove le contraddizioni si assommano e si aggrovigliano, dove la borghesia è quindi più debole, e il proletariato – anche se meno numeroso – può contare su alleati quali i contadini e le nazioni oppresse.
E in conseguenza dello sviluppo ineguale del capitalismo, la rivoluzione potrà non solo vincere, ma anche avviare la costruzione del socialismo in un solo paese o gruppo di paesi. “L’ineguaglianza dello sviluppo economico e politico è una legge assoluta del capitalismo – scriverà Lenin nell’agosto del 1915 – Ne risulta che è possibile la vittoria del socialismo all’inizio in alcuni paesi o anche in un solo paese capitalistico, preso separatamente”. Non c’è dubbio che Lenin pensò per lungo tempo al rapido propagarsi della rivoluzione nell’Europa più sviluppata, il cui alto livello economico e culturale avrebbe favorito lo stesso sviluppo della rivoluzione in Russia in direzione del socialismo.
Ma fu lo stesso Lenin – soprattutto negli ultimi anni di vita, quando era ormai chiaro che la rivoluzione non avrebbe vinto in Occidente – a misurarsi per primo, sul piano teorico e pratico, con le problematiche inedite di quella che Gramsci aveva definito addirittura come “rivoluzione contro il Capitale”, nel senso di una rivoluzione che si affermava in un contesto assai diverso da quello supposto da Marx.
Lenin muore nel 1924 e può solo abbozzare la riflessione. Essa vede una sua significativa sperimentazione nella NEP, che nel ragionamento di Lenin appare dettata non solo da un contingente stato di necessità, ma si carica via via di un significato più strategico e allude a problematiche più generali della transizione.
È implicita nella riflessione leniniana degli ultimi anni – a volte esplicitamente dichiarata – l’idea che in un paese arretrato, tanto più dopo la sconfitta della rivoluzione in Occidente, la transizione al socialismo non sarebbe stata un processo di breve periodo; e che essa avrebbe visto, nell’economia, la compresenza di piano e mercato, di pubblico e privato, di elementi di socialismo e di capitalismo, con l’inevitabile conflitto sociale e di classe che da ciò ne sarebbe derivato. E che il problema del potere politico socialista, utilizzando gli elementi di socialismo in economia (il settore pubblico), sarebbe stato quello di governare la transizione e dominare gli elementi di mercato e di risorgente capitalismo, per utilizzarli e guidarli (non sopprimerli volontaristicamente) verso un loro graduale controllo e poi riassorbimento dentro le “compatibilità” del socialismo.
Ovvero; sarebbe toccato al potere socialista, tenendo conto dell’arretratezza della Russia, promuovere e governare alcuni fattori di sviluppo delle forze produttive che nei paesi più evoluti erano stati affrontati e risolti dal capitalismo; evitando al tempo stesso che essi potessero diventare prevalenti e rovesciare così il carattere e la prospettiva socialista della rivoluzione russa.
Lenin immaginava a tale proposito un processo dai tempi lunghi: “tra capitalismo e comunismo vi è una fase di transizione che abbraccia una intera, lunghissima e complessa epoca storica’’. In cui, in campo economico, convivono “elementi di socialismo ed elementi di capitalismo”. Questo periodo sarà “tanto più lungo quanto meno questa società è sviluppata”.
Lenin mette in guardia “contro le illusioni di facili scorciatoie”. “La presa del potere è solo il primo passo di una lunga transizione”. Ovvero: dopo l’ineludibile rottura rivoluzionaria (non vi è in Lenin, né poi in Gramsci, alcuna confusione possibile con un gradualismo di tipo riformista) il socialismo vince passando attraverso una lunga competizione tra elementi di socialismo e di capitalismo, entrambi presenti nella transizione. E vince quando i primi prevalgono compiutamente sui secondi.
La questione verrà poi ripresa e sviluppata da Gramsci nella sua riflessione sulla “rivoluzione in Occidente”, dove la questione dei “tempi lunghi” e della complessità della rivoluzione si estende alla fase stessa di costruzione del processo rivoluzionario, di conquista cioè dell’egemonia del proletariato – e di trincee avanzate – nell’ambito stesso della società borghese, dove lo Stato non è solo coercizione.
3. Le circostanze storiche eccezionali e le scelte che prevalsero nel gruppo dirigente bolscevico dopo la morte di Lenin (e dopo un aspro dibattito che si protrasse fino al 1929) – scelte fondate sulla previsione, che si rivelò storicamente fondata, secondo cui l’Urss si sarebbe trovata presto a fronteggiare un nuovo conflitto mondiale – favorirono raffermarsi di un modello di industrializzazione accelerata e di forzata collettivizzazione delle campagne.
Il prezzo umano pagato fu elevatissimo, e ancora oggi si discute quanto la ferrea e autoritaria direzione staliniana (di cui tutti riconoscono gli eccessi), fosse per lo più un tributo pagato all’eccezionalità dei tempi; o quanto invece fosse l’espressione di processi degenerativi non obbligati, quindi in buona misura evitabili.
Ma è difficile negare (lo confermò anche Gorbaciov nel suo discorso in occasione del 70° anniversario della rivoluzione d’Ottobre, sia pure in un contesto di riabilitazione complessiva della figura di Bucharin) che quello sviluppo accelerato consentì all’Urss un rapido sviluppo delle forze produttive e le permise di non giungere impreparata all’appuntamento drammatico della 2° guerra mondiale. E se così non fosse stato, se cioè l’Urss si fosse trovata nel 1939 con un’industria pesante più debole e arretrata, assai diversi sarebbero stati gli esiti del conflitto e i destini del mondo.
Sta di fatto che si cristallizzò nei decenni, e continuò anche dopo la morte di Stalin, un modello di statizzazione pressoché integrale dei mezzi di produzione; e per molto tempo le problematiche insite nella riflessione dell’ultimo Lenin sulla Nep furono sostanzialmente rimosse. Riemersero qua e là, in modo frammentario, nel dibattito sulla riforma economica degli anni ‘60 (nell’unione Sovietica, in alcuni paesi dell’Est europeo…), ma non riuscirono mai, in quel periodo, a tradursi in un progetto organico di riforma.
Al contrario, un certo guevarismo a Cuba (che peraltro semplificava il pensiero economico del “Che”) e il maoismo e la Rivoluzione culturale in Cina, spingevano in direzioni opposte, verso una iper-valorizzazione della componente soggettiva, volontaristica e di mobilitazione “ideologica” nello sviluppo delle forze produttive (tutta la cultura politica “anti-economicista” del’68 ne fu impregnata…).
4. Per la verità, una riflessione di grande interesse emerge nel movimento comunista, appena dopo la 2° guerra mondiale, a proposito delle cosiddette “democrazie popolari” nei paesi dell’Est europeo (discorso a parte andrebbe fatto per l’esperienza jugoslava, ma non mi addentro).
In un lungo saggio su Rinascita (la rivista teorica del PCI) del giugno 1947, che si intitola; “Che cosa è la democrazia di nuovo tipo”, (un testo che varrebbe la pena di riprendere analiticamente) l’economista e rivoluzionario ungherese Eugenij Varga (quadro storico dell’Internazionale comunista, uomo di fiducia di Stalin, certamente non un “eretico”…) scrive:
“Il regime sociale di questi stati si differenzia da tutti gli stati da noi conosciuti finora: è qualcosa di assolutamente nuovo nella storia dell’umanità”…In essi “esiste il sistema della proprietà privata sui mezzi di produzione; ma le grandi imprese industriali, il trasporto e il credito sono nelle mani dello stato e lo stato stesso e il suo apparato di repressione non servono gli interessi della borghesia monopolistica, ma gli interessi dei lavoratori’’…”Con la nazionalizzazione dei principali mezzi di produzione e col carattere stesso di questi Stati sono state gettate le basi per il loro passaggio al socialismo. Essi possono, mantenendo il potere statale attuale, passare gradualmente al socialismo sviluppando sempre più le organizzazioni di tipo socialista che già esistono accanto alle aziende mercantili…e …capitalistiche che hanno perso la loro posizione preminente”…”Così la struttura sociale negli Stati democratici di nuovo tipo non è la struttura socialista, ma una nuova forma originale di transizione. Le contraddizioni tra le forze produttive e i rapporti di produzione si attenuano man mano che aumenta il peso specifico del settore socialista”.
Quello che si prefigura qui è dunque un processo di transizione nell’ambito di una economia mista, con un potere politico orientato al socialismo.
5. La stessa problematica si ritrova anche nella elaborazione del PCI di quegli anni sulla “democrazia progressiva” e sulla “via italiana al socialismo”. Nella Dichiarazione programmatica varata nel 1956 dall’8° congresso, si può leggere:
“La costruzione di una società socialista deve prevedere, data la struttura economica italiana, tanto la protezione e lo sviluppo dell’artigianato, quanto la collaborazione con una piccola e media produzione che. non avendo carattere monopolistico, può trovare in un regime socialista condizioni di prosperità per lunghi periodi, prima del passaggio a forme di produzione superiori, sempre sulla base del vantaggio economico e del libero consenso”.
Come si vede gli spunti non mancano, ma anche qui, per diverse ragioni oggettive e soggettive, a partire dal condizionamento operato dalla guerra fredda e dalle rigidità politiche e ideologiche che essa porta inevitabilmente con sé, il tutto non si trasforma in una riflessione e soprattutto in una sperimentazione organica. E anche le nuove intuizioni riguardanti la transizione al socialismo nelle democrazie popolari, vengono riassorbite dentro l’allineamento “di campo” al modello sovietico e alla nuova militarizzazione delle relazioni internazionali, imposta dall’imperialismo e dalle minacce di una nuova guerra (nucleare) contro l’Unione sovietica e il campo socialista.
6. L’originalità delle riflessioni che si affermano nel Partito comunista cinese nel 1978, dopo la morte di Mao e la sconfitta della “banda dei quattro” (e successivamente nel Partito comunista vietnamita) sta proprio – a mio avviso – nella forte riproposizione, attualizzazione e sistematizzazione dei temi sollevati da Lenin nella Nep [1], sia pure nell’ambito di una riflessione che parte dal contesto cino-vietnamita, senza pretese generalizzatrici, senza la velleità di indicare un “modello”.
Sono riflessioni che vengono da lontano.
II nuovo gruppo dirigente cinese (poi quello vietnamita) riflettono sul fallimento del “soggettivismo” e del “volontarismo” economico della Rivoluzione culturale, ma hanno ben presente anche la stagnazione economica che comincia a caratterizzare il sistema sovietico. Si afferma il tentativo di un primo bilancio critico complessivo dell’esperienza del socialismo reale in economia, che troverà ulteriore incoraggiamento e impulso con il fallimento della perestrojka gorbacioviana e il successivo crollo dell’URSS.
L’idea guida è che la crisi del socialismo reale è prima di tutto economica, di difficoltà a reggere la competizione economica e tecnologica con i paesi capitalistici più sviluppati. Per cui, se il socialismo non riesce a reggere tale sfida, esso è destinato a soccombere. E così pure se esso non riesce a reggere la sfida della modernizzazione capitalistica e della competizione mondiale [2], a cui non è realistico pensare di poter sfuggire con economie chiuse, semi-autarchiche, né con forme di esasperato protezionismo; tanto più in paesi ancora in via di sviluppo, come la Cina e il Vietnam.
E quindi – si dice – le società di ispirazione socialista sopravvissute al crollo del sistema sovietico, devono trovare le forme adeguate per introdurre elementi di forte dinamizzazione nello sviluppo delle forze produttive, imparando anche dalle esperienze dei paesi capitalistici più avanzati. Tanto più in paesi ancora in via di sviluppo, come appunto la Cina e il Vietnam, dove, secondo tale approccio, il processo di costruzione del socialismo comporta un lungo processo di transizione, destinato a durare per una lunga fase storica, prima di pervenire ad una società socialista sviluppata degna di questo nome, che possa credibilmente proporsi la realizzazione compiuta degli obiettivi e delle finalità di ciò che da Marx in poi chiamiamo “comunismo”.
Quali che siano le opinioni nel merito del “nuovo corso” cinese e vietnamita, che suscitano valutazioni per lo più caute, non conclusive e assai differenziate nel dibattito dei comunisti, in Italia e a livello internazionale, si tratta in ogni caso di esperienze originali, inedite, dagli sviluppi non scontati. Esse contengono elementi di continuità (soprattutto sul piano politico-istituzionale), ma anche di forte discontinuità (soprattutto sul piano economico e della teoria della transizione), con l’esperienza del “socialismo reale” del ‘900, e si collocano storicamente a cavallo tra 20° e 21° secolo. Questa mescolanza di passato-presente-futuro, nonché il peso crescente della Cina nell’economia mondiale e negli equilibri internazionali del 21° secolo, fanno di queste esperienze un laboratorio di grande interesse, dagli sviluppi oggi non prevedibili, per chiunque si ponga il problema delle prospettive del socialismo.
Ricordo in proposito, durante un viaggio in Cina (1995), un commento di Sergio Garavini, allora segretario del PRC: “ i cinesi, diversamente dallo statalismo integrale del modello sovietico, stanno cercando di costruire una società civile autonoma e dinamica, che si dialettizza con un potere politico destinato prima o poi a democratizzarsi, in relazione alla crescita della società civile stessa. Se l’esperimento riesce, le conseguenze di tutto ciò possono essere imprevedibili e dirompenti per il futuro del socialismo
7. La storia del ‘900 ha confermato la giustezza dell’analisi di Lenin sull’imperialismo e la conseguente teoria dell’ “anello debole” della catena [3], quale che sia il giudizio che si vuol dare sull’esito conclusivo dell’esperienza sovietica (a meno di non pensare che esso fosse implicito nelle sue premesse originarie, che fosse cioè predeterminato fin dal 1917…). E, a mio avviso, ha confermato anche alcune intuizioni di fondo del Lenin degli ultimi anni sulla transizione (ma su ciò ritorneremo più avanti).
Le rivoluzioni socialiste che si affermano nel corso del 20° secolo, a partire da quella sovietica, riguardano tutte paesi fortemente segnati dall’arretratezza (Jugoslavia, Cina, Vietnam, Corea, Cuba…); mentre l’esperienza che coinvolge i paesi dell’Est europeo, alcuni dei quali partono da livelli più elevati di sviluppo (Cecoslovacchia, DDR) è fortemente condizionata, più che dalle rispettive peculiarità nazionali, dalla comune appartenenza ad un campo politico-militare e ad un’area di influenza dominati dall’Urss. dalle “compatibilità” della guerra fredda e dalla militarizzazione delle relazioni internazionali che essa produce.
Si tratta di un contesto internazionale che certamente non è auspicato dall’Urss e dai suoi alleati, che anzi lo subiscono (a partire dalla minaccia nucleare e dalla costituzione della NATO nel 1949), ma che una volta affermatosi condiziona fortemente scelte e comportamenti del campo socialista.Ciò non consente a questi paesi di “democrazia popolare” di praticare esperienze di transizione più conformi alle rispettive peculiarità nazionali e ai rispettivi livelli di sviluppo economico, politico, culturale (come pure era auspicato dalla stessa direzione sovietica all’indomani della 2° guerra mondiale e prima dell’affermarsi della guerra fredda), ma li costringe ad uniformarsi ai tratti fondamentali del “modello sovietico” e ad una “disciplina di campo” dominata dall’Urss e dalle sue esigenze statuali di sicurezza.
8. Il riflusso della rivoluzione in Occidente fa sì che il campo socialista (inteso in senso lato, e cioè prima imperniato sull’Urss, poi sull’asse Urss-Cina, poi segnato dalla rottura drammatica tra le due maggiori potenze socialiste) si affermi oggettivamente, nell’arco di tutta la vicenda novecentesca, come “l’epicentro” del processo rivoluzionario mondiale, della lotta per l’avanzata verso il socialismo e la liberazione dei popoli (emblematica sarà la vicenda del Vietnam). E ciò al di là delle valutazioni anche molto diverse che si esprimono sulla politica nazionale e internazionale di questo o quel Paese socialista, nelle diverse fasi che segnano la storia del secolo scorso, o su singoli eventi.
Si tratta di una constatazione storica, più che di un giudizio.
Anche nella elaborazione del PCI di Gramsci, Togliatti, Longo, che affronta il tema delle peculiarità della rivoluzione in Occidente, e che si pone sovente in modo critico nei confronti del “socialismo reale”, la funzione internazionale del campo socialista resta centrale. E centrale essa rimane, in pressoché tutti i filoni di pensiero di ispirazione comunista del ‘900: da Mao a Kruscev, da Togliatti a Che Guevara, nonostante le diversità anche profonde di strategia e di teoria che tali filoni esprimono (dalle diversità di giudizio sulla Cina e sull’Urss, alle polemiche sulla coesistenza pacifica tra i due sistemi e sulla inevitabilità di una terza guerra mondiale, dal confronto su via pacifica o via rivoluzionaria, all’emergere di un filone terzomondista o di chi al contrario pone l’accento sulla funzione del movimento operaio dell’Europa occidentale).
Nonostante tali diversità, tutt’altro che marginali, nessuna delle componenti più significative del movimento comunista nega (sia pure criticamente e al di là delle esasperazioni propagandistiche della fasi più acute della polemica) la funzione centrale del campo socialista, quantomeno quale principale elemento di contrappeso all’imperialismo. Anche nel primo Berlinguer e in talune interpretazioni meno estreme del filone “eurocomunista’’, tale funzione viene riconosciuta.
Nella fase finale della direzione di Breznev e poi soprattutto con Andropov, emergono segni crescenti di normalizzazione nelle relazioni Urss-Cina, incoraggiati da ambo le parti, dopo una fase acutissima e lacerante di contrapposizione. E l’eventualità, che appare finalmente possibile, di una pacificazione tra le due maggiori potenze socialiste incoraggia una ripresa di fiducia in un possibile rilancio del ruolo internazionale dei paesi socialisti. Lo stesso Gorbaciov, su questo punto in sintonia con Deng Xiaoping, promuoverà una linea di normalizzazione delle relazioni con la Cina. È del tutto evidente che una nuova dinamizzazione del processo di rinnovamento socialista di entrambi i maggiori paesi del “socialismo reale” e una pacificazione delle loro relazioni avrebbe potuto accrescere la capacità di attrazione del socialismo su scala mondiale. Ma, come è noto, le due “perestroike” (quella sovietica e quella cinese) avranno approcci ed esiti ben diversi.
Sarà invece Enrico Berlinguer, prima di questi eventi e dopo la crisi polacca del 1981, a “passare il guado”, con la famosa sentenza sull’esaurimento della spinta propulsiva. Una tesi che, nella sua più profonda (e meno compresa) accezione – come appare chiaro anche dalla recente pubblicazione del “diario segreto” di Tatù – sostiene che una nuova fase storica si è aperta, nella quale non più il campo socialista, bensì il movimento operaio dell’Europa occidentale (nell’incontro tra “eurocomunismo” e socialdemocrazia) diventa “l’epicentro” del processo rivoluzionario mondiale.
Saranno i fatti degli anni e decenni successivi (scioglimento del PCI, deriva neo-liberale della socialdemocrazia europea) a dimostrare il carattere infondato e velleitario di questa tesi: non già nell’aver colto la profondità della crisi del sistema sovietico (che crollerà dieci anni dopo), ma nelle conclusioni da ciò fattene derivare per il movimento operaio internazionale. Mentre il Pei, dopo la morte di Berlinguer, si avvierà disastrosamente all’autoscioglimento.
Sta di fatto che il crollo dell’Urss e del campo socialista in Europa (diversamente ad es. dall’esperienza cinese, vietnamita, cubana: non si può semplificare e rubricare tutto sotto la categoria del “crollo” o del “fallimento”) ci obbliga ad analizzarne le cause, a tentare un bilancio complessivo di tutta un’esperienza storica che per decenni è stata centrale nell’esperienza del movimento operaio del secolo scorso. Non è possibile ricostruire una casa che è crollata dopo un terremoto se non si comprendono a fondo le ragioni del crollo. Non è possibile rilanciare credibilmente la prospettiva del socialismo nel 21° secolo se non si fanno i conti fino in fondo, in modo rigoroso e non propagandistico, con l’esperienza complessiva del socialismo e del movimento comunista del ‘900.
Sull’esperienza storica di costruzione del socialismo nel ‘900
9. Possiamo provare a riassumere, in estrema sintesi e tenendo conto degli apporti di diversi filoni di pensiero, le cause fondamentali della crisi e poi del crollo del “socialismo sovietico” e del campo socialista in Europa?
Si tratta, preliminarmente, di considerare un dato strutturale, di arretratezza storica rispetto al capitalismo sviluppato, in cui si è compiuta la prima esperienza di transizione al socialismo.
La sconfitta della rivoluzione in Occidente negli anni ’20 e il conseguente isolamento e ripiegamento in cui ciò ha costretto il potere sovietico, hanno condizionato tutto il processo di costruzione del “socialismo in un solo Paese”. Non tutto era inevitabile, sarebbe assai meccanicista affermarlo, ma certamente il contesto oggettivo fu tremendamente difficile. E favorì non solo i processi degenerativi che vi furono, ma anche e soprattutto l’affermarsi di un “modello” economico (statalismo integrale) e politico istituzionale (partito unico, partito-Stato) che poi sostanzialmente si estese – nelle sue strutture portanti e nei suoi limiti originari – anche alle successive esperienze di transizione.
I lunghi decenni di guerra (calda e fredda) che l’Urss ha dovuto reggere nei confronti del mondo capitalistico (accerchiamento, seconda guerra mondiale, minaccia nucleare, corsa agli armamenti) hanno indotto una centralizzazione autoritaria della vita economica e politica e una “militarizzazione” del pensiero che. una volta cristalizzatasi in un sistema di potere, sono sopravvissuti ben al di là delle circostanze che ne avevano favorito l’affermazione.
10. Si è consolidato un modello economico dimostratosi inadeguato a reggere la competizione col capitalismo e con la sua impetuosa rivoluzione tecnico-scientifica. Un modello economico i cui assi portanti erano:
- la statizzazione pressoché integrale della vita economica e sociale e il mancato riconoscimento del ruolo non marginale del settore privato nella transizione, tanto più nei paesi ancora alle prese con problemi primordiali di sviluppo a causa della loro arretratezza;
- una pianificazione rigidamente centralizzata e gerarchica e un dirigismo aziendale che hanno sostanzialmente escluso i lavoratori (i “produttori”) dalla partecipazione responsabile alla gestione delle unità produttive e alla elaborazione democratica del piano, determinando una oggettiva separazione dei produttori dai mezzi di produzione (statalizzazione senza socializzazione);
- l’inadeguatezza di un sistema di incentivi (per i singoli, per le imprese, per i collettivi aziendali), capace di premiare quantità, qualità e spirito di iniziativa del lavoro umano.
11. L’altro limite fondamentale del “socialismo reale” rimanda a un modello politico-istituzionale autoritario che ha frenato lo sviluppo di una democrazia socialista, nella cornice di uno Stato di diritto, con solide radici nella società civile. Questo spiega, tra l’altro, la facilità con cui – venuto meno il protettorato politico-militare dell’Urss – i sistemi politici dell’Est europeo sono crollati: facilità e rapidità mai viste in altri sistemi politici anche apertamente reazionari, dimostratisi assai più radicati, più capaci di egemonia e resistenti all’azione delle forze organizzate di opposizione.
12. La mancanza di un’autentica dialettica democratica nel partito e nello stato, l’identificazione del partito con l’apparato statale, il distacco tra potere e popolo, tra potere e lavoratori, il monolitismo verticistico del potere politico e la negazione di ogni autentica dialettica politico-culturale, sia pure interna al movimento dei lavoratori e alle forze che si collocavano in una comune prospettiva socialista – patologie che pure hanno avuto certamente intensità diverse nelle differenti esperienze di transizione e nelle diverse fasi delle medesime – hanno prodotto, in molti casi, la stagnazione e la sclerosi del pensiero teorico, trasformando il marxismo in ideologia di Stato, sempre meno credibile agli occhi delle masse. E hanno privato la società e il partito stesso di quegli strumenti critici autocorrettivi capaci di far intendere per tempo le modificazioni della realtà e le riforme che si rendevano necessarie per rafforzare e rilanciare le basi del socialismo.
13. L’esperienza storica ha dimostrato la persistenza di profonde differenziazioni sociali, di classe, politiche, ideali, nazionali, etniche nelle società di transizione; diversità che vanno riconosciute, fatte emergere e governate democraticamente, con il consenso e la partecipazione popolare. Mentre erronea si è rivelata la tesi della “crescente omogeneizzazione” di queste società, del venir meno in esse di contraddizioni anche profonde. Queste differenziazioni, non trovando canali democratici e trasparenti per esprimersi, si sono manifestate in una sorta di “parlamentarismo nero” nel partito, mascherato da un esteriore e sempre più formale centralismo burocratico; e hanno favorito lo snaturamento del carattere rivoluzionario e d’avanguardia dei partiti comunisti al potere e il loro allontanamento dalle masse, con la penetrazione in essi di tendenze e interessi che nulla avevano a che vedere con le prospettive e le idealità comuniste. Una volta scoperchiato in modo improvviso e improvvisato il “vaso di Pandora” (come avvenne in Urss con la perestroika gorbacioviana), tali forze – dopo avere ricercato e ottenuto il sostegno decisivo dell’occidente capitalistico – hanno preso il sopravvento.
14. Nell’analisi delle ragioni storiche e politiche che hanno condotto al crollo dell’Urss, considero di grande interesse (meritevole quanto meno di attenzione e approfondimento) l’opinione che ci fu esposta a Pechino nel gennaio 1995, in occasione del primo viaggio in Cina di una delegazione del PRC (di cui facevo parte) guidata dall’allora segretario Sergio Garavini, nell’incontro con uno dei massimi dirigenti – all’epoca – del Partito comunista cinese. Una tesi che provo così a riassumere.
Sia la direzione di Mao in Cina che la direzione di Stalin in Urss hanno avuto molti limiti, e i contenuti di quelle politiche sono irripetibili e non riproponibili nel contesto storico attuale. È stato giusto andare oltre.
Esse hanno avuto comunque il merito storico di aver posto le basi primordiali della costruzione del socialismo nei rispettivi paesi, dopo la vittoria della rivoluzione e in circostanze storiche eccezionali. In particolare l’Urss fu costretta a sopravvivere per alcuni decenni nell’isolamento internazionale e nel più brutale accerchiamento.
È sbagliato e serve a poco accanirsi contro Mao e Stalin e contro i loro errori, essi non sono la causa primaria dei problemi e delle difficoltà che entrambi i Paesi si sono trovati ad affrontare dopo la loro morte.
Il punto è che la Cina ha saputo – dopo la morte di Mao – fare un bilancio critico, ma non liquidatorio, della fase precedente e delle condizioni di eccezionalità che l’avevano contraddistinta; ha trovato gradualmente la via di un modello di sviluppo che andasse oltre Mao, senza bisogno di demonizzare Mao, con una politica di riforme – ancora in corso – adeguate alla nuova fase storica politica (modello che si sta sperimentando, che non viene considerato esaustivo e definitivo, che si è pronti a correggere sulla base dell’esperienza, ma che ha permesso di fronteggiare la crisi del “socialismo reale”, evitare il crollo, andare avanti). Mentre l’Urss e le direzioni del PCUS che sono venute dopo Stalin, non hanno saputo veramente andare “oltre Stalin”; lo hanno denigrato o rimosso, ma non hanno saputo elaborare e attuare un progetto organico di riforme del sistema sovietico capace di rivitalizzarlo nella nuova fase storica; non hanno saputo adeguarlo al nuovo contesto interno e internazionale per renderlo capace di reggere la competizione economica e tecnologica con i Paesi capitalistici più avanzati, passando da una fase estensiva ad una intensiva dello sviluppo economico, fino ad imboccare la via della stagnazione burocratica e poi della crisi. E, con la catastrofe finale della politica gorbacioviana, hanno condotto l’Urss non sulla via della riforma del socialismo, ma sulla via della sua autoliquidazione.
Varrebbe la pena, a tale proposito, riprendere l’analisi puntuale e la discussione sulla figura di Andropov, sul suo progetto (appena abbozzato) di riforma della società sovietica (come oggi stanno facendo, non a caso, anche storici non “ortodossi”, come Moshe Lewin).
Mi sbaglierò, ma molti elementi inducono a ritenere che la brevissima e contrastata direzione andropoviana abbia rappresentato la vera occasione mancata di riforma socialista del sistema sovietico, dopo la morte di Stalin. E il fatto che significative componenti politiche e correnti di pensiero non nostalgiche nella Russia di oggi (anche nel ristretto entourage di Putin..) continuino a farvi riferimento, non mi sembra privo di significato.
15. Per quanto importante sia la problematica della democrazia socialista e delle differenti forme politico-istituzionali in cui essa possa incarnarsi, va superata a mio avviso una concezione per cui la crisi del socialismo sovietico avrebbe avuto sostanzialmente la sua origine in un deficit di democrazia politica (che pure vi fu e fu grave). Il fallimento della perestrojka, da un lato, e la rivitalizzazione di esperienze di transizione come quella cinese o vietnamita, dall’altro, evidenziano invece la centralità delle questioni strutturali, del modello di sviluppo, delle forme di proprietà e di gestione dei processi produttivi; senza che ciò conduca ad una rimozione delle altre.
16. Tali problematiche sono in ultima analisi riconducibili alla grande questione del rapporto tra piano e mercato, tra economia pubblica e privata, con una presenza del settore pubblico che sia sufficiente – per estensione, qualità ed efficienza – ad orientare le scelte strategiche dello sviluppo, senza di che verrebbero meno i presupposti strutturali minimi di una transizione orientata al socialismo.
Si tratta cioè di riconoscere, in questo quadro, il ruolo di strumenti e meccanismi di mercato, sul piano interno e su quello internazionale, per una lunga fase di transizione, prima del passaggio a forme più avanzate di socializzazione, oggi non prefigurabili. Un tema questo che è oggi al centro del dibattito di quasi tutti i maggiori partiti comunisti al mondo, siano essi al potere, in governi di coalizione o all’opposizione [4].
17. Rispetto ad alcune tesi liquidatone dell’esperienza storica del socialismo del ‘900, vorrei ricordare quello che ha detto recentemente in una intervista il presidente del PC giapponese, Tetsuzo Fuwa (che pure è un critico feroce dell’esperienza sovietica, così come essa si è sviluppata dopo la morte di Lenin); e cioè “quanto sia oggi ancora prematuro fare un bilancio del 20° secolo in relazione al socialismo. Nel 20° secolo l’Urss e i paesi dell’Europa dell’Est non sono stati gli unici paesi ad abbandonare il capitalismo per diventare paesi socialisti. Al contrario, in termini di popolazione sono solo una minoranza tra quei paesi che hanno tentato di costruire il socialismo”.
“Ho visitato la Cina e il Vietnam – ha scritto Fuwa – A seconda delle strade che percorreranno nel 21° secolo per diventare paesi socialisti e dei risultati che otterranno, la valutazione del 20° secolo in relazione al socialismo sarà molto diversa. È infatti troppo presto per trarre un bilancio del 20° secolo, basandosi solo sulla fine dell’Unione Sovietica e dei sistemi dell’Europa orientale”.
Cosa intende dire Fuwa?
Nell’intervista citata, richiamando le tesi congressuali più recenti del suo partito, egli ricorda innanzitutto – nel tirare un bilancio complessivo del 20° secolo – che nel ‘900 l’umanità è andata avanti, non indietro, e ciò grazie in buona parte al ruolo svolto dal socialismo, dal movimento operaio e comunista. Più che in ogni altro secolo precedente nella storia millenaria del genere umano, si sono fatti passi avanti nella liberazione di miliardi di esseri umani dalle precedenti forme di oppressione, con la conquista di diritti sociali, politici (stato sociale, suffragio universale, emancipazione femminile…), con l’autodeterminazione dei popoli e la conquista dell’indipendenza nazionale per la maggioranza di essi, col crollo dei vecchi imperi coloniali, la fine di gran parte delle monarchie e dei regimi fascisti, l’aspirazione alla pace nella coscienza diffusa dei popoli. Quando si ammette che il crollo dell’ URSS è un ritorno indietro, un fattore negativo e una sconfitta per tutto il movimento progressista (e ciò viene unanimemente riconosciuto tra i comunisti e i progressisti, anche dalle correnti di pensiero più critiche nei confronti dell’esperienza sovietica), si ammette che di per sé la sua esistenza era un fattore positivo nelle dinamiche internazionali, comunque di contrappeso al capitalismo e all’imperialismo. Le guerre dell’ultimo decennio (Jugoslavia, Afghanistan, Iraq…) sarebbero state impensabili in un mondo in cui fosse esistita ancora l’Urss.
Più precisamente, Fuwa sottolinea che, su circa 1 miliardo e 800 milioni di esseri umani che nel secolo scorso hanno intrapreso processi finalizzati alla costruzione di società socialiste, un miliardo e mezzo ancora ci sta provando, ed esso rappresenta un quarto dell’umanità intera.
È vero che l’esperienza dell’Urss fu centrale nella storia del ‘900, e il suo esito catastrofico non può certo essere rimosso o minimizzato nell’ambito di una valutazione complessiva. Ma cosa accadrebbe nel mondo del 21° secolo se – come ritengono molti analisti, di vario orientamento – tra alcuni decenni la Cina dovesse eguagliare gli Stati Uniti in termini di forza economica? [5]
Cosa accadrebbe se ciò avvenisse nell’ambito di una direzione di marcia del suo sviluppo che non rinnegasse una prospettiva socialista, sia pure di lungo periodo? Non è forse vero che la Cina assumerebbe un ruolo internazionale non inferiore a quello che l’Urss espresse nel secolo scorso? Un ruolo che già oggi, in termini di influenza e competizione economica, è superiore a quello che fu dell’URSS nel ‘900.
Non è forse vero che essa diventerebbe (in parte lo è già) un punto di riferimento sempre più importante per i Paesi in via di sviluppo (che rappresentano i 4/5 dell’umanità), oltre che un significativo contrappeso agli Stati Uniti nella dialettica pace-guerra?
Se questo fosse lo scenario, probabilmente il mondo non tornerebbe a logiche bipolari e di campo,
come quelle che lo hanno segnato nel secolo scorso; credo al contrario che ne uscirebbe rafforzata una dimensione multipolare. Ma gli equilibri e le dinamiche internazionali cambierebbero non poco rispetto ad oggi. E nel frattempo, cosa succederebbe in India, in Russia, in Medio Oriente, nell’America Latina, in Africa…?
Siamo così sicuri che tutto ciò – a partire dal ruolo della Cina – abbia poco a che vedere col futuro del socialismo?
Nuovo quadro mondiale e prospettive del socialismo nel 21° secolo
18. La contraddizione pace/guerra – così come lo fu nel secolo scorso – si conferma come centrale anche nel 21° secolo, terreno essenziale e strategico nella lotta per il socialismo.
Le due guerre mondiali del ‘900 sono principalmente il prodotto delle contraddizioni tra imperialismi (l’Urss, fino agli anni ’40, non è ancora percepita come una minaccia globale e ravvicinata al dominio capitalistico sul mondo). Ma dopo la vittoria conseguita nella 2° guerra mondiale e il ruolo di punta svolto nella lotta antinazista – che determina la formazione di un campo socialista in Europa e una crescita enorme del prestigio e dell’influenza internazionale dell’Unione sovietica – la politica di riarmo ’ di minaccia nucleare che caratterizza la guerra fredda è essenzialmente diretta contro il campo socialista, che si viene estendendo (Cina, Vietnam, Corea, Cuba…), rappresenta un sostegno essenziale per le lotte di liberazione e compete per l’egemonia mondiale.
Nella guerra fredda le contraddizioni inter-imperialistiche, che sottotraccia continuano a esistere, sono però compresse nella compattezza e nella disciplina di campo atlantica, guidata dagli Usa. Il confronto è sempre più bipolare e in ultima analisi rimanda al confronto capitalismo/socialismo.
La politica di riarmo perseguita coerentemente dal campo imperialista serve anche ad impedire uno sviluppo pacifico, democratico del socialismo e della sua capacità di attrazione, a sfiancarne l’economia con le spese in armamenti.
Le rotture tra paesi socialisti, prima quella tra Urss e Jugoslavia, poi quella – gravissima – tra Cina e Urss, indeboliscono il campo socialista e ne intaccano il prestigio internazionale. Assai diversi sarebbero stati i destini del socialismo, se non vi fosse stata una frattura così profonda tra le due maggiori potenze socialiste, o se essa fosse stata per tempo ricomposta (e qui emergono pesanti responsabilità soggettive da entrambe le parti). Ma tali rotture non modificano il contesto prevalentemente bipolare del confronto. Le superpotenze globali sono due, USA e Urss. La Cina, diversamente da oggi, non dispone ancora di una forza economica e militare capace di farle svolgere un ruolo internazionale di primo piano.
19. Il crollo dell’Urss modifica qualitativamente il quadro generale. Rimane una sola superpotenza, il prevalere delle forze che si richiamano al socialismo non rappresenta più una minaccia ravvicinata, riemergono le contraddizioni tra le maggiori potenze imperialiste (Usa, Ue, Giappone) e con altre potenze emergenti. Il contesto generale agli inizi del 21° secolo è quello di una competizione globale per l’egemonia.
Gli Usa percepiscono il rischio di un declino della loro egemonia planetaria. La tendenza è quella di una diminuzione dell’incidenza del PIL Usa sull’economia mondiale; e di una crescita di altre aree economiche, geo-politiche, valutarie.
Si calcola che tra alcuni decenni l’incidenza economica complessiva di Paesi emergenti come Cina, India, Russia, Brasile, Sudafrica potrebbe eguagliare e poi superare quella degli imperialismi della triade (Usa, Ue, Giappone). Una autentica rivoluzione degli equilibri planetari (le guerre mondiali del ‘900 sono scoppiate per molto meno).
Gli Usa tentano di arginare tali tendenze ricorrendo ad un potenziamento della loro superiorità militare sul resto del mondo e ad una politica di crescente ricorso alla guerra: per vincere la competizione globale che temono di perdere sul terreno della competizione pacifica ed economica.
Da qui il salto di qualità, in negativo, rappresentato dalla “guerra preventiva” di Bush.
Il resto del mondo, non solo i progressisti ma anche le altre potenze imperialiste, percepisce il pericolo di una dittatura planetaria. E di una linea volta al controllo delle risorse energetiche del pianeta per condizionare lo sviluppo delle altre economie, concorrenti con quella Usa.
Da qui sorgono le nuove divisioni nell’Onu, nella Nato, nella Ue. Da qui le spinte al riarmo e ad una politica autonoma in campo militare che si manifestano in un nascente imperialismo europeo (imperniato sull’asse franco-tedesco) e in quello giapponese.
Vincere la lotta per la pace e il disarmo (che passa per l’affermazione di un Trattato internazionale vincolante che comporti la messa al bando e la distruzione di tutte le armi di distruzione di massa) è una battaglia storica prioritaria, di lungo periodo. Ciò non condurrebbe di per sé al socialismo, ma rafforzerebbe un ordine mondiale multipolare in cui la minaccia principale, oggi rappresentata dai settori più aggressivi dell’ imperialismo Usa, verrebbe sconfitta e fatta retrocedere, aprendo all’umanità e ai popoli prospettive più avanzate di liberazione.
Solo gli Usa hanno oggi la forza militare per poter pensare di dominare il mondo. Se questa forza/ricatto si riduce o viene addirittura vanificata, tutto il mondo è più libero. E sul terreno della competizione pacifica e del multipolarismo, si aprono spazi maggiori anche per l’affermazione delle forze progressive, dei popoli e dei Paesi che nelle diverse regioni del mondo perseguono modelli di sviluppo e di società di tipo socialista o comunque alternativi al neo-liberismo.
Non sappiamo se queste contraddizioni sfoceranno prima o poi in una nuova guerra mondiale. Lottiamo per evitare scenari che sarebbero catastrofici nell’era nucleare.
Se questo fosse lo scenario che ci riserva il futuro (un conflitto mondiale o la estensione di guerre regionali), quanto più forte e determinato sarà il fronte della pace, tanto più alto sarà il prezzo pagato dai fautori di guerra. Lo si vede, su scala ancora circoscritta, con quello che è successo e succede con la guerra in Iraq: la forzatura dell’intervento Usa fa pagare loro un prezzo politico alto (isolamento internazionale, “antiamericanismo” che rinasce nei popoli e nelle nuove generazioni, fino a pochi anni fa largamente omologate, soprattutto in Occidente). Guai se non ci fosse stata una reazione forte alla guerra in Iraq: una reazione mondiale che trova sostegno e alimento nella resistenza del popolo irakeno contro l’occupazione, che proprio per questo, al di là di ogni altra considerazione, riveste un elevato valore strategico nella lotta internazionale tra conservazione e progresso, tra guerra e pace.
20. Il crollo dell’Urss, per quanto grave e traumatico sia stato l’evento, non rappresenta la fine del movimento comunista e del lungo processo storico mondiale di transizione al socialismo e al comunismo (di superamento del sistema capitalistico) aperto dalla rivoluzione d’Ottobre, le cui caratteristiche sono tutte da esplorare.
Sappiamo che la formazione delle società capitalistiche più evolute è il frutto di un lungo processo storico di transizione durato alcuni secoli. Non si comprende per quale magia la costruzione compiuta del socialismo su scala mondiale, e segnatamente nei paesi più arretrati, dovrebbe avvenire in tempi brevi. Altri sono i tempi della storia, e oggi lo comprendiamo meglio, sulla base dell’esperienza compiuta.
Anzi, una delle acquisizioni (autocritiche) di fondo che oggi caratterizzano in larga misura la riflessione teorica del movimento comunista in relazione al novecento (certo, col senno di poi…) è proprio quella di averlo considerato, volontaristicamente, come il secolo della crisi generale e conclusiva del capitalismo e della vittoria finale del socialismo.
Il processo di transizione al socialismo su scala mondiale si è invece rivelato, alla luce dell’esperienza storica, assai più lungo e tortuoso di quanto non fosse nelle concezioni e previsioni dei fondatori del socialismo scientifico e dei maggiori esponenti del movimento comunista del ‘900.1 quali, tutti, più o meno esplicitamente e a partire da concezioni e strategie molto diverse, ritennero che il 20° secolo avrebbe visto la crisi risolutiva del sistema capitalistico e la vittoria del socialismo su scala mondiale (chi attraverso la competizione pacifica, chi attraverso la rivoluzione nel “terzo mondo’’, chi attraverso un nuovo conflitto mondiale): con una sottovalutazione, alla prova dei fatti, delle potenzialità espansive e di auto-regolazione del sistema capitalistico e una sopravvalutazione delle potenzialità delle prime esperienze storiche di transizione [6].
“Adesso possiamo dire che Marx sottovalutò le possibilità di autosviluppo del capitalismo, il quale è riuscito ad assimilare le conquiste della rivoluzione tecnico-scientifica e a dare vita a strutture economico-sociali in grado di assicurargli vitalità e di creare nei paesi capitalistici sviluppati un livello relativamente alto di benessere per la maggioranza della popolazione. Ciò, naturalmente, non ne elimina le profonde contraddizioni interne.
Marx fu il primo che vide le enormi potenzialità di sviluppo nel progresso tecnico-scientifico, nella trasformazione della scienza in una diretta forza produttiva e sociale, ma non potè prevedere che la rivoluzione tecnico-scientifica futura sarebbe potuta diventare una nuova fonte di sviluppo del capitalismo. E si comprende facilmente se si tiene conto che Marx aveva considerato le possibilità di sviluppo del capitalismo a lui noto, quello del XIX secolo. Egli non poteva prevedere la lunga coesistenza di due sistemi sociali in grandi gruppi di paesi: coesistenza che ha spinto il capitalismo all’autoperfezionamento. ad accogliere elementi significativi dell’esperienza socialista nella sfera economico-sociale (intervento dello Stato in economia – ndr), alla democratizzazione dell’ordinamento politico; il che, nel complesso, gli ha consentito di acquisire forze supplementari e di adeguarsi alle sfide del tempo”(Pravda, 26.11.1989) [7].
21. La transizione va dunque intesa come un lungo processo storico, ricco di fasi intermedie di avanzata e arretramento (per cui di grande interesse in relazione al futuro del socialismo sono oggi esperienze non subalterne all’imperialismo e al neo-liberismo, come ad es. quella del Venezuela, oltre a quelle che esplicitamente si richiamano a una prospettiva socialista).
Va superata l’idea di una società socialista come cristallizzazione di una fase intermedia ma conchiusa della transizione, con proprie leggi generali staticamente intese, sempre più omogenea e priva al suo interno di contraddizioni anche antagoniste, così come per decenni – soprattutto negli anni ‘60-70 – il socialismo sovietico (con un approccio assai poco marxista) ha rappresentato se stesso, coniando per sé – nell’era brezneviana – la nozione di “società socialista sviluppata”.
22. Per quanto sia problematico fare delle previsioni (chi avrebbe potuto, 20 anni fa, prevedere l’ampiezza, la radicalità e la rapidità dei sommovimenti che di lì a poco avrebbero investito i paesi del “socialismo reale”?), è credibile ritenere che il sistema capitalistico abbia prolungalo di molto la propria soglia storica di sopravvivenza (Fide! Castro). Per cui la fase non contingente che si apre innanzi a noi non si presenta come quella della crisi generale e conclusiva del capitalismo (né, peraltro, come quella di una sua stabilizzazione organica e permanente), bensì come una lunga e complessa fase di acuti conflitti sociali e politici, in cui gli ineludibili antagonismi di classe e di sistema continueranno ad operare e ad intrecciarsi con esigenze e possibilità nuove di costruzione di equilibri più avanzati.
La capacità dei comunisti e delle forze che in vario modo si richiamano al socialismo di affermarsi come le più conseguenti nell’indicare le soluzioni migliori alle grandi contraddizioni che minacciano il futuro dell’umanità, è oggi la via attraverso cui la classe operaia, nei singoli paesi e su scala mondiale, può conquistare una funzione dirigente e ritrovare la propria peculiarità di “classe generale” che, lottando per liberare se stessa, non si rinchiude in un orizzonte corporativo, ma indica all’umanità intera le nuove frontiere della propria liberazione.
Il problema fondamentale è quello di chi guiderà nei prossimi decenni la crescente interdipendenza delle relazioni mondiali, se i gruppi dominanti dell’imperialismo americano (da soli o in “condominio” con altre grandi potenze imperialiste), o se invece saprà crescere una convergenza internazionale di forze progressive, popoli, Stati non omologati al dominio imperialistico, capaci di incidere e condizionare l’evoluzione del mondo. Per non parlare della eventualità di scenari assai più catastrofici, da terza guerra mondiale, che non possono essere aprioristicamente esclusi.
23. Nella lotta per il socialismo, centrale e ineludibile – per chi effettivamente si proponga di costruire una società alternativa – rimane anche oggi la questione del potere politico, come già indicarono con chiarezza le elaborazioni di Marx, Lenin e Gramsci. Appaiono poco convincenti in proposito correnti di pensiero che anche a sinistra vorrebbero considerare “superata” tale questione (come in alcuni scritti del subcomandante Marcos o di alcuni intellettuali no global come l’irlandese John Holloway, autore del libro che emblematicamente si intitola: “Cambiare il mondo senza prendere il potere”).
Si possono e si devono discutere le modalità con cui, nel corso del 20° secolo, si sono concretamente manifestate le forme del potere politico e istituzionale nelle diverse esperienze di costruzione del socialismo. E si devono pure continuamente approfondire e attualizzare, come ci suggerisce la lezione di Antonio Gramsci, le questioni inedite riguardanti la conquista e la gestione di un potere politico di tipo socialista “in Occidente”, nelle società capitalistiche più sviluppate, dove mai si sono affermati vittoriosamente rivoluzioni e poteri statuali orientati al socialismo.
Va ripresa dunque la fondamentale indicazione gramsciana, per cui – nelle società capitalistiche più sviluppate – lo Stato è un intreccio inestricabile di società politica e società civile, di forza e consenso, di dittatura ed egemonia. Dove la conquista del potere politico e la sua gestione non sono riducibili al controllo degli apparati militari, repressivi e burocratici dello Stato, né alla questione di chi controlla il governo e i fondamentali mezzi di informazione (questioni che pure non possono essere eluse), bensì comportano un lungo e preliminare processo di conquista di “trincee” e “casematte” nell’ambito della società civile, su cui fondare – quando le circostanze storico-politiche la rendano possibile – la conquista degli apparati statuali “in senso stretto”.
In ciò risiede una delle ragioni fondamentali per cui non è scolastico né retorico parlare di “attualità” del leninismo e del pensiero di Gramsci in materia di Stato e potere politico.
24. La crescente interdipendenza delle relazioni economiche internazionali (mercato mondiale) rende oggi improponibile l’idea del “socialismo in un solo paese”, che pure ha avuto storicamente il suo ruolo propulsivo, al di là delle forme concrete e dei metodi (certamente discutibili) in cui quella linea si espresse sotto la direzione di Stalin (che cosa avrebbero dovuto fare altrimenti i dirigenti bolscevichi di fronte al riflusso della rivoluzione in Occidente: arrendersi?).
Il punto di partenza di ogni rivoluzione socialista, di ogni conflitto sociale e di classe resta nazionali le, anche oggi; il potere politico continua a esprimersi in primo luogo nelle forme dello Stato nazionale, ma non è possibile, certo assai meno di ieri, una sua sopravvivenza autarchica.
Sempre più necessaria diventa la formazione di convergenze economiche e politiche nel quadro di entità almeno regionali, per poter esprimere una massa critica sufficiente per non essere schiacciati dalle “compatibilità” del mercato mondiale. Se ciò è vero per grandi paesi-continente, già pervenuti ad un grado elevato di industrializzazione, come ad esempio Cina e India, lo è ancor più per i piccoli paesi (il Vietnam e la Corea non potrebbero sopravvivere in una prospettiva socialista senza una contiguità con la Cina; l’indipendenza di Cuba, non a caso sempre più minacciata dopo il crollo dell’Urss, è strettamente connessa allo sviluppo di forti relazioni continentali col Venezuela bolivariano, con il Brasile di Lula…oltre che al sostegno che anch’essa trae dalle forti relazioni economiche e politiche con la Cina).
in un mercato mondiale sempre più integrato, ciò delinea – per una lunga fase – un processo di transizione verso il socialismo sulla base di un’economia mista, sia all’interno dei singoli Paesi che nelle loro relazioni internazionali.
Ciò non significa che tutti arriveranno insieme al socialismo (lo sviluppo resta diseguale), né deve indurre a negare la possibilità di singole vittorie nell’ambito di rivoluzioni nazionali. Ma sempre meno ogni rivoluzione nazionale, ogni potere politico nazionale orientato in senso antimperialista, anti-liberista, può ignorare i condizionamenti di un mercato mondiale in cui il capitalismo è e rimarrà per un periodo non breve forza dominante.
Non si può dunque eludere la competizione economica e tecnologica in campo aperto col capitalismo, nei singoli paesi e mondialmente.
Ciò comporta dei rischi, ma la sfida è ineludibile, non conosce durevoli alternative autarchiche nel mondo di oggi. Anche Paesi come Cuba o la Corea del Nord, tra loro peraltro diversissimi, ma accomunati da una certa diffidenza nei confronti delle riforme economiche in Cina e in Vietnam, sono costretti a tenere conto di tali esigenze, sia pure con approcci di politica economica assai più prudenti rispetto alla sperimentazione cino-vietnamita.
Ritorna e si impone per tutti il tema della centralità dello sviluppo delle forze produttive (parliamo ovviamente di sviluppo sostenibile, un criterio ormai universalmente acquisito in ambito progressista).
25. Condizione necessaria, ancorché non sufficiente, di una strategia alternativa alla mondializzazione capitalistica è un recupero sia pure parziale di sovranità degli Stati nazionali, in primo luogo in campo economico, con la difesa (o il ripristino) e la qualificazione di un forte settore pubblico, capace di orientare le scelte fondamentali del mercato interno e le relazioni col mercato mondiale.
Una strategia alternativa avanza quando, prima di tutto all’interno delle singole nazioni, si determinano equilibri sociali, politici, statuali più favorevoli alle classi popolari, con un potere politico non subalterno all’imperialismo.
In questo quadro, la difesa intransigente delle risorse nazionali e dei settori pubblici dell’economia assume un carattere di resistenza e di controtendenza alla espansione e alla penetrazione imperialistica, anche quando ciò si manifesta da parte di governi e poteri statuali che esprimono in tutto o in parte gli interessi di borghesie nazionali e di élites politico-militari (penso a contesti peraltro assai differenziati come la Siria, l’Iran, il Brasile di Lula, il Sudafrica e buona parte dei paesi dell’Africa australe, l’india democratica e non allineata, la stessa Russia di Putin …).
26. La difesa della sovranità nazionale, ripetiamo, non può affermarsi nel quadro di una impossibile autarchia. Essa suppone, al contrario, una fitta rete di relazioni tra Stati sovrani, con accordi tra settori e imprese pubbliche (o miste) dei rispettivi Paesi, volti a costruire entità economiche integrate a vello sovranazionale, capaci di reggere l’urto e di esercitare un parziale elemento di contrappeso al predominio delle multinazionali private.
Si pensi, per fare un esempio, ai molteplici accordi per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio e del gas naturale che, a vari livelli, coinvolgono imprese pubbliche o miste di nazionalità russa, cinese, vietnamita, algerina, cubana, venezuelana, brasiliana, (ieri) irakena, iraniana, libica, kazacha, siriana…(una sorta di attualizzazione della filosofia di Enrico Mattei).
Si pensi ai progetti di accordo proposti dal Venezuela di Chavez al Brasile e ad altri paesi della regione per la formazione di un polo pubblico integrato su scala continentale per lo sfruttamento e la commercializzazione delle risorse energetiche, i cui introiti servano anche a finanziare l’attività di una banca continentale per lo sviluppo e una emittente televisiva pan-latino-americana, in grado di rivaleggiare con la CNN (una sorta di AlJazeera bolivariana). Si tratta di un progetto (fortemente incoraggiato da Cuba) che riprende in parte ed amplia una vecchia idea di Gheddafi, per la costituzione di una banca mondiale per il sostegno ai Paesi in via di sviluppo, promossa dai paesi produttori di petrolio non subalterni all’imperialismo, al fine di creare un circuito finanziario autonomo dal FMI e dalla Banca Mondiale.
Il principio ispiratore è quello di stabilire accordi tra Stati sovrani e tra le rispettive imprese pubbliche o a partecipazione statale per dare vita a relazioni e a forme democratiche di cooperazione e/o integrazione non subalterne alle grandi potenze imperialiste, in grado di pesare in modo autonomo sui processi mondiali.
“Propongo – ha scritto in proposito Samir Amin – che si dia la priorità alla costruzione di grandi unità regionali”; e ad una rete di relazioni tra esse capaci di rappresentare un contrappeso, o quanto meno un fattore di condizionamento nei confronti della Triade (Usa, Ue, Giappone), facendo leva anche su fattori crescenti di competizione interimperialistica. La formazione cioè di entità regionali dirette da “blocchi egemonici popolari, nazionali e democratici”, in grado di condurre “grandi negoziati internazionali, capaci di organizzare un’interdipendenza controllata al servizio dei popoli”, con elementi di controllo e di correzione delle politiche dominanti.
27. Quali sono, nell’analisi di Samir Amin, queste “grandi unità regionali” che possono rappresentare le forze motrici di una strategia alternativa?
Alcune sono singole nazioni che, per le loro dimensioni e potenzialità, corrispondono a veri e propri continenti:
- la Russia e tutta l’area ex sovietica, dove sono in atto processi sociali e politici dove possono affermarsi o consolidarsi direzioni politiche non subalterne al nuovo ordine mondiale imperialista (come ad es. in Bielorussia);
- la Cina, governata dal più grande partito comunista del mondo;
- l’India, paese in cui persistono forti spinte al non allineamento e a un modello di sviluppo non liberista e non subalterno ai centri dominanti dell’imperialismo. ,
Il graduale affermarsi di una “partnership strategica” tra Russia, Cina e India, in campo economico, politico e militare (potenze nucleari medio-grandi, che l’amministrazione Bush definisce significativamente “Paesi dalla transizione incerta”), può determinare la formazione di un grande polo euro-asiatico, non subalterno all’imperialismo.
Vi sono poi altre “unità regionali” – l’America Latina (si pensi al ruolo propulsivo di paesi come Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasile…), il mondo arabo e islamico, l’Africa (in particolare il coordinamento dei paesi dell’Africa australe, raccolti attorno al nuovo Sudafrica) – dove “nessun paese ha sufficiente peso per opporsi da solo alle pretese della mondializzazione capitalista”, ma dove i processi di integrazione regionale possono vedere un ruolo incidente di forze progressiste e di “blocchi popolari, nazionali e democratici”, in grado di raggiungere la massa critica sufficiente per pesare sugli equilibri globali.
L’emergere, a Cancun (vertice WTO) e dopo Cancun di una crescente convergenza nella politica mondiale del cosiddetto G20 (imperniato su Cina, India, Russia, Brasile, Venezuela, Sudafrica: una nuova stagione della cooperazione “sud-sud”?) sembra dare consistenza a tale prospettiva.
Secondo Samir Amin, “nell’arco dei prossimi 20 anni il futuro dipenderà principalmente da ciò che accadrà nella regione Europa (Russia inclusa) e nella regione Cina”.
28. Sarà possibile – come scrive Samir Amin – che “in un orizzonte di 20 anni, si possa sedimentare un progetto europeo, sociale e di sinistra”, capace di coinvolgere l’insieme del continente”?
Il discorso sull’Europa va approfondito. Il processo di integrazione in corso nell’unione europea (che riguarda solo una parte del continente) avviene su basi neo-imperialiste, sia nella variante prospettata dalle forze più conservatrici, che in quella “social-liberale” e comunque euro-atlantica prospettata dalla maggioranza della socialdemocrazia. Il che ne fa un processo di integrazione regionale assai diverso da quelli in corso in America Latina, in Africa, in Asia, che non avvengono su basi neo-imperialiste, anche se in molti casi non configurano “alternative di sistema” (Brasile, Sudafrica, Asean…).
La presenza nell’Ue di spinte ad una maggiore autonomia dagli Usa (asse franco-tedesco, linea Prodi, ecc…) avviene sul terreno della “solidarietà transatlantica” e di una competizione tra imperialismi (per quanto non egualmente pericolosi), non sul terreno di una fuoriuscita dalla logica imperialista, come si è visto ad esempio nella guerra contro la Jugoslavia, su cui rarissime sono le autocritiche in ambito socialdemocratico e che la grande maggioranza della socialdemocrazia europea ancora rivendica. 0 come ancora si è visto nell’atteggiamento dell’UE (senza apprezzabili differenze tra schieramenti di centro-destra e centro-sinistra, e con rare eccezioni) nei confronti di Cuba, Ucraina, Bielorussia, Iran, Israele, Palestina…
Una alternativa in Europa equiparabile a quella perseguita dalle forze progressiste in America Latina non può che avvenire in netta discontinuità col progetto Ue e con gli orientamenti oggi dominanti, di centro-destra e anche di centro-sinistra. Essa presuppone, inoltre, il coinvolgimento di tutta “la regione Europa (Russia inclusa)” se vuole avere la massa critica e la base sociale e politica per poter affermare una collocazione internazionale del continente realmente autonoma dalla Nato, dalle logiche imperialiste e di interventismo militare; e se vuole fondarsi su un progetto di società realmente alternativo al neo-liberismo. Ma un’Europa di questo tipo, come si è visto anche nel corso della vicenda Ucraina, appare un’orizzonte piuttosto lontano. Ed il progetto di “un’altra Europa”, al di là della propaganda, si presenta quindi – per i comunisti – tutt’altro che risolto, non solo sul terreno della congiuntura, ma anche su quello della strategia.
29. Quale sarà l’equilibrio mondiale che potrebbe sortire da un quadro mondiale di accentuato multipolarismo e di superamento del predominio Usa? “Si tratterà – si domanda Samir Amin – di un’economia socialista o capitalista? È molto importante discuterne. A mio giudizio – scrive – si devono associare, in una relazione evidentemente conflittuale, elementi di entrambi i sistemi, imponendo un compromesso di fase tra le logiche del capitalismo e le logiche che non dipendono da esso (si possono chiamare antisistema, se si vuole)”. Compromesso dinamico e instabile, che configurerebbe “una tappa della lunga transizione dal capitalismo mondiale al sistema socialista mondiale”.
La riflessione è interessante, ed è chiaro che vi è qui materia per uno sviluppo ampio e approfondito della ricerca e della discussione.
30. Una strategia di avanzata al socialismo in questa fase storica fa dunque emergere tre priorità sul piano politico e programmatico:
- la formazione di poli pubblici produttivi, tecnologici e finanziari non autarchici, operanti nel mercato mondiale, con capacità di competizione, contrappeso e condizionamento del capitale multinazionale privato. La lotta contro i processi di privatizzazione, in alternativa al neo-liberismo, hanno un valore strategico. Porre ad esempio in Italia il problema di una forte presenza pubblica nella proprietà e nella direzione del gruppo Fiat, significa porre un problema di questa portata;
- la lotta per la pace e il disarmo: NATO, basi militari straniere, messa al bando delle armi di distruzione di massa, lotta alla guerra e al sistema di guerra, ridimensionamento del primato internazionale dell’imperialismo americano.
Condizione imprescindibile di tutto ciò (è la terza priorità, ma non in ordine di importanza) è la formazione di poteri politici nazionali, tra loro cooperanti su scala regionale e mondiale, capaci di esprimere una volontà politica non subalterna al neo-liberismo in campo economico e all’imperialismo e al suo sistema di guerra nella collocazione internazionale.
Si tratta di tre assi portanti della lotta per fare dei passi avanti verso una prospettiva di tipo socialista nelle condizioni del mondo di oggi.
NOTE
[1] ↑ Non mi convince la tesi, sostenuta nel documento preparatorio al Convegno della Rete dei Comunisti, secondo cui “il processo di accumulazione “primitiva” e accelerata che sta seguendo la Cina sembra seguire, in condizioni storiche e materiali molto diverse, lo stesso che ha seguito l’URSS con il processo di industrializzazione forzata”. Il tema richiederebbe un convegno a sé (perché no?), ma in estrema sintesi direi che il modello URSS anni ‘30 si discosta dalla NEP (per ragioni anche obbligate) e dall’ipotesi di una transizione di lungo periodo ad economia mista; mentre l’attuale modello cinese (e vietnamita) si caratterizza proprio. per esplicita ammissione dei suoi stessi protagonisti, come una sorta di NEP allargata e di lungo periodo.
Trovo invece assai condivisibile la tesi, sostenuta nel documento della Rete, secondo cui “una economia socialista, socialistica o comunque non capitalistica, fino ad oggi ha dimostrato di essere in grado di…avvicinarsi allo sviluppo capitalistico superando la barriera della arretratezza”. E che “il punto su cui invece va messo l’accento e sul quale va concentrata la riflessione, non è tanto quello del superamento della prima barriera (l’accumulazione che porta al superamento dell’arretratezza) comunque fondamentale, ma quello della seconda, ovvero quella dello sviluppo generale e della egemonia. È questo un nodo strategico ed irrisolto. Tutto ciò va affrontato con lo spirito della ricerca e del dibattito e con molta modestia, viltà la dimensione delle questioni, ma anche qui senza fare e senza farci sconti.
In conclusione sembra che riemerga con forza la questione della capacità di progettare, della soggettività e, in ultima istanza, del partito; ovviamente sempre tenendo conto del contesto oggettivo e materiale in cui tutto ciò è avvenuto ed avviene, non solo per rincorrere il capitalismo ma anche per concepire uno sviluppo produttivo, scientifico e sociale che sia in grado di superarlo”.
[2] ↑ Condivido in proposito la tesi del documento preparatorio: “Fin dalla rivoluzione del ‘17 la questione centrale per la edificazione socialista è stata quella dello sviluppo delle forze produttive. Questo nodo si è trascinato fino al secondo dopoguerra, anche nella rivoluzione cinese, ed ha prodotto nei partiti comunisti al potere dibattiti e scontri assai spesso pesanti sul come procedere in quella direzione.
La centralità di questo elemento ha però avuto la conferma storica, se ce ne fosse stato ancora bisogno, con la rivoluzione tecnico-scientifica avviata dai paesi capitalisti dalla seconda metà degli anni *70 (…) che ha ridato sviluppo e forza egemonica al capitalismo”.
[3] ↑ Scrive opportunamente in proposito il documento preparatorio: “Nel lavoro da fare forse è necessario avanzare anche una riflessione sulle modalità della transizione sociale dopo il fallimento dei paesi socialisti “filo-sovietici”. Sappiamo bene che uno degli elementi di crisi della rivoluzione bolscevica è stata la mancata rivoluzione della classe operaia nel resto dell’Europa e che questa mancata rivoluzione sia stata il frutto delle possibilità egemoniche dell’imperialismo dell’inizio ‘900 ma anche delle scelte politiche fatte dalla II0 internazionale.
Lenin a questo proposito non solo analizzò le cause strutturali, le caratteristiche del movimento operaio dell’epoca e gli effetti della sua subordinazione alle borghesie nazionali, ma comprese anche le conseguenze che una simile situazione avrebbe creato nella costruzione del socialismo, il quale in quel momento disponeva come unica base di un paese non solo arretrato (l’URSS), ma anche piegato da anni di guerra civile. Situazione successivamente ulteriormente aggravata dalla seconda guerra mondiale.
È chiaro che molto di quello che è accaduto, sia in termini concreti di costruzione di una società alternativa al capitalismo – ma anche in termini di tenuta teorica del pensiero comunista che una tale mastodontica opera richiedeva – è stato condizionato da quegli eventi che, per certi versi, si sono confermati per tutto il XX secolo.
Le rivoluzioni fatte, a cominciare da quella cinese, hanno avuto come base sociale sostanzialmente le masse rurali sfruttate e non le classi lavoratrici dei paesi avanzati; classi queste che, pur conducendo una forte lotta in alcuni paesi come ad esempio nel nostro, sono state sicuramente determinanti per modificare i rapporti di forza nella società e per la conquista di spazi democratici, ma non hanno mai raggiunto il punto di rottura rivoluzionaria, come è invece accaduto nell’allora cosiddetto Terzo Mondo.
Il fatto che a poco meno di un secolo di distanza, in presenza di una molto più forte integrazione dei sistemi produttivi, si riproponga una possibile frattura tra lavoratori dei centri imperialisti e della periferia produttiva sul piano internazionale, crediamo che ci debba spingere a riflettere non tanto e non solo sul piano della contingenza politica quanto sulle implicazioni teoriche relative ai modi della transizione possibile.
In altre parole l’avvio di un processo di trasformazione potrebbe mantenere le forme del ‘900, cioè la rottura rivoluzionaria che avviene nell’anello debole dell’imperialismo, in una condizione dove la relativa indipendenza strutturale dei paesi imperialisti del secolo passato viene meno a causa del processo in atto di integrazione mondiale e della costituzione dei blocchi economici.
Il “rischio” di trovarsi di fronte ad eventi rivoluzionari che riguardano i paesi meno sviluppati, e dunque la possibilità del riprodursi di situazioni apparentemente note, è sicuramente un elemento da inserire nelle nostre elaborazioni e nel dibattito anche perché i segni che vanno in questa direzione si stanno manifestando concretamente”.
[4] ↑ Condivido in proposito pienamente la tesi avanzata nel documento preparatorio: “È evidente come la legge del valore ed il mercato capitalistico siano strettamente collegati e siano stati per tutto il ‘900 condizione immanente e parte consistente dei problemi e delle contraddizioni nella costruzione dell’URSS, dei paesi socialisti e della Cina rivoluzionaria. Il comunismo di guerra, la NEP, la collettivizzazione di Stalin, i modelli misti del secondo dopoguerra fino alla politica odierna del Partito Comunista Cinese, sono stati tutti costretti a misurarsi direttamente o indirettamente con la legge del valore che soprassiede nel capitalismo agli scambi mercantili.
Tale questione, che oggi si ripropone con ancora più forza, ci obbliga a fare i conti con il passato ma anche con le prospettive e non può essere rimossa d’ufficio. Questa è di fatto un elemento di valutazione importante anche perché abbiamo imparato a nostre spese come siamo ben dentro una fase storica di transizione e non all’attuazione del socialismo e tanto meno del comunismo”.
[5] ↑ Secondo il Sole-24 ore (22 aprile 2006), “la scalata della Cina alla graduatoria delle potenze economiche mondiali sta bruciando le tappe. Gli strateghi americani all’inizio del decennio credevano vi fosse davanti ancora un ventennio di indiscussa supremazia statunitense. Quel lasso di tempo appare più che dimezzato. Il PIL cinese (calcolato a parità di potere d’acquisto, ovvero in termini di ricchezza reale, al di là delle variazioni legate ai cambi valutari, ai prezzi nominali delle merci sui mercati interni piuttosto che su quelli esteri -NDR) già nel 2005 ha superato, con 9.406 miliardi di dollari, quello di tutta Eurolandia, ferma a 9.040 miliardi. Il sorpasso è “nascosto” in una tabellina dell’appendice del World economie Outlook dell’FML.In testa restano gli USA, con una quota del 20,1% (12.277 miliardi), seguiti a distanza dalla Cina con il 15,4%, eppoi l’eurozona con il 14,8%. Nel 2004 le posizioni tra i Dodici e il “dragone” asiatico erano invertite, con il PIL dell’area euro in vantaggio di 365 miliardi.
Ai ritmi di crescita medi dell’ultimo decennio, nel 2010 la Cina sopravanzerà anche gli USA, portandosi a quota 19,2% del PIL globale (con 14.499 miliardi), contro il 19% americano (14.413). Proseguendo la sua corsa, nel 2014, tra appena otto anni, doppierà per stazza economica l’attardata Eurolandia”.
Va detto comunque che altre stime (a partire da quelle cinesi ufficiali) sono assai più caute in relazione ai tempi del “sorpasso” della Cina, che viene proiettato in avanti di alcuni decenni. E non si sfugge all’impressione che dietro alla girandola delle cifre si nascondano differenti esigenze propagandistiche: quelle Occidentali, volte ad enfatizzare il “pericolo giallo”, quelle cinesi volte al contrario a tranquillizzare le opinioni pubbliche e le stesse classi dirigenti dei Paesi capitalistici più sviluppati.
Nell’ottobre 2003 l’americana Goldman Sachs – dal 1869 una delle maggiori banche d’investimento al mondo – ha pubblicato uno studio (cit. in Salvatore Minolfi, Giano, n.49, 2004), dove il raffronto tra il PIL dei diversi Paesi viene calcolato non in termini di ricchezza reale e a parità di potere d’acquisto, ma in termini di valore delle merci sul mercato internazionale (un criterio che dunque sottostima il valore reale della produzione di merci e servizi nei Paesi in Via di Sviluppo: a Pechino con un dollaro si compra molto più riso o pane che a New York…). Ebbene, stante quel diverso criterio adottato, se ne ricaverebbe comunque che la Cina dovrebbe superare gli USA attorno al 2040. E che i Paesi del BRIC (acronimo composto dalle iniziali di Brasile, Russia. India e Cina), che nel 2003 rappresentavano insieme appena il 15% delle economie del G6 (non conteggiato il Canada), nel 2040 pareggerebbero il conto e nel 2050 supererebbero del 20% il PIL dei Paesi del G6 (ovvero: 40% il G6, 60% i BR1C, sul totale di entrambi). La sproporzione sarebbe assai più rilevante se il calcolo fosse fatto, come nei calcoli del FMI, a parità di potere d’acquisto. In base al quale già nel 2006 i BRIC esprimono il 26,5% del PIL mondiale, più della metà del G6 (41,1%), mentre nel calcolo della Goldman Sachs (2003) ne esprimerebbero poco meno di un settimo. Dunque, ricalcolate approssimativamente le proporzioni sulla proiezione al 2050, ne deriverebbe che alla metà del secolo la ricchezza reale dei BRIC sarebbe di gran lunga maggiore di quella del G6: un’autentica rivoluzione degli equilibri mondiali. Tale da indurre il citato Salvatore Minolfi a titolare il suo saggio: “Il declino del capitalismo occidentale: una proiezione al 2050”.
[6] ↑ La questione è ben richiamata nel documento preparatorio: “La storia del movimento comunista, pur nelle sue molteplici varianti. ha seguito una tendenza alla crescita che va dalla rivoluzione del 1917 fino di fatto alla metà degli anni ‘70…Si era generalmente affermata in quei decenni l’idea che “l’assalto al cielo” potesse riuscire e che per il fronte anticapitalistico fosse quasi a portata di mano la trasformazione socialista.
Come sappiamo bene così non è stato, e non lo è stato non solo per motivi politici ma fondamentalmente per motivi strutturali relativi sia alla possibilità per il capitalismo di tenere e rilanciare sullo sviluppo, sia ai limiti della concreta esperienza storica in costruzione del movimento operaio e comunista.
Poiché questo è oggi un dato di fatto evidente a tutti, se non si vuole rinunciare ad una prospettiva di cambiamento sociale, la lettura alternativa alla liquidazione di tale prospettiva è quella secondo cui la transizione dal capitalismo a nuove forme sociali ricopre una intera fase storica, dove possono intervenire anche momenti forti di rottura rivoluzionaria ma dentro un processo nel quale le spinte contro il cambiamento non solo non sono affatto eliminate ma hanno già dimostrato di poter riprodurre una egemonia che fino agli Settanta appariva in rotta.
Non si tratta qui di reintrodurre un gradualismo socialdemocratico,… ma di capire che siamo di fronte ad una situazione di estrema complessità, la quale richiede un alto livello teorico delle capacità soggettive che devono essere in grado di interpretare ed affrontare quella complessità sociale prodotta proprio dall’attuale sviluppo del capitalismo.
Se confrontiamo questo dato di fatto oggettivo – a meno che non si ritenga che ci siano rotture rivoluzionarie a breve – con la visione del movimento comunista del secolo passato, la differenza è evidente e mostra i limiti di quella concezione. Infatti il dare per acquisita la prospettiva e la possibilità irreversibile del socialismo, era la convinzione profonda che c’era in tutte le componenti del movimento comunista ed antimperialista, ed ha significato incorrere in un vero e proprio errore teorico”.
[7] ↑ Ecco come alcune di queste questioni venivano poste una ventina di anni or sono, prima del crollo dell’Urss. in un saggio di K. Tsagolov, docente all’Accademia Militare di Mosca (La vie internationale, n. 12. 1988):
“È particolarmente importante definire oggi il carattere e i ritmi dello sviluppo del processo rivoluzionario mondiale. I classici del marxismo avevano previsto la possibilità di flussi dell’ondata rivoluzionaria mondiale, con fasi di accumulazione quantitativa e fasi di esplosione qualitativa. Dopo l’impulso rivoluzionario del grande Ottobre, che si è ripercosso in tutti i continenti, abbiamo avuto un periodo di relativa stabilizzazione. La seconda ondata si è manifestata durante e dopo la seconda guerra mondiale, con la formazione di un sistema socialista mondiale e il crollo dei sistemi coloniali. Ma alla fine degli anni ’70 abbiamo assistito ad un riflusso dell’ondata rivoluzionaria e gli anni ‘80 hanno mostrato che l’onda alta è ormai passata. Quali sono le cause? Innanzitutto la rivoluzione tecnico-scientifica, le cui conseguenze a lungo termine non sono oggi prevedibili, che ha permesso al capitalismo. soprattutto nelle sue metropoli, di innalzare bruscamente la propria soglia di sopravvivenza, di rinviare ad una scadenza indeterminata la propria fine storicamente inevitabile. Il capitalismo ha ritrovato un secondo soffio vitale, si è rivitalizzato con i risultati del progresso tecnologico e ha cominciato a reagire con molta più elasticità ai problemi sociali della società borghese contemporanea. In secondo luogo, il socialismo non ha saputo, non ha potuto, a causa dell’impatto di diversi decenni di processi deformanti, sviluppare interamente le sue potenzialità; non ha saputo dare l’esempio di un più allo livello di produzione materiale e di democrazia, e tutto ciò ha danneggiato l’immagine del socialismo davanti agli occhi di grandi masse.
(…) L’ottenimento di un livello di produzione materiale superiore a quello del capitalismo, lo sviluppo della democrazia e l’eliminazione dalla nostra vita di tutto ciò che vi era e vi è di pseudo-socialista, sono le condizioni necessarie per il pieno ristabilirsi della capacità di attrazione del socialismo. Fino a che noi non saremo capaci di assicurare la superiorità sul capitalismo nella sfera decisiva, quella della produzione materiale, noi non potremo immaginare una nuova onda montante del processo rivoluzionario mondiale. È dunque tempo di porre la questione: disponiamo oggi noi comunisti di studi scientifici sufficientemente fondati che ci diano la chiave per l’elaborazione di una strategia e di una tattica, nazionale e internazionale, da attuare in una fase di riflusso dell’ondata rivoluzionaria mondiale? Credo di no, e il dovere della scienza e della teoria marxista è di colmare questa lacuna nella teoria affinché essa possa essere colmata anche nella pratica. Si tratta di un compilo a cui dobbiamo accingerci con grande urgenza”.