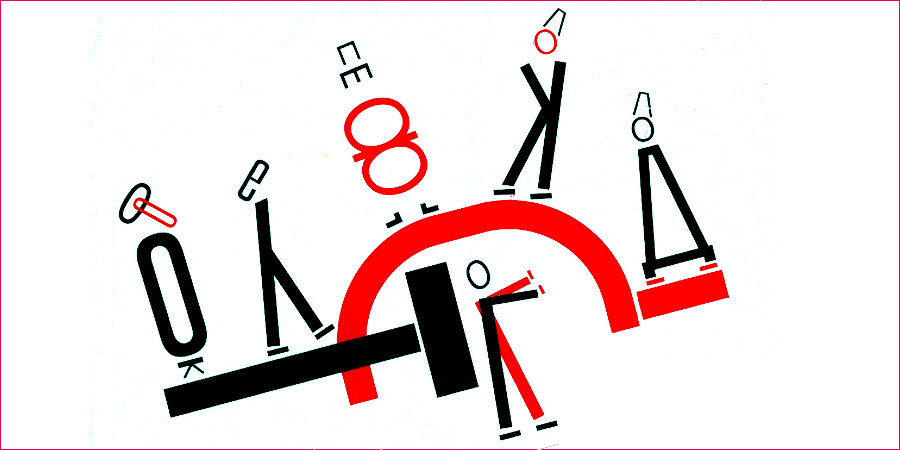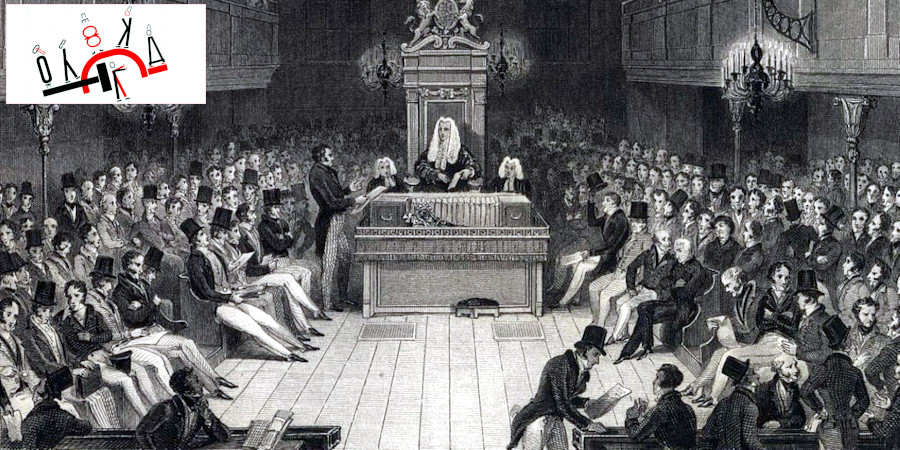dal Documento politico per la 3ª Assemblea Nazionale della Rete dei Comunisti – Roma 2-3 aprile 2011
L’Europa che è bene intendere come area geopolitica, ben al di là del recinto comunitario dell’Unione Europea, è attraversata da significative convulsioni finanziarie, economiche e sociali che stanno riverberando – con effetti diversificati e differenzianti – nei vari paesi.
L’agire della crisi economica globale ed i problemi finanziari – dalla Grecia, all’Irlanda fino agli allarmi in Spagna, in Portogallo e quelli paventati in Italia – stanno mettendo alla prova il funzionamento dell’unione economica e monetaria in Europa, a partire dalla sua istituzionalizzazione ufficiale con il trattato di Maastricht del 1992 e proseguita, poi, con il varo dell’Euro.
Il meccanismo di concertazione e di funzionamento comunitario sta mostrando, ancora una volta, tutti i limiti e le difficoltà nel riuscire a pervenire, entro brevi termini, ad una posizione ed un fronte comune in grado di soddisfare le priorità e le esigenze di tutti i paesi membri. A distanza di oltre un decennio dalla sua istituzionalizzazione possiamo affermare che, prima di tutto, l’Unione Europea, al di là dell’ottimistica facciata propagandistica, non si è rivelata in grado gestire al meglio questo tornante della crisi il quale sta mostrando tutti gli snodi strutturali ancora irrisolti. In secondo luogo l’Unione Europea si va conformando sempre più come un polo imperialista intorno al nucleo duro franco-tedesco con una posizione preminente della Germania.
Il ritardo con cui gli esponenti dei poteri forti europei stanno giungendo, almeno fino ad ora, a decisioni effettive non sta facendo altro che incentivare la speculazione sui mercati, aggravando ulteriormente il quadro economico e finanziario dell’UE e mostrando le difficoltà di un blocco capitalistico, relativamente ancora solido sul piano economico ma ancora troppo debole sul versante prospettico e generale.
Un gap che risiede nella lentezza del processo di concentrazione e centralizzazione finanziario e politico e che mostra le debolezze di alcuni territori e paesi membri percepiti, sostanzialmente, in questo attuale periodo di marasma economico internazionale, come pesi e zavorre da normalizzare e disciplinare ad ogni costo anche attraverso terapie shock.
In questa nuova condizione oggettiva, per non penalizzare ulteriormente, il profilo complessivo dell’Unione i settori più avanzati della borghesia continentale (quelli tedeschi e francesi in particolare) stanno intensificando i loro deliberati normativi verso un più serrato controllo e blindatura di tutti i dispositivi d’indirizzo e di comando finanziari con l’obiettivo di evitare, ai singoli paesi, sforamenti e splafonamenti che potrebbero rivelarsi difficili da gestire o addirittura fuori controllo.
Siamo – dunque – in presenza di un significativo ed evidente cambio di passo verso cui si stanno orientando tutti i principali provvedimenti dell’Ecofin e degli altri organi di vigilanza sovranazionali i quali stanno approntando, sotto l’incalzare delle ripetute scosse finanziarie, provenienti da quell’autentico ottovolante rappresentato dal ciclo dell’ economia globale capitalistica, una sorta di nuova governance europea in grado, o quanto meno con la speranza, di tentare di controllare la speculazione e addrizzare, alla greca, le economie degli stati nazionali (…tra cui anche l’Italia) ritenute poco affidabili.
Paradossalmente l’Unione Europea può trovare nuove energie proprio dal manifestarsi della crisi. In primo luogo costringendo i paesi aderenti dentro i rigidi parametri economici e aumentando la capacità di controllo e sanzione degli organismi comunitari. In secondo luogo avviando un processo di omogeneizzazione/gerarchizzazione delle diverse borghesie tra le quali spiccano il ruolo della Germania e in secondo ordine della Francia.
L’egemonia di queste due borghesie si manifesta anche nel ruolo economico internazionale che intendono affidare all’Unione Europea ovvero la costruzione di un polo imperialista con una moneta competitiva verso il dollaro, un sistema finanziario stabilizzato, una produzione qualificata e tecnologicamente avanzata complementare alle economie della periferia produttiva (i cosiddetti BRIC) che rafforzano il ruolo strategico dell’Europa.
Questi avvenimenti e le relative dinamiche sociali che suscitano disvelano l’essenza concreta della natura imperialista dell’Unione Europea e fanno evaporare, definitivamente, le suggestioni che, a vario titolo anche a “sinistra”, si sono alimentate, nel corso degli ultimi decenni, circa la possibile natura diversa e/o sociale di una Unione la quale, fin dai suoi fondamentali, ha mostrato costitutivamente i caratteri antipopolari e neo/colonialisti di questa matura soglia politica, economica e militare del capitalismo e delle sue classi dominati continentali.
Emergono tutti i limiti del capitalismo “tricolore”
E’ palese, quindi, che nel rapporto con questo contesto l’Italia e la borghesia italiana stanno mostrando tutti i limiti derivanti da retaggi storici e da una molteplicità di difficoltà strutturali ascrivibili non solo all’attuale congiuntura politica ma rintracciabili nella storia del complesso e relativamente giovane processo di formazione dello stato nazionale unitario.
Una tipicità che si è riverberata, più volte, nel percorso di costruzione, sedimentazione e di espansione del moderno capitalismo tricolore non solo sul territorio italiano ma anche nelle varie proiezioni all’estero sia sul terreno squisitamente commerciale ed economico ma anche sul piano della partecipazione alle varie aggressioni militari nei quadranti di crisi (Corno d’Africa, Balcani, Iraq, Afghanistan, Libano) Fin quanto ha potuto il padronato italico, specie quello innervato nelle zone territoriali cosiddette dinamiche, è riuscito – a fronte delle difficoltà di azione come capitale unitario nazionale – a fare di necessità virtù di ogni situazione particolare e contingente.
Persino elementi di oggettiva debolezza della configurazione del sistema industriale e finanziario italiano, nella fase in cui la Lira era avvantaggiata nel differenziale di cambio con le altre divise monetarie, erano diventati, paradossalmente, fattori di dinamicità del capitalismo piccolo piccolo i quali, nonostante tutto, garantivano, comunque, ampi margini di profittabilità e di riproduzione ad un fondamentale segmento dell’imprenditoria.
Con l’avvento dell’Euro, con il completamento del ciclo di ristrutturazione del vecchio assetto fordista della produzione, con l’emergere dei nuovi competitori dentro e fuori dell’area europea e – soprattutto – con l’immanenza della crisi economica questo status quo è stato messo in discussione.
In Italia, e le cronache di questi ultimi mesi stanno a dimostrarlo, si stanno ripresentando, di nuovo, tutti gli snodi cruciali che afferiscono ai caratteri peculiari della borghesia e ai suoi irrisolti problemi storici ed immediati.
E’ la crisi della borghesia italiana
La struttura arretrata e frammentata del modello produttivo italiano, sta rivelando la marginalizzazione dell’Italia dalla competizione globale. Del resto questo scenario appare inevitabile in una realtà dove su 4 milioni e 400mila imprese ben 4milioni e 170mila sono imprese con meno di 9 dipendenti e solo 3.400 aziende hanno più di 250 lavoratori.
I padroni italiani hanno sempre potuto contare sui salari più bassi nei paesi industrializzati, sulla complicità statale attraverso l’evasione fiscale tollerata e utilizzata come vero e proprio strumento di accumulazione primitiva – vedi il boom del Nordest – hanno potuto contare su una delocalizzazione selvaggia agevolata dal sistema fiscale – vedi il Traffico di Perfezionamento Passivo – ma sono andati in crisi quando l’entrata in vigore dell’Euro ha messo fine alle svalutazioni competitive sulla Lira e quando il patto di stabilità europeo ha imposto parametri più rigidi sulla fiscalità e le entrate nei bilanci pubblici. L’entrata in campo dei competitori a basso costo sui prodotti a scarso valore aggiunto –vedi la Cina – ha poi rivelato tutta la debolezza del sistema produttivo italiano che era cresciuto comprimendo al massimo soprattutto il fattore lavoro senza nuovi investimenti. I profitti ottenuti sfruttando il lavoro sono stati investiti soprattutto nel settore finanziario, nelle utilities e nella speculazione immobiliare. Ciò ha creato in Italia una sorta di capitalismo senza borghesia, una classe dominante che è prosperata solo sugli appalti pubblici, le società di gestione dei servizi pubblici (luce, gas, etc.), la rendita e la speculazione, l’economia extralegale, ma la rapacità dei prenditori (chiamarli imprenditori sarebbe un eufemismo) e la complicità dello Stato, hanno fatto sì che la marginalizzazione dell’Italia nella competizione globale sia oggi evidente agli occhi di qualsiasi osservatore.
Nel contesto della competizione globale, le classi dominanti – sia dal punto di vista imprenditoriale che politico – sembrano non avere neanche la capacità di gestire il declino e la marginalizzazione dell’Italia dai punti alti dello sviluppo capitalistico. La grande borghesia italiana (ininfluente però a livello di massa) punta all’integrazione dell’Italia nella grande borghesia europea che è venuta definendosi con il processo che ha portato alla costituzione dell’Unione Europea e dell’Eurozona.
La struttura produttiva dell’Italia e la stessa figura di Berlusconi contrastano con l’obiettivo di agganciare l’Italia ai punti forti di Francia e Germania e ostacolano tale progetto. A questo punta invece il Terzo Polo (una moderna destra europea), ma a questo appare subalterno anche l’intero impianto ideologico delle forze della sinistra emerse nella cosiddetta Seconda Repubblica. Costoro hanno infatti introiettato e veicolato per anni una idea progressiva dell’Europa come indispensabile strumento della modernizzazione capitalistica in Italia. Un’idea smentita sistematicamente dai fatti, dalla natura imperialista dell’Unione Europea e dal carattere antipopolare delle sue scelte concrete.
Diversamente, il blocco sociale berlusconiano è rappresentativo e consapevole dell’arretratezza della borghesia e del capitalismo italiano che questa ha prodotto ((piccole e micro imprese, capitalisti appaltatori e bollettari, imprenditori “criminali” etc). Nella competizione globale e nella relazione con la strategia della borghesia europea esso può avere solo un ruolo marginale e parassitario. Ragione per cui il berlusconismo alimenta l’idea che è meglio essere primi tra gli ultimi (intendendo con gli ultimi anche paesi non del tutto marginali come Russia, Turchia, Libia, il Maghreb, i paesi dell’Europa dell’Est, i PIGS europei etc.). Questo spiega la spregiudicata politica estera seguita da Berlusconi dominata dal criterio del business più che da criteri geopolitici, strategici, diplomatici, un disegno questo che ha fatto inquietare non poco gli Stati Uniti e messo in difficoltà l’Unione Europea.
Il modello Marchionne spiazza i vecchi equilibri
In Italia dunque i gruppi capitalistici più internazionalizzati sono pochi e per molti aspetti ininfluenti sul piano politico (dove invece è più forte il blocco sociale berlusconiano/leghista).
Marcegaglia, Fini, Bonanni, Camusso, Veltroni si sforzano con ogni mezzo di decretare la fine del conflitto tra capitale e lavoro e rilanciano l’idea mefitica di un patto sociale neocorporativo che pieghi definitivamente i lavoratori alle esigenze dei padroni, ma tutti costoro devono fare i conti con fattori nuovi che stanno scombinando il quadro pre-esistente: uno di questi è sicuramente il modello Marchionne.
E’ evidente come Marchionne rappresenti la tendenza strategica dei grandi gruppi multinazionali e guardi molto relativamente ad una Italia marginale dal punto di vista economico. Marchionne non intende solo azzerare le relazioni sindacali esistenti ed ereditate dal dopoguerra – in qualche modo conformate dall’impianto costituzionale – ma destabilizza anche la Confindustria e il sistema delle relazioni industriali sul quale le medie imprese e le poche grandi imprese residue hanno gestito il rapporto con il sindacato e il governo. Gli strateghi del capitale Fiat, infatti, nella propria battaglia per la ripianificazione delle politiche aziendali di ristrutturazione del processo di lavoro su scala globale, agiscono in una dimensione transnazionale sfruttando la concorrenza tra gli stabilimenti Fiat sparsi nei vari continenti ove investe la casa torinese. Tale concorrenza non serve soltanto ad allocare il capitale laddove è meglio valorizzabile, ma a creare fortissime pressioni sulle frazioni di classe operaia localizzate al centro che godono di “privilegi” ritenuti eccessivi rispetto ai mercati della forza-lavoro periferici.
La Fiat nell’Italia del XXI Secolo non è più in nessun caso la Fiat che abbiamo conosciuto storicamente. Non solo per il drastico ridimensionamento quantitativo dei lavoratori occupati nel circuito Fiat e nel suo indotto (e di conseguenza anche della loro influenza politica) ma anche perché i lavoratori occupati nel territorio italiano sono ormai equivalenti numericamente a quelli occupati all’estero. La strategia del capitale Fiat mira, in definitiva, a comprimere il costo della forza-lavoro anche al centro (Italia) con un attacco complessivo a tutte le voci di spesa relative al lavoro: dal salario diretto a quello differito, dalla gestione della giornata di lavoro in termini ultraflessibili all’aumento dei ritmi di lavoro eliminando ogni fattore di rigidità della forza lavoro.
Anche il cuore strategico della proposta di Marchionne, quindi, ruota attorno alla produttività, ovvero al tasso di sfruttamento degli operai. Il problema è quello di ripristinare allettanti tassi di produttività anche al centro. Esso passa non solo per un rinnovato dispotismo di fabbrica, ma anche per l’eliminazione di dei diritti soggettivi e dei diritti sindacali – a cominciare dal diritto di sciopero- frutto delle relazioni industriali esistenti fino ad oggi. Alla produzione snella- secondo Marchionne e i suoi sostenitori – deve corrispondere un complesso di relazioni industriali snelle. Il sindacato deve essere collaborativo, discriminatorio e magari repressivo nei confronti di ogni tendenza critica e conflittuale all’interno della classe. In quest’ottica vengono ritenuti legittimi gli attacchi sistematici mossi contro i sindacati di base e la Fiom durante la trattativa su Pomigliano e Mirafiori.
Le contraddizioni irrisolte del modello capitalista “tricolore”
Del resto il peso e la continua crescita di un enorme debito pubblico, il nanismo delle imprese nazionali se rapportate alle dimensioni di quelle estere, una gigantesca evasione fiscale e contributiva, la persistenza di un articolato sistema di cricche affaristiche e speculative annidate in quasi tutti i gangli dell’apparato statale e la circolazione, fuori ogni controllo, di un immensa massa di capitali, provenienti dal circuito extralegale, non solo nel Meridione d’Italia ma in tutto il paese, sono dati preoccupanti e costituiscono materialmente un notevole freno per le ambizioni globali delle nostrana borghesia.
Mentre in ogni angolo del globo è in atto una gara inter-imperialistica sempre più combattuta sul terreno della centralizzazione finanziaria, delle joint-ventures, delle acquisizioni, delle fusioni e delle incorporazioni, nell’ambito di un mercato azionario, monetario e finanziario realmente unificato e “liberalizzato” su scala mondiale, in Italia sta emergendo la inadeguatezza di un “modello di crescita” – quello tricolore – ancora troppo tributario della dinamica delle esportazione di merci, del piccolo cabotaggio finanziario e dei tentativi, sempre meno coronati da successo, di insinuarsi in alcune nicchie di mercato sempre più strette e residuali.
Certo, a scanso di equivoci o di errate sottovalutazioni, il capitalismo italiano non è ancora, come a volte semplicisticamente si afferma, un capitalismo di seconda serie. Anzi analizzando i diversi tipi di indicatori non solo politici o economici ma anche quelli relativi alle dimensioni dell’interventismo militare fuori dai confini, il nostro padronato – l’intera Azienda/Italia – resta saldamente nel gotha del capitalismo internazionale e delle sue istituzioni (il G8, l’OCSE etc.)
Ciò, però, non impedisce di segnalare l’avanzare, sia pure, contraddittoriamente, di alcuni nuovi fattori di crisi (l’enorme settore delle produzioni dei distretti e delle subforniture è in certificata difficoltà già da almeno tre anni) i quali stanno negativamente segnando questa fase configurando chiari elementi di declino economico che, oggettivamente, predispongono il capitalismo nazionale ad un vistoso arretramento di posizione nella dinamica del confronto/scontro con le altre potenze.
Tale situazione economica e politica sta accelerando le spinte centrifughe nel nostro paese dove gli stessi assetti di comando complessivo, da quelli attinenti le funzioni governative a quelli economici e finanziari, hanno difficoltà ad interpretare agevolmente e risolutamente questo passaggio politico e danno corpo, a volte anche convulsamente, ad innumerevoli lacerazioni che scompongono e confondono (senza produrre una automatica ricomposizione in avanti per il complesso degli interessi della borghesia) i meccanismi dell’amministrazione, della programmazione e della pianificazione capitalistica.
Le convulsioni in atto e le crepe nel blocco berlusconiano e delle destre, il ruolo della Lega Nord e il dibattito, anche contradditorio, attorno ai temi del federalismo, nei territori dove questa formazione vanta un buon insediamento, la questione del terzo polo, dei centristi e l’ascesa dei nuovi “salvatori della patria” (Montezemolo, Della Valle, la Marcegaglia), l’attivismo di Marchionne, ben oltre il caso/Fiat, le preoccupazioni delle gerarchie ecclesiastiche e quelle esternate, in toni più sommessi, dai vertici dell’ Esercito circa i rischi che paventa la tenuta unitaria del paese, il rinfocolarsi di spinte localiste e particolariste al Sud (dal movimento di Lombardo e Miccichè a quello della Poli Bortone fino ad alcuni toni di Vendola e di taluni sindaci come quello di Salerno, De Luca), la stessa l’inanità oscillante ed indefinita del Partito Democratico sono sintomi di una fenomenologia politica che non promette nulla di buono per gli interessi e le stesse aspirazioni generali del capitalismo e del complesso degli interessi nazionali.
Autonomia ed indipendenza come parametri di un nuovo movimento operaio
Nonostante le tensioni sociali, la profondità della crisi economica e la divisione al’interno della classe dominante italiana, stenta ancora a manifestarsi una risposta politica e sindacale di carattere generale in grado di opporsi a questa “lotta di classe dall’alto contro il basso”. La crisi e l’involuzione della “sinistra” e dei sindacati hanno lasciato un vuoto politico che non è semplice da riempire . E’ un spazio politico che deve essere affrontato salvaguardando l’autonomia degli interessi di classe che non possono essere ricondotti all’opzione interclassista del PD e della SEL .
Questa sorta di maionese impazzita, questo clima da padroni coltelli, se da un verso mostrano un clima di marasma e di vacuità per una efficace linea di condotta di parte capitalistica dall’altro – però – ci consegnano una situazione sociale complessa in cui permangono le difficoltà per una enucleazione politica ed organizzativa di una controtendenza sociale in grado di porre un deciso stop alla generale offensiva padronale e governativa. In Italia non possiamo non tenere conto che solo il 18% dei lavoratori è concentrato in imprese con più di 250 addetti. Il 59% lavora invece in micro-imprese e quasi dieci milioni di lavoratori su diciassette non usufruiscono neanche dei diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori. La situazione dei lavoratori italiani spicca anche per la lunghezza della sua giornata lavorativa direttamente proporzionale alla scarsità di investimenti nella ricerca e sviluppo da parte delle imprese e dello Stato. Un lavoratore italiano nel XXI° Secolo non ha mai lavorato meno di 1.800 ore l’anno. Un lavoratore tedesco ne lavora poco più di 1.400, un lavoratore francese 1.500, un lavoratore inglese lavora in media 1.670 ore l’anno e uno statunitense quasi 1.800. Non possiamo negare come in questa palude del lavoro subalterno vadano sommati ormai anche migliaia e migliaia di lavoratori autonomi a partita Iva che la realtà ha trasformato in cottimisti subordinati ai committenti con tassi di autosfruttamento elevatissimi. Infine i salari italiani – così come i trattamenti previdenziali da lavoro dipendente e autonomo – sono tra i più bassi dell’intera area OCSE anche nei settori più avanzati del lavoro (dagli ingegneri ai ricercatori, dai tecnici agli insegnanti).
Questa situazione è sicuramente il frutto della grande destrutturazione industriale avviata negli anni ’70 e delle privatizzazioni degli anni ’90, ma è anche il risultato contraddittorio del ruolo dell’Italia nella divisione internazionale del lavoro e della sua progressiva marginalizzazione. Sul piano ideologico e della percezione soggettiva della propria condizione, questi processi hanno frammentato e devastato in più punti la composizione di classe del blocco sociale antagonista.
La impetuosa delocalizzazione produttiva avviata negli anni ’90 anche dalle imprese italiane, ha trasferito all’estero quasi un milione e mezzo di posti di lavoro e spesso la maggioranza del fatturato delle aziende. E’ stato delocalizzato il lavoro vivo e mantenuti in Italia solo i processi a maggiore valore aggiunto (dal marchio alla rifinitura, dalla progettazione alla logistica). La distribuzione del lavoro su filiere internazionali e l’arrivo massiccio di manodopera immigrata, ha fatto sì che molti lavoratori abbiano per tutto periodo assunto materialmente – ma anche percepito ideologicamente – la propria funzione come una sorta di aristocrazia salariata verso altri settori di lavoratori in condizioni peggiori (sia all’estero che nella periferia interna). Ma la competizione globale, la crescente polarizzazione sociale ed oggi la crisi, hanno messo in moto un processo che alcuni osservatori definiscono “convergenza” e che vede l’abbassamento generalizzato degli standard sociali (e salariali) nei paesi del centro capitalistico e l’innalzamento (in realtà molto lento) degli standard sociali e salariali nei paesi della ex periferia produttiva. L’asimmetria della crisi globale – pesante in Europa e Stati Uniti, occasione di crescita invece nei BRIC – sta accentuando la pressione capitalistica sul fattore lavoro nei paesi a capitalismo sviluppato all’insegna della competitività dei fattori nella competizione globale.
Dunque in un paese fortemente sotto stress strutturale come l’Italia, la polarizzazione sociale in alcuni settori del lavoro ha assunto i caratteri di una vera e propria proletarizzazione. I bassi salari e la precarizzazione dei contratti infatti non riguardano solo i settori operai ma anche i tecnici e i settori avanzati come gli ingegneri delle società multinazionali o nei servizi tecnologici o i ricercatori scientifici, i giornalisti e gli insegnanti o i giovani tecnici informatici. Ma se sul piano sociale questa proletarizzazione è evidente, sul piano ideologico questi settori non si percepiscono ancora come neo-proletari né come alleati naturali dei settori operai e popolari. Settori consistenti di lavoro salariato “proletarizzato” e soprattutto di lavoro autonomo “cottimizzato”, continuano a riconoscere la rappresentanza politica del proprio status sociale minacciato o perduto più nella destra che nella sinistra (anche perché quest’ultima da tempo ha liquidato la centralità del lavoro come asse strategico nel conflitto con il capitale).
La stessa concentrazione dei lavoratori – fattore obiettivo che facilita le lotte, la comunicazione e la presa di coscienza – è stata dispersa e frammentata in unità produttive piccole e distribuite nei territori e che si riconcentrano parzialmente solo nella dimensione delle aree metropolitane individuate dai gruppi capitalistici come vere e proprie reti produttive integrate.
I dati finora forniti ci indicano una situazione del lavoro in Italia estremamente frammentata e mortificata dalla voracità di un padronato straccione che autogratifica se stesso come imprenditori che “producono ricchezza e lavoro”. Verso costoro, la politica – centrodestra e centrosinistra in questo perfettamente convergenti – e i sindacati concertativi chiedono ai lavoratori un patto di fedeltà verso la logica di impresa che riteniamo falso e inaccettabile.
Il problema strategico resta il come ricomporre questo blocco sociale sul piano sindacale, politico ma anche culturale e identitario – nell’accezione di classe che ne dava ad esempio Edoardo Sanguineti – per rovesciarlo contro gli appropriatori privati della ricchezza prodotta e coloro che ostacolano lo sviluppo sociale dell’intero paese.
Si tratta infatti di avviare un processo di ricomposizione di classe che partendo dal lavoro abbia la capacità di riunire e dare identità di destino – sulla base dell’indipendenza dal capitale e dai suoi apparati ideologici – ad una classe che la destrutturazione avviata nella metà degli anni ’70 ha disperso in milioni di piccole e micro-imprese subalterne alle filiere di produzione principali.
L’autonomia di classe rivelata dagli operai della Fiat di Pomigliano e Mirafiori conferma che punti di resistenza possono darsi nelle ormai poche grandi fabbriche residue, ma che per ricomporre settori consistenti di lavoratori in una realtà così frammentata occorre mettere in campo confederalità sul piano sindacale e sperimentazione sul piano politico, soprattutto nelle grandi aree metropolitane.
Gli effetti della crisi economica nel nostro paese si stanno inoltre manifestando in maniera articolata e con accentuazioni diversificate nel corpo vivo della variegata composizione di classe.
Al Nord l’aumento della cassa integrazione ed il dilagare della precarietà sono avvertiti in maniera più drammatica producendo ulteriore smarrimento e disorientamento tra i lavoratori. In tale contesto la crescita del sentimento leghista (ben al di là dei confini organizzativi della stessa Lega Nord) e di comportamenti razzisti sono, sicuramente, riconducibili a questo profondo mutamento sociale e ai rovinosi fattori di disgregazione che si innestano nella società. Ma è evidente come la crisi stia mettendo in seria difficoltà anche i settori sociali di riferimento della Lega.
Nel Meridione d’Italia i fattori di crisi pur palesandosi su un tessuto economico meno strutturato, sono, momentaneamente, attutiti da una organizzazione sociale in cui vige un mercato del lavoro dove si miscelano, sapientemente, lavoro nero e grigio, reti familiari di protezione ed una modalità della governance fondata su uno uso disinvolto della spesa pubblica e dei finanziamenti provenienti dall’Unione Europea. Inoltre l’economia criminale, pur agendo, da tempo, in uno spazio transnazionale e caratterizzandosi come una nuova forma di accumulazione originaria del moderno capitalismo, garantisce, comunque, una ricaduta economica a vasto raggio specie nelle aree metropolitane e tra le fasce giovanili dei ceti popolari e marginali. La crisi però sta acutizzando pesantemente soprattutto la disoccupazione giovanile e produce una nuova spinta migratoria dal Meridione che ne sottrae risorse umane e sociali importanti.
Certo nell’ultimo periodo – al Nord come al Sud – non sono mancati segnali di risposta dai settori sociali che sono stati investiti dalla crisi e dalle politiche antipopolari. Ci sono stati movimenti di lotta ed alcune grandi manifestazioni che hanno visto la mobilitazione dei lavoratori migranti, dei lavoratori del settore pubblico, del settore privato e dei territori in difesa del bene comune (dall’acqua alla salute all’istruzione), tra questi vogliamo evidenziare la novità interpretata dal ciclo di lotta convergente degli studenti, dei ricercatori e delle varie tipologie di precari che hanno simboleggiato una diffusa resistenza alle politiche del governo del Cavaliere e di Confindustria.
I comunisti dentro il conflitto di classe e dentro la crisi
Dobbiamo, però, prendere atto che, mentre iniziano a configurarsi le prime conseguenze materiali della crisi, non si scorge ancora quella grande risposta conflittuale ed organizzata di cui necessiterebbe l’attuale livello dello scontro e della posta politica in gioco.
La stessa indicazione a costruire l’unità delle lotte ed a non pagare la crisi, ben presente nelle manifestazioni reali del conflitto e nelle loro sedimentazioni concrete, alla luce delle difficoltà dello scontro si è configurato come una mera forma di evocazione e di auspicio ma fatica enormemente a sedimentare organizzazione stabile del conflitto e dei settori sociali coinvolti.
Tale situazione non è ascrivibile, esclusivamente, al lavorio destrutturante del ciclo delle ristrutturazioni o alle conseguenze del corso della crisi. Esistono precise responsabilità anche nel campo della “sinistra” le quali reclamano un bilancio impietoso dopo gli autentici disastri succedutesi nei decenni e negli anni passati.
Da lungo tempo – infatti – la “sinistra” (nelle sue varie accezioni compresi gli epigoni di quella che, un tempo, amava definirsi come “radicale”) ha concepito il proprio ruolo, sia sul piano politico e sia su quello più squisitamente elettorale, esclusivamente in funzione della governance o del risultato elettorale da perseguire a tutti i costi.
Questa deriva non poteva non riflettersi e sedimentarsi, anche materialmente, nella cultura, nei comportamenti sociali, nel senso comune e nell’insieme delle dinamiche del conflitto del nostro paese. Le mobilitazioni, le vertenze sindacali e sociali, il movimento reale è stato costantemente depotenziato e ricondotto, dal prevalere di una impostazione politica e programmatica di stampo collaborazionista, alla logica del minimo sforzo, del rispetto delle compatibilità e dell’accettazione subalterna degli interessi dell’Azienda/Italia.
Oggi, però, il permanere dei fattori di strutturalità e di sistemicità della crisi danno, seppur in maniera asimmetrica e contraddittoria, nuova linfa alla ripresa del conflitto in tutti i segmenti – quelli “vecchi” e quelli “nuovi” – della composizione di classe in Italia e non solo.
Nel momento in cui il Wall Street Journal e l’insieme dei poteri forti globali ricordano all’Unione Europea che la “festa è finita” e che il vecchio continente non può più consentirsi un modello di welfare ritenuto troppo includente, siamo giunti ad un punto di svolta le cui decisioni pratiche conseguenti stanno iniziando a riverberare nell’intero spazio continentale a partire dai paesi più deboli strutturalmente dell’Unione. Indubbiamente la resistenza dei lavoratori e dei giovani attraverso il ciclo di lotte sociali e sindacali a cui stiamo assistendo in tutta Europa – e in modo consequenziale anche in un Maghreb ormai strettamente integrato con la “metropoli europea” – apre uno scenario di enorme interesse e opportunità. Non possiamo però non registrare che tale opportunità è più consistente in quei paesi europei dove esiste e agisce concretamente una soggettività comunista organizzata che mette in discussione apertamente le organizzazioni riformiste della sinistra.
In tale tipo di contesto il rilancio di una riqualificata funzione internazionalista è parte integrante dell’azione dei comunisti nel rapporto con la complessa realtà in cui operiamo anche in Italia.
L’impegno quindi a favorire l’incontro e la socializzazione di tutte le espressioni organizzate del conflitto le quali, indipendentemente dai punti di innesto da cui partono, si muovono da subito ed in tendenza, contro un comune avversario, è un punto fermo del nostro programma politico immediato.
In questa prospettiva la Rete dei Comunisti intende sviluppare il suo impegno con una costante attività teorica, politica ed organizzativa a tutto campo, in Italia e non solo, consapevole che le ragioni dei comunisti oggi sono legate in maniera inscindibile alla ripresa – a larga scala – di un nuovo movimento operaio e proletario incardinato ad una prospettiva autonoma ed indipendente.
CREDITS
Immagine in evidenza: 15 Ottobre 2011 – Roma
Autore: USB
Immagine originale ridimensionata e ritagliata