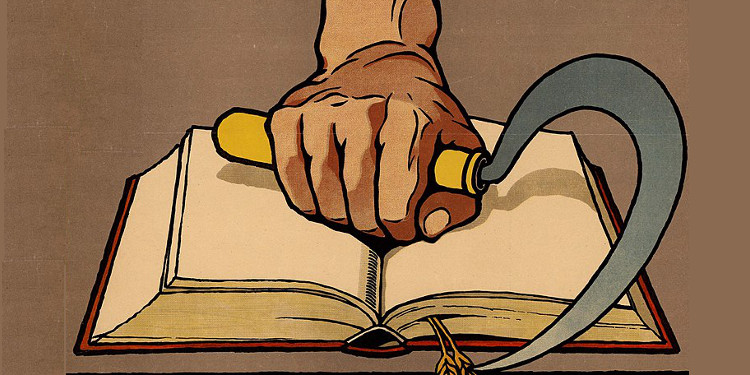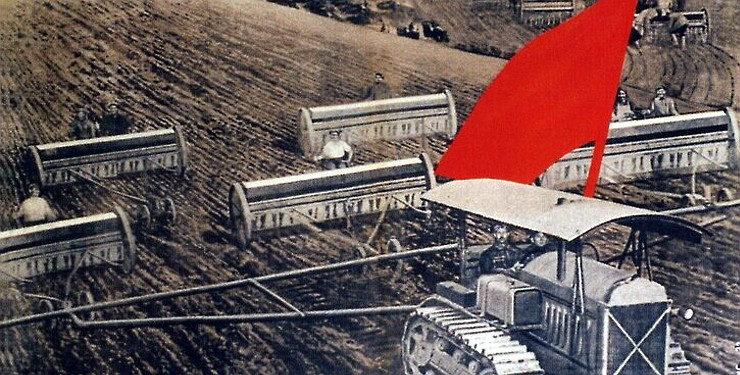Capitale e natura – Prima parte – Capitolo 5
Di fronte alla crisi ecologica, parte integrante e punta alta della crisi economica e sistemica del capitale, si propongono alternative che nella maggior parte dei casi rimangono comunque, consapevolmente o inconsapevolmente, direttamente o indirettamente, compatibili con il Modo di Produzione Capitalista.
Il capitale cerca di camuffare le reali contraddizioni spostando il problema dalle cause agli effetti. Allora propone, o condivide, ad esempio “soluzioni” come lo sviluppo sostenibile, la “green economy”, l’uso e lo sviluppo di fonti energetiche “verdi”.
La “green economy”, così cara ad Obama e alle lobby da lui rappresentate, e così entusiasticamente accettata da ampi settori politici italiani anche della sinistra e da quelli sindacali, primi fra tutti la CGIL (che con la sua IRES ha fatto ampi studi elogiativi sull’impatto quantitativo sull’occupazione), trova i favori di ampi settori del capitale. A parte tutti i principi astratti e teorici sulla “green economy” che parlano di mirabolanti effetti positivi sull’ambiente e sull’occupazione, la sua applicazione pratica ad oggi si concretizza in enormi investimenti pubblici in termini di incentivi e sgravi fiscali al capitale e leggi di sostegno alla incentivazione della produzione e al consumo.
La proposta di una “economia verde” parte da un’analisi econometrica per cercare, in modo mistificatorio, di far credere in uno sviluppo economico (dove comunque l’indicatore rimane il PIL) che considera i danni ambientali. Ma il PIL, per essere sostenuto, non può prescindere dal modello di produzione capitalista. Nella “economia verde” i rapporti di produzione, il fin della produzione, i rapporti sociali, sono gli stessi di prima. Non può essere altrimenti. Le pale eoliche o i pannelli fotovoltaici, ad esempio, nel sistema capitalistico sono merci, e come tali, nella loro produzione, circolazione e commercializzazione, seguono tutte le regole della produzione capitalista e del profitto.
Si dice che la “green economy” è un nuovo modello di sviluppo che contrasta il modello economico ‘nero’ basato sui combustibili fossili, e si considera in grado sia di creare “lavori verdi”, che di assicurare una crescita economica sostenibile, di prevenire l’inquinamento ambientale, il riscaldamento globale, l’esaurimento delle risorse e il degrado ambientale.
Ma vediamo alcuni esempi nella sua applicazione pratica.
A luglio 2009 la Vestas dell’isola di Wight (Gran Bretagna), il più grande produttore mondiale di turbine eoliche e che faceva profitti enormi non rischiando certo il fallimento (fatturato di 4,8 miliardi di euro nel 2007, 6 miliardi nel 2008, 6,6 miliardi nel 2009), chiude gli stabilimenti e più di 400 lavoratori sono stati licenziati. Nell’ottobre 2009 Vestas inaugura nuovi stabilimenti di ben 130.000 metri quadrati in Cina, nella provincia di Tianjin, la più grande fabbrica di turbine eoliche al mondo. Lo stabilimento Vestas di Taranto ha chiuso per 2 mesi (febbraio e marzo) nel 2010 mettendo 350 operai, con contratto a tempo indeterminato, in cassa integrazione. Oltre ai 350 lavoratori con contratto a tempo indeterminato, alla Vestas di Taranto lavoravano quasi 150 persone con contratti atipici (interinali e a tempo). Sempre Vestas ha da poco annunciato (ottobre 2010) di voler chiudere ben 5 impianti di produzione presenti sul territorio scandinavo, tagliando così circa 3.000 posti di lavoro.
In Italia ci sono in esercizio (fine 2009) 4.850 MegaWatt di potenza eolica, per 6,7 TetraWattora di energia elettrica prodotta. Detto così potrebbe sembrare un dato incoraggiante, ma la produzione di energia eolica in Italia equivale soltanto al 3% del fabbisogno elettrico nazionale. Poiché i consumi di elettricità rappresentano meno del 40% del consumo totale di energia, si ha un risparmio sul totale di energia fossile consumata annualmente in Italia pari neanche all’1%. A fronte del raggiungimento di questa percentuale, la produzione di “energia nera” (quella prodotta da fonti non rinnovabili) in Italia non è neanche diminuita.
Per questo scarso 1% sono istallati oltre 200 “parchi eolici” (nome ovviamente accattivante, usato per non chiamarle centrali elettriche) per un totale di migliaia di pale eoliche. Molti di questi “parchi eolici” sono stati realizzati su aree protette (vietato), falsificando mappe catastali per sviare le leggi relative alla vicinanza a luoghi abitati, con la connivenza di amministratori locali. Circa il 90% sono stati costruiti nel sud Italia (43 in Sicilia, 29 in Sardegna, 28 in Puglia, 24 in Calabria, 17 in Molise, 15 in Basilicata, 15 in Campania, 11 in Abruzzo). Sono stati realizzati e sono gestiti dalle più importanti multinazionale dell’energia, sia italiane che straniere, in “società” spesso con la criminalità organizzata che concede i terreni e crea Società fittizie di progettazione e gestione delle commesse. Queste multinazionali, prime fra tutte Edison ed Enel ma anche altre, sono le stesse, direttamente o indirettamente, che producono “energia nera”. A parte le considerazioni sui danni paesaggistici, naturalistici e di inquinamento acustico degli impianti eolici, in Italia esiste una legge (il Decreto Bersani) che prevede i cosiddetti “certificati verdi”. Chi produce energia ne deve produrre una percentuale di tipo rinnovabile, chi non lo fa, o sta sotto la percentuale, deve acquistare i “certificati verdi” pari alla percentuale mancante. Chi produce più energia da fonti rinnovabili della percentuale dovuta, può vendere i “certificati verdi”. Se chi vende “certificati verdi” non li vende tutti, questi vengono acquistati comunque dal GSE S.p.A. (Gestore Servizi Energetici), una Società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha anche il compito di emettere i “certificati verdi”, quindi, in sostanza, di fare da intermediario tra chi compra e chi vende. E’ evidente allora che produrre energia alternativa in Italia non serve a diminuire la produzione di quella da fonti non rinnovabili, ma serve sostanzialmente al capitale e alle multinazionali a vendere “certificati verdi”. Le Società che producono “energia nera” non hanno nessun interesse a diminuire la loro produzione, tanto possono comprare i “certificati verdi”, spesso da loro stessi.
Ma all’interno della “green economy” si possono anche ad esempio proporre pratiche come quelle della produzione dei cosiddetti biocombustibili (mais, grano, oli vegetali, ecc.), che meglio e più correttamente dovrebbero essere definiti agrocombustibili, cioè una soluzione ai problemi energetici e di emissione di CO2 mistificatoria e criminale. La produzione di agrocombustibili è infatti mistificatoria perché non risolve i problemi ambientali, anzi li acutizza: deforestazione per l’acquisizione di sempre maggiori terreni da coltivare, inquinamento dei suoli e delle falde acquifere con l’uso massiccio di diserbanti, concimi chimici e antiparassitari, maggiore sviluppo degli OGM per aumentare la quantità di produzione, impoverimento della biodiversità agricola con lo sviluppo massiccio delle monocolture, impiego smisurato di acqua per l’irrigazione, sono solo alcuni degli effetti sulla natura che la coltivazione di prodotti agricoli per produrre agrocombustibili provoca, senza parlare di quelli degli stessi impianti di produzione. E’ criminale perché produce nuovo colonialismo, aumenta i prezzi dei più importanti e primari prodotti agricoli, usa questi a scopo energetico invece che a scopo alimentare.
Questo solo per fare alcuni esempi di “economia verde”: un’invenzione mistificatoria del capitalismo che rimane quindi tutta interna al conflitto capitale -lavoro.
Ma il capitalismo inventa anche forme filosofiche di mistificazione, o a queste aderisce, come ad esempio il cosiddetto sviluppo sostenibile.
La definizione più in voga di sviluppo sostenibile è quella che recita: “lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. Cioè il concetto delle tre “e”: ecologia, equità, economia. Cioè, sostanzialmente: crescita, diminuzione della povertà, tutela della natura. Tale concetto, anche se con parole leggermente diverse, è quello sostenuto anche dalla legge italiana (D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con le modifiche apportate dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4). A parte la visione antropocentrica di tale concetto, sulla quale molto ci sarebbe da discutere, la crescita all’interno del sistema capitalistico è una crescita quantitativa, che inevitabilmente è in contrasto con gli altri due concetti (diminuzione della povertà, tutela della natura), quindi, di fatto, una falsa idea di soddisfare i bisogni senza compromettere la natura.
Un concetto di sviluppo avulso dalla critica alla civiltà capitalista, che si riduce a mera crescita quantitativa, dove un indicatore come il PIL è l’elemento fondamentale della sua determinazione. In una nazione il PIL cresce anche quando aumentano i malati di cancro grazie alle spese che la società deve sostenere per le loro cure, aumenta quando si costruiscono carceri o centri di detenzione per i migranti, quando si spende in produzione di armi e in guerre, quando si costruiscono inceneritori, quando aumenta l’inquinamento ambientale e le relative spese per porre qualche rimedio, quando in generale c’è una crescita della produzione delle merci e la conseguente accentuazione della distruzione ambientale. “Se si calcolasse il PIL tenendo conto anche dei danni ecologici e sociali il valore di questo dovrebbe essere notevolmente ridotto in ogni paese. E quindi è una mera illusione pensare ad uno sviluppo sostenibile (sostenibile per chi? Sostenibile per le leggi di mercato) perché ogni produzione provoca un impoverimento delle risorse naturali e devastanti impatti sociali” (L. Vasapollo, R. Martufi, L’ambiente Capitale, Natura Avventura Edizioni, 2008).
Il capitalismo inventa anche le leggi ambientali o le cosiddette norme volontarie (EMAS, ECOLABEL, ISO, ECOAUDIT, Bilancio Sociale, Bilancio Ambientale). Tutte norme che di fatto salvaguardano le relazioni di dominio sociale e ambientale del capitale.
Norme che nel migliore dei casi posticipano il problema, come ad esempio quelle sul riciclaggio dei rifiuti, che da una parte induce a pensare che visto che alcuni materiali possono essere riciclati ne possiamo fare un uso indiscriminato, e dall’altra che possono essere prodotti in grandi quantità. Ma quali sono i costi economici, ambientali, sociali anche dello stesso riciclaggio? Chi gestisce tutti i processi di riciclaggio? E questi prodotti, in ultima istanza, anche dopo essere stati riciclati, dove andranno a finire? Alcune leggi, pur sembrando ecologicamente sostenibili, non solo non risolvono il problema, ma spesso anzi lo aggravano.
Ad esempio, di recente sono state approvate leggi che vietano la produzione e l’uso di sacchetti di plastica, sostituendoli con quelli prodotti con il mais e l’olio di girasole. Nel mondo ogni anno vengono consumati centinaia di miliardi di sacchetti di plastica (solo in Italia tra i 10 e i 15 miliardi l’anno). Per produrre un sacchetto ci voglio 5 grammi di mais e 10 grammi di olio di girasole, quindi solo per coprire l’uso di sacchetti in Italia in un anno ci sarà bisogno di 75 milioni di chili di mais e di 150 milioni di chili di olio di girasole. Quante tonnellate di mais bisognerà produrre in un anno solo per realizzare questi sacchetti per tutto il mondo? Questo significherà, come è nella produzione di prodotti agricoli per gli agrocombustibili, distruzioni ambientali e crimini sociali.
Il capitalismo si è dotato anche di altri strumenti, come ad esempio alcuni trattati internazionali che se anche nel loro impianto generale hanno un’attenzione all’ambiente e cercano di risolvere le distruzioni della natura, contengono comunque degli elementi che gli consentono di continuare a farlo indisturbato. Uno di questi è il Protocollo di Kyoto, il quale contiene il cosiddetto “meccanismo di sviluppo pulito” (CDM – Clean Development Mechanism). Il CDM prevede infatti alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione, di realizzare progetti che mirano alla riduzione delle emissioni di gas serra nei paesi in via di sviluppo senza vincoli di emissione.
Cioè se ad esempio un’impresa di un paese industrializzato che ha vincoli di emissione previsti dal Protocollo (cioè deve mantenersi sotto una certa soglia di produzione di gas ad effetto serra) istalla pannelli solari in un paese in via di sviluppo, la riduzione di gas ad effetto serra che questa istallazione produce nel paese ospitante il progetto, fa acquisire crediti di emissione (CER – Certified Emission Reductions) al paese dell’impresa che realizza il progetto.
Questi CER possono servire al paese industrializzato a raggiungere la percentuale di vincoli di emissione oppure, se in eccedenza, possono essere venduti ad altri paesi. In sostanza, questo genera tre cose: la prima che le imprese dei paesi industrializzati possono fare affari con i paesi in via di sviluppo, la seconda che i paesi industrializzati possono continuare a non ridurre le proprie immissioni di gas ad effetto serra e quindi continuare a produrre senza vincoli ambientali, la terza quella di creare un mercato dei CER.
In tutto questo non è solo il capitalismo che, con opera mistificatoria, tenta di spostare la visione del problema dalla causa all’effetto, ma sono anche settori sociali e intellettuali che, spesso in buona fede, propongono “alternative” non alternative.
Tra queste la teoria della decrescita. Non ha senso parlare di decrescita, in quanto “crescita” e “decrescita” sono comunque indicatori quantitativi e strumenti di misura strettamente legati ad un modello economico e sociale, basato sul consumo e sul profitto. Un’idea bizzarra, occidentalcentrica, ma allo stesso tempo pericolosa per lo sviluppo solidale dell’umanità, come se ciò risolvesse i problemi dei disastri del sistema capitalistico, rimanendone invece all’interno, senza porsi il problema del suo superamento. Se è un’idea inaccettabile all’interno dei paesi a capitalismo maturo, lo è ancora di più se ragioniamo in termini globali, dove circa l’ 80% della popolazione mondiale vive in condizioni di povertà o di estrema povertà, dove circa 800 milioni di persone non dispongono di cibo sufficiente per condurre delle esistenze normali, sane e attive, dove più di 850 milioni di persone sono analfabeti, dove più di un miliardo di persone non ha accesso alle risorse di acqua pulita, dove circa 2,4 miliardi non dispone dei servizi sanitari di base, dove quasi 325 milioni di bambini e bambine non frequenta la scuola, dove 11 milioni di bambini al di sotto dei cinque anni di età muoiono ogni anno per cause che potrebbero essere evitate. E’ come dire che il metodo per non prendersi l’AIDS è praticare l’astinenza.
Parallelamente a questa, sono nate anche altre teorie fuorvianti.
La consapevolezza che indicatori come il PIL non siano in grado di rilevare il peggioramento e l’impoverimento della natura e gli effetti devastanti del Modo di Produzione Capitalista su questi, ha portato a varie proposte per la sua correzione. Tra queste il PIL VERDE che dovrebbe tener conto delle conseguenze sull’ambiente dello sviluppo economico; il GPI (Genuine Progress Indicator) che, invece di calcolare tutte le spese come positive come fa il PIL, fa una distinzione tra spese positive (ad esempio quelle dei servizi o dei beni) e spese negative (ossia quelle causate dall’inquinamento, dalla criminalità, dagli incidenti); l’UNDP (United Nations Development) che considera l’HDI (Human Development Index), un indice di sviluppo umano che tenga conto di altri fattori di sviluppo come quelli sociali quali istruzione, sanità, nutrizione. Indicatori che rimangono tutti comunque interni alla compatibilità di un sistema di Contabilità Nazionale, che misura comunque con formule quantitative di mercato le dinamiche economiche che sono del sistema capitalista.
Allora, ad esempio, ci si trova di fronte all’impossibilità di calcolare gli effetti dei cambiamenti climatici o i cambiamenti culturali, scientifici ed economici, oppure comunque sempre attraverso canoni di definizione “occidentali” e quindi a connotato capitalistico, in un contesto che non tiene conto di altre civiltà, usi e costumi che creano bisogni diversi.
Altri indicatori proposti, e in alcuni casi introdotti, sono quelli microeconomici di tipo aziendali per la misura dell’impatto ambientale. Tra questi gli indicatori di impatto ambientale e gli indicatori di performance ambientale, cioè indicatori fisici ed economici a valutazioni soggettive. Delle stime che accertino le conseguenze provocate dalla gestione produttiva attraverso la formulazione più chiara degli obiettivi, permettono altresì uno sviluppo del sistema di gestione ambientale, un miglioramento della comunicazione esterna e il controllo con una riduzione delle emissioni e soprattutto dei relativi costi di abbattimento e di prevenzione. Ma anche in questo caso l’ambiente è valutato come fattore della produzione capitalista e sottoposto quindi comunque alle leggi di valorizzazione del capitale. In ultima analisi, serve soprattutto all’impresa nel suo obiettivo di migliorare la propria immagine.
E’ chiaro, dunque, come le alternative proposte, direttamente o indirettamente, dal capitalismo, o da esso acquisite, come anche quelle fatte da interpretazioni diverse ma che non si pongono come obiettivo il suo superamento, di fatto sono alternative che non risolvono la contraddizione capitale-natura e quindi interne al conflitto capitale-lavoro.