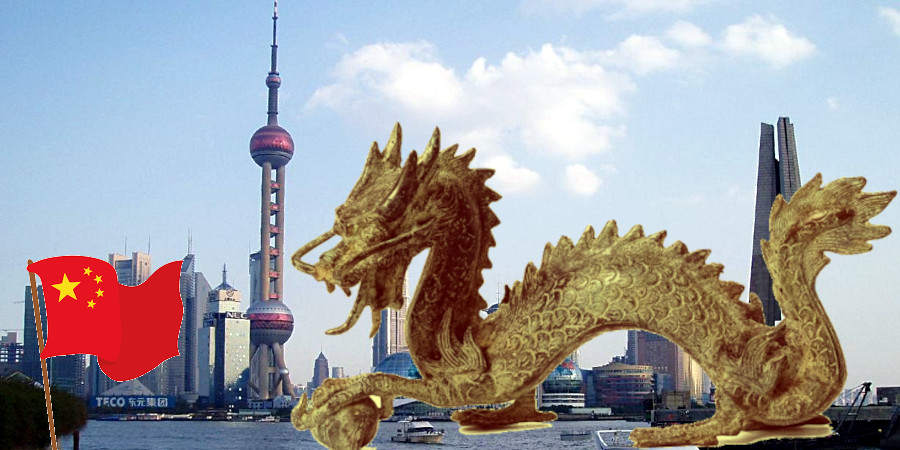Per rilanciare l’attualità del comunismo
Silvio Serino (Relazione al I° Forum promosso dalla Rete dei Comunisti – Roma 13-14 Maggio 2006)
È ben noto agli organizzatori del convegno che noi non solo riteniamo che dalla morte di Lenin in poi sia venuta progressivamente meno la natura socialista del potere in Urss, ma anche e conseguentemente che non sia stata avviata alcuna transizione economico-sociale al comunismo. Per dirla in sintesi, la gestione stalinista ha sempre di più generalizzato il lavoro salariato, anche col settore dell’industria statale pianificata, e sempre più istituito un sistema di gestione gerarchico-manageriale che poneva i lavoratori salariati in posizione nettamente esecutiva e subalterna. Non è la nostra un’analisi ex post per liberarci di una cosa imbarazzante e che ha fatto una fine ingloriosa (anche per non essere stati difesa quasi da nessuno [1]), ma la ripresa di una critica che già fu fatta da consistenti correnti marxiste che si dissociarono dallo stalinismo. Né è un’analisi svolta all’insegna di un modello paradisiaco di comunismo per poter sempre opporre che noi non c’entriamo affatto con le ruvidezze della realtà, ma ben , tenendo in mente che una transizione presenta caratteri contraddittori e richiede talvolta scelte e decisioni immediate che possono risultare erronee. In Urss – sempre per dirla in breve – non c’è stato non | già il comunismo, ma la transizione socialista, se non confondiamo quest’ultima con una sorta di welfare.
Sul punto c’è una montagna di libri, ovviamente controversi, per cui non sarebbe opportuno e serio cercare di dimostrare quanto sopra detto con un intervento di una ventina di minuti.
Si può qui affrontare invece, sia pure con qualche schematismo, quell’argomento che rappresenta l’estrema difesa dell’Urss, che suona pressappoco così. D’accordo che l’Urss è stata caratterizzata da pesanti distorsioni burocratiche, da una transizione appena accennata o bloccata, anche da qualche orrore tipico di ogni accumulazione originaria, ma tutto ciò fu dovuto al livello arretrato delle forze produttive e al pesante accerchiamento capitalistico; il carattere di transizione con segno comunque proletario sarebbe però dimostrato da quattro fatti:
- in corrispondenza con resistenza dell’Urss, il capitalismo ha dovuto adottare politiche welfariste contro la sua natura, per impedire che le sue retrovie fossero infiammate dall’esempio sovietico;
- con la fine dell’Urss il capitalismo ha ripreso la politica liberista secondo la sua natura e sono riprese le aggressioni ai paesi della periferia;
- la lotta anticoloniale è stata incoraggiata e sostenuta talvolta anche apertamente dall’Urss;
- le scelte di Stalin, per quanto criticabili sotto il profilo comunista, portarono l’Urss a sconfiggere il nazismo, che altrimenti avrebbe vinto sull’inconseguenza delle democrazie occidentali.
Naturalmente non abbiamo dubbi che la causa della mancata transizione al comunismo e l’accartocciamento del potere statale in Urss non dipese da un riformismo di partenza della frazione cosiddetta stalinista, ma dall’accerchiamento capitalistico di un paese che non aveva (ancor più dopo le devastazioni della guerra mondiale e della guerra civile che coincise con una grande carestia) risorse umane e tecniche tali da renderlo relativamente autonomo. Ma di tale impossibilità fu abbondantemente preavvertita la predetta frazione, che per prevalere operò una pesantissima repressione del marxismo dissidente insieme con una colossale mistificazione dell’opera in corso, che legittimò la perdita di qualsiasi autonomia del potere operaio. E si badi bene: le frazioni marxiste duramente represse dallo stalinismo non proponevano una forzatura soggettivistica per realizzare il vero socialismo; nella consapevolezza invece che il mercato mondiale avrebbe reso impossibile la “costruzione” del socialismo in un solo paese, tanto più arretrato, esse si battevano per mantenere la massima autonomia possibile del partito e del potere dei soviet da quelle che possiamo complessivamente definire un’economia ancora fondata (o sempre più fondata) sulla legge del valore. Autonomia da potere investire, peraltro, nel sostegno alle lotte che si sarebbero presentate nello scacchiere internazionale [2]. Lo stesso Lenin avvertiva l’importanza decisiva di questa autonomia, se consideriamo il suo “onestissimo” saggio sulla imposta in natura, nel quale egli con grande chiarezza definisce le misure della Nep [3] tendenti a realizzare al massimo il capitalismo di stato, definito capitalismo di stato e non contrabbandato come socialismo. Certo, scorporando questo importante testo dalla strategia leniniana che poneva come compito prioritario l’iniziativa internazionale ed enfatizzando oltremodo i suoi apprezzamenti del taylorismo, si può criticare Lenin per un eccesso di fiducia sul controllo di un capitalismo suscitato dagli stessi comunisti. Sappiamo però che egli e quasi tutta l’internazionale avvertivano la priorità di tale iniziativa e la drammaticità in cui veniva sempre più a trovarsi il potere dei soviet con il rifluire della rivoluzione in Europa occidentale. Una drammaticità che lo porta a constatare con amarezza: ci troviamo alla guida di automobile con la sensazione che il volante nelle nostre mani sia manovrato da altri.
Venendo invece al primo punto, è il caso di precisare che le prime misure welfaristiche, sia pure in modo sporadico e isolato, furono assunte ben prima della “costruzione del socialismo in un solo paese” [4] inaugurata dopo la morte di Lenin, e anche prima della rivoluzione d’Ottobre. Non alludiamo solo alle prime aperture paternalistiche della Germania di fine Ottocento, ma alle iniziative assunte da Henry Ford alla vigilia della prima guerra mondiale, in materia di orario di lavoro, di stabilità del posto di lavoro e di aumenti salariali [5]. Queste iniziative rispondono a tutta evidenza ad una esigenza del capitalismo di creare un circolo virtuoso (che comunque le crisi mettono in questione) tra maggiore sicurezza operaia, rilancio della produzione, della produttività e consumi di massa maggiormente stimolati con l’aumento del cosiddetto tempo libero. Certo, vi è anche la sollecitazione o, se si vuole, la paura della lotta operaia, che negli Usa in particolare – nel periodo che va dall’ultimo quarto dell’ottocento fino alla prima guerra mondiale – fu particolarmente antagonista [6]. Ma questo argomento, che mette nel conto delle scelte del capitale la necessità di imbrigliare la sovversione proletaria o di aggirare la resistenza sindacale con una maggiore estrazione di plusvalore relativo, va molto al di là del pericolo rappresentato dall’Urss a direzione stalinista, tant’è che perfino dove le rivoluzioni vengono sconfitte con la violenza aperta, come in Italia e in Germania, i governi reazionari, adottando una politica di spinto interventismo statale nell’economia, vanno a reggersi su un consenso costruito intorno ad alcune concessioni welfaristiche.
Peraltro, il carattere intrinseco al capitalismo di una politica a sostegno di alcuni consumi di massa, di protezione dell’occupazione e della forza lavoro con la sanità e la previdenza è indicato da un’altra coincidenza. Questa politica di New Deal ispirata alle teorie di Keynes viene lanciata a ridosso della grande crisi del 1929. E non si può dire ancora una volta che le maggiori preoccupazioni di Wall Street e di Delano Roosevelt derivassero dalla radicalizzazione dell’internazionalismo sovietico. In quel periodo anzi la grande paura dell’ottobre sembrava attenuarsi proprio per la scelta della frazione stalinista di sbarazzarsi di ogni avventurismo internazionalista, se consideriamo il sospiro di sollievo di Churchill a commento della scelta di esiliare Trotsky e l’apprezzamento di Roosevelt alla Costituzione sovietica del 1936 come la più democratica del mondo…alla vigilia appunto delle grandi purghe.
Ma ancor più rilevante è distinguere che c’è Welfare concesso dall’alto, con limiti anche quantitativi precisi, e Welfare strappato dal basso. Quando si parla della parte più significativa del Welfare non bisogna dimenticare che essa fu strappata in Europa non solo dalla durissima lotta proletaria nella seconda metà degli anni sessanta e agli inizi degli anni settanta, ma anche in contraddizione, a volte molto aspra, con gli indirizzi del PCUS e dei partiti occidentali ad esso affratellati.
Per essere più chiari, la vittoria dell’Urss sul nazifascismo e la ricostituzione del grande PCI in Italia (si può dire lo stesso del PCF) aggiunse ben poco negli anni del dopoguerra alle concessioni fordiste – keynesiste degli anni precedenti la guerra. E quel poco fu pressoché concesso in corrispondenza del nuovo e più grande boom economico della storia del capitalismo.
La linea di Togliatti, inaugurata con la svolta di Salerno, non mirava solo a organizzare la resistenza in rigidi schemi interclassisti e patriottici in ossequio agli accordi di Stalin con Roosevelt e Churchill, ma anche a impedire che le rivendicazioni salariali fossero incompatibili con il piano di ricostruzione economica nazionale. Entro questi confini, il Pci e la Cgil furono certamente strumenti di una lotta che alcuni settori del capitalismo non riuscivano a tollerare. Ma è innegabile che il PCI fu un partito responsabile che non metteva seriamente in discussione le gabbie salariale, la forte divisione tra lavoro femminile e maschile, tra giovani e adulti, tra impiegati e operai, nel quadro di una politica di sacrifici. A riconoscere il senso di responsabilità di Togliatti era lo stesso capitale che tutt’al più, quando voleva essere critico, insinuava il sospetto di una sua doppiezza e cioè che dietro la linea di collaborazione nazional-popolare si tenessero effettivamente nascosti i mitra partigiani nei mitici orti dell’Emilia-Romagna. Della moderazione del PCI e della Cgil non parlavano del resto solo le pregiudiziali e “dottrinarie” dissidenze troskyste e bordighiste. ma anche la più accomodante sinistra socialista che poi si trasformò in P.S.I.U.P., il nascente operaismo dei Quaderni Rossi, la sinistra cocchiera della CGIL e perfino – con la lingua dello schiavo, ovviamente – alcune componenti dello stesso P.C.I., dalle quali nacque poi la scissione del Manifesto.
Una moderazione – va ripetuto – non derivante solo dalla relativa passività operaia, ma in contraddizione con un ripresa delle lotte operaie e con una resistenza, peraltro, prima che arrivasse Togliatti, molto più consistente di quella raccoltasi intorno al P.C.L
Di questa contraddizione ne dà conto anche Vittorio Foa nella sua raccolta con il titolo “Sindacati e lotte operaie 1943-73″ così premettendo ad una “relazione non firmata all’interno del Pei sugli avvenimenti in Lombardia nei giorni 26, 27 e 28 luglio e riportata da Pietro Secchia nel suo testo “Il partito comunista italiano e la guerra di liberazione 1943-45″:
“Alla notizia della caduta di Mussolini, diffusa la tarda sera del 25 luglio 1945, ebbero inizio grandi manifestazioni popolari in tutta Italia. Il lento emergere delle parole d’ordine, il carattere sociale dell’epurazione fatta dagli operai, il rapporto complesso fra linea di unità nazionale ed esigenze specifiche della classe operaia, sono presenti in questa relazione”
che tra l’altro così recita (in verità, in modo poco complesso) dopo aver apprezzato la presenza delle bandiere tricolori:
“Sono apparse nelle manifestazioni bandiere rosse e si sono sentiti canti rivoluzionari. In alcuni casi ho potuto appurare che si trattava di iniziativa di elementi moralmente bacati, ai quali gli operai non si sono uniti; la presenza di distintivi rossi ha dato luogo nel centro della città ad incidenti con alcuni ufficiali, alcuni dei quali sostenevano in buona fede la necessità di non creare scissioni nell’unità della lotta per la libertà. ”
Naturalmente, sappiamo come venivano giustificate le scelte di responsabilità che arrivavano ad additare come provocatori o come elementi moralmente bacati quelli che si presentavano con le bandiere e i distintivi rossi e cantavano inni rivoluzionari, fino a progettare l’assassinio di esponenti “avventuristi” del tipo di Lelio Basso: i rapporti di forza internazionali!
Appunto, durante la Resistenza e subito dopo di essa – commenterà sempre Vittorio Foa in un convegno del 1974 – “alle esigenze di trasformazione socialista della società che venivano da una parte considerevole delle masse operaie in lotta si opponeva da parte dei conservatori il quadro intemazionale, la divisione del mondo in blocchi contrapposti, l’incontrastabile egemonia capitalistica sull’Europa occidentale.
La realtà non era così semplice. La situazione intemazionale non è qualcosa che cala sulla testa delle gente, la situazione intemazionale esercita la sua pressione sempre attraverso strumenti interni. Prendiamo la Nato con le sue costrizioni militari e con la sua connessione strettissima con gli strumenti di potere interni a ciascun paese. Prendiamo la coesistenza pacifica a livello delle due maggiori potenze con le sue esigenze di concorrenza e di controllo di campo, per cui l’America, proprio perché trova l’accordo con l’Unione Sovietica, ha bisogno di controllare strettamente la propria sfera di influenza, di impedire ogni processo di liberazione. I condizionamenti internazionali in ogni situazione si realizzano attraverso la mediazione di forze interne. L’avversario perciò non scompare in una presunta eteronomia delle scelte, l’avversario di classe è presente, nei suoi collegamenti internazionali, e ogni rassegnazione è priva di giustificazioni. ”
Per togliere ogni dubbio alla sua linea di responsabilità Togliatti ebbe a dare un giudizio fortemente negativo perfino sulla scissione nel 1964 del P.S.I.U.P., pur essendo stata questa decisa a seguito della gravissima scelta del P.S.I. di formare il primo governo di centro-sinistra a guida democristiana. E fu proprio in quegli anni che il Partito Comunista Cinese pubblicò un documento che definiva il segretario del P.C.L alla stessa stregua di un socialdemocratico e l’Urss un paese socialimperialista.
Cosa avvenne negli anni sessantotto! Tutti sottolineano la grande effervescenza studentesca, per inferire che il contrasto con il P.C.I. coinvolse settori socialmente poco definiti o fu espressione di una rivolta generazionale, ma pochi rammentano quanto andava ripetendo, almeno nella seconda metà degli anni settanta, sempre Vittorio Foa, che nel 1968 faceva parte della segreteria nazionale della CGIL e non era membro di gruppi estremisti o settari. I sindacati confederali, in ossequio all’accordo sulla politica dei redditi ispirata da quel noto “sprecone” di La Malfa padre, avevano elaborato una proposta di riforma delle pensioni che consisteva più o meno nella disciplina che è venuta a stabilirsi dalla controriforma Dini in poi. Poiché rappresentava comunque un piccolo miglioramento rispetto al sistema pensionistico vigente allora, essi andarono giulivi a presentare la loro proposta nelle assemblee di fabbrica. Furono accolti con fischi, sputi e monetine in faccia. Fu uno choc per chi non aveva neppure minimamente seguito quel movimento carsico di ripresa operaia che aveva caratterizzato il quinquennio precedente e anzi ne aveva salutato alcune emersioni come provocazioni di giovani teppisti meridionali. Vittorio Foa, che pure aveva criticato aspramente quella falsa riforma, si dimise dalla CGIL, mentre gli scioperi e le proteste di piazza assunsero forme alluvionali, mettendo in discussione tutto: gabbie salariali, divisioni giovani/adulti, donne/uomini, operai/impiegati, contenimenti salariali, monetizzazione del rischio salute, instabilità del posto di lavoro, orario, ritmi e turni di lavoro, commissioni interne, insomma il cosiddetto Welfare del boom post-bellico “conquistato” dal PCI.
Si dice con un po’ di disinvoltura che anche il PCI fu a suo modo protagonista delle lotte di quegli anni. Non siamo tra quelli che arrivano a dire che partecipò sempre allo stesso modo in cui Giuliano Ferrara partecipò agli scontri di Valle Giulia a Roma. Ma non crediamo sia seriamente confutabile che ogni lotta doveva superare la moderazione e il tentativo di contenimento da parte della maggioranza del PCI e dei sindacati. A volte si arrivava allo scontro, a volte si riusciva a chiudere con un compromesso. Perfino, sulle commissioni interne “le botteghe oscure” tennero duro fino all’ultimo momento, per poi impegnare tutti i loro sforzi nell’addomesticamento istituzionale dei Consigli di Fabbrica.
Quando dunque parliamo di contro-offensiva liberista, dobbiamo precisare bene. Essa non ha come obiettivo le presunte conquiste del dopoguerra, cioè le gabbie e le altre divisioni salariali, la disciplina dei licenziamenti fino al 1968, il sistema pensionistico e sanitario del periodo degasperiano. Non dimentichiamo che anche la legge del 1966, che fu salutata come eccessivamente garantista, non prevedeva ancora, in caso di licenziamento ingiustificato, la piena reintegra del lavoratore ed il risarcimento danni a decorrere dal dì del licenziamento. Ha di mira invece tutto ciò che è stato conquistato negli anni sessantotto a volte contro lo stesso PCI o, nel migliore dei casi, con un PCI che cavalcava la tigre per domarla. Berlinguer a ridosso di quegli anni e a commento del colpo di stato in Cile di Pinochet sciolse ogni ambiguità sostenendo che perfino eventuali governi di sinistra non potevano che dare ingresso alla reazione. Dunque, compromesso storico, unità nazionale, Pecchioli e teorema Calogero a seguire!
La contraddizione tra il sessantotto e la posizione del PCUS è ancora più evidente. Non ci riferiamo solo alla repressione della cosiddetta Primavera di Praga, ma al Maggio francese, quando fece enorme scalpore internazionale Breznev che additò i rivoltosi parigini, che erigevano le barricate contro le violenze dei flic, come “lupi mannari”, nel mentre i sindacati s’ingegnavano a spegnere i poderosi scioperi dei lavoratori, ancora più pericolosi perché trainati dagli immigrati algerini e marocchini
Anche sul secondo punto non c’è quella corrispondenza cronologica indicata dai sostenitori della natura comunque non capitalistica deH’URSS. Il liberismo non inizia nel 1991, ma sul finire degli anni settanta, dopo che il compromesso storico incominciò a funzionare e il sindacato fissò i famigerati tetti salariali al congresso dell’Eur. E assunse negli anni ottanta la sua massima virulenza con il reaganismo negli Usa e il tatcherismo in Gran Bretagna.
Se come è evidente perfino in modo clamoroso che il liberismo non viene messo in atto in quanto si ritiene che non c’è più il baluardo “sovietico” da superare, da quali esigenze nasce? Non ci pare che al riguardo ci siano molti dubbi da parte di quasi tutti i più seri studiosi, a parte i diversi giudizi di valore.
Il liberismo è una risposta alla crisi dopo la fine del boom postbellico, un tentativo di ricacciare indietro la forte ascesa dell’Europa occidentale e del Giappone, ed è nel contempo una risposta alle conquiste del sessantotto, strappate ancor più “inopportunamente” a fine di quel boom. Che in questo caso l’URSS fosse l’ultima preoccupazione (in quanto fonte di sovversione) del grande capitale mondiale è dimostrato dal fatto che anche nella “patria del socialismo” si mette mano a metà degli anni ottanta ad una sorta di politica liberista. Gorbaciov è certamente costretto alle riforme dalla feroce competizione del mercato mondiale (e già questo esclude che l’URSS fosse un campo autonomo e contrapposto alla forza dell’altro campo), ed è sollecitato da strutture economiche e agenti sociali endogeni. Non si tratta solo dei 10 milioni di laureati ansiosi di emulare i loro più privilegiati colleghi occidentali, ma soprattutto della maggioranza di quei burocrati che si trasformano senza colpo ferire e senza drammatiche crisi di identità nei più selvaggi capitalisti mai visti.
Sulle pagine dell’unità – e spesso anche su quelle del Manifesto – Gorbaciov è stato salutato non come un riformatore liberista, ma come simbolo del compromesso sovietico in condizioni di particolare difficoltà dopo gli sprechi brezneviani nella conservazione di industrie decotte (in verità, soprattutto nel settore militare che arrivò ad assorbire fino al 18% del PIL). Liberista sarebbe stato invece lo spregiudicato Eltsin. Francamente, queste discussioni ci sembrano molto simili a quelle che vogliono distinguere tra il centrosinistra e il centrodestra, tra la Tatcher e Blair o tra il compromesso storico e la svolta ochettiana della Bologninal
Sul terzo punto, ci rendiamo conto che la discussione è più difficile perché coinvolge temi internazionali che per la loro ampiezza e complessa interrelazione non sempre consentono una presa diretta ed un controllo empirico immediato. Alcuni chiarimenti sono però possibili.
Cominciamo da una premessa metodologica. Molti compagni sono portati a giudicare alcune prese di posizioni anticolonialiste come una sicura scelta di campo anticapitalistica e antimperialista. In realtà, valutando tutto il corso storico del capitalismo questo solo parametro si è dimostrato abbastanza fragile e fuorviante. Come molti sanno, gli inglesi e i francesi, non ancora insediatisi nelle Americhe o non ancora insediatisi in modo significativo, furono critici feroci dei colonialisti iberici, fino a diffondere la legenda nera sui massacri terrificanti compiuti da primi conquistadores. Naturalmente, quanto scriveva Las Casas sulle carneficine compiute dai suoi connazionali non era una leggenda, era pura e semplice verità. Era però falso che gli inglesi e i francesi fossero indignati per le atrocità commesse dagli iberici. Come è stato ampiamente dimostrato dai fatti, essi si proponevano solo di sostituire i loro concorrenti, tant’è che contribuirono alla diffusione dello schiavismo in misura preponderante e allo sterminio dei nativi con vere e proprie soluzioni finali; gli inglesi per di più furono paladini della loro purezza razziale, aborrendo i matrimoni misti del centro-sud America.
Questa precisazione non sembri un’inutile banalità, perché ancora oggi l’immaginario collettivo (alimentato da “seri” intellettuali) è portato a credere che gli spagnoli in quanto reazionari fossero peggiori degli illuministi francesi ed inglesi. È risultato invece che proprio gli illuministi “per sé” furono i più radicali razzisti “per gli altri”, avvalendosi dell’ausilio della scienza e della dea ragione. Locke e Jefferson predicavano la libertà ed erano tranquillamente proprietari di schiavi.
Né questo apparente paradosso – quello cioè di essere contrari al colonialismo… degli altri – è venuto meno con il XX secolo. È risaputo che il primo Novecento non vede solo il Congresso dei Popoli di Bakù, ma, paradossalmente, anche i proclami wilsoniani contro il colonialismo e a favore dell’autodeterminazione di tutte le nazioni.
Possiamo anche convenire che l’anticolonialismo wilsoniano (comunque gli Usa in quegli anni non rinunciavano al loro dominio sulle Filippine e su Cuba) non mirava a sostituire il vecchio colonialismo europeo. Ma come spiegano anche Mauro Bulgarelli ed Umberto Zona nel libro “L’Impero invisibile”, che si inoltra nel retroscena pensante della Presidenza americana capeggiato da personaggi a dir poco inquietanti, quella politica si basava sulla sicurezza che i nuovi mezzi militari e finanziari, ovviamente sempre più monopolio esclusivo degli Usa, avrebbero consentito un nuovo tipo di oppressione e di supersfruttamento…e di rappresaglia a distanza in tempo reale in caso di ribellioni.
Questa premessa non serve ad insinuare che quindi l’anticolonialismo dell’URSS aveva lo stesso segno di quello usamericano. Escludiamo che l’URSS staliniana fosse un paese imperialista e non pensiamo neppure – a differenza del Partito Comunista di Mao – che lo fosse diventata l’URSS post-staliniana. Nonostante l’Unione Sovietica avesse raggiunto coefficienti di grande potenza militare, non ha mai raggiunto quelli economici e finanziari per potersi definire paese imperialista (nel senso leniniano del termine).
Tuttavia, per quanto avesse un interesse oggettivo ad una politica antimperialista e alle rivolte dei popoli ancora oppressi, se non altro per sottrarsi al suo ruolo di dipendenza dal capitale mondiale dominante, si deve constatare che fece prevalere più l’interesse al compromesso e al contenimento (in alcuni casi, alla svendita) che non quello del conflitto con gli USA. La cosiddetta costruzione del socialismo in un solo paese comportava una politica diplomatica tessuta anche da buoni rapporti con le grandi potenze.
Il caso più clamoroso che dimostra l’assenza, se non peggio, dell’URSS nella lotta antimperialista è rappresentato dalla Cina. Come è noto, la frazione stalinista riteneva che la lotta antimperialista dovesse comportare l’alleanza del P.C. cinese con il Kuomintang, anche dopo che questi mise in atto esecuzioni capitali di migliaia di comunisti. Di diverso avviso e in aspra polemica con Mosca fu la direzione maoista che riuscì a portare a termine vittoriosamente la lotta antimperialista trasgredendo con le direttive di Stalin.
Nel frattempo, altri avvenimenti portano a mettere seriamente in dubbio la convinzione che l’URSS fosse almeno un faro della lotta antimperialista. La resistenza greca – troppo fiduciosa sull’aiuto di Mosca – fu massacrata dalle truppe alleate in ossequio agli accordi di Yalta; la resistenza guidata da Tito vinse dovendo fare completo affidamento sulle proprie forze e sempre in polemica con la linea compromissoria di Mosca; lo Stato di Israele venne riconosciuto dall’Onu con il voto favorevole del rappresentante sovietico. Né le cose diventano più limpide negli anni cinquanta e sessanta quando la lotta anticoloniale divampò dappertutto e perfino gli Usa erano più che mai decisi a liquidare i vecchi domini inglesi e francesi…per scopi wilsoniani. In questo periodo la decisione di tenere la Cina con il suo quinto dell’umanità fuori dall’Onu, e sanzionata con un boicottaggio economico che durò fino all’inizio degli anni settanta, non indusse l’URSS a rompere con 1’ ONU, ma a lanciare la politica della cosiddetta coesistenza pacifica. L’assassinio di Lumumba in Congo getta molte ombre sul comportamento della diplomazia sovietica, per non dire di quanto successe in Indonesia e del pronto allacciamento di rapporti (a controrivoluzione ancora calda) con i colonnelli greci prima e con Pinochet dopo.
Ci sono stati anche gli aiuti ad alcune lotte, la più importante delle quali è stata quella vietnamita. Ma anche tenuto conto che quando l’antimperialismo si manifesta a singhiozzo e in modo a dir poco strumentale, bastano questi aiuti a riscattare l’Urss come faro quanto meno della lotta antimperialista? E nel caso del Vietnam non è legittimo chiedersi se le scelte sovietiche sarebbero state diverse in assenza di un tentativo di egemonia cinese (per quanto anch’esso opinabile sotto il profilo comunista) ormai in aperta concorrenza con il Cremlino?
Dal 1991 in poi – si fa però presente – le aggressioni alle periferie sono in rapido aumento. È vero, e conveniamo che ciò è dovuto anche al crollo dell’Urss e quindi alla concentrazione della potenza militare nelle mani degli Usa. Ma ciò ha ben poco a che vedere con il crollo di un baluardo antimperialista quanto piuttosto con un’aggressività indotta dalla crisi e incoraggiata dal venire meno di un multilaterismo militare. Non c’è da dubitare che, se la Francia, sicuramente capitalistica e a presidenza Chirac, avesse avuto la stessa potenza militare dell’Urss, l’aggressione statunitense all’lrak sarebbe stata alquanto più problematica.
Sul quarto punto, gli stalinisti, poiché hanno un brutto scheletro nell’armadio, sono costretti a raccontare solo tra se stessi (in modo autoreferenziale, dicono i no global) che senza l’intervento dell’Urss nella guerra il nazifascismo non sarebbe stato sconfitto. Ora, non c’è dubbio che, senza l’apertura del fronte orientale, i tedeschi non avrebbero perso la guerra o, se pure l’avessero persa, avrebbero patteggiato come alla fine della I guerra mondiale.
La malizia degli stalinisti consiste però nel voler far credere che l’Urss sia “intervenuta” nella guerra contro il nazifascismo, così come un centro sociale decide per principio di andare a contrastare una manifestazione neo-fascista. Per avvalorare questa tesi, è necessario sorvolare disinvoltamente sulla politica del Pcus. cioè sulle decisioni manifeste e coscienti, e forzare l’interpretazione delle ragioni oggettive che ispirarono la frazione staliniana ad avviare l’industrializzazione a tappe forzate. L’industrializzazione a tappe forzate sarebbe stata ispirata dalla necessità di dover affrontare il nazismo.
Ma è un’interpretazione così troppo oggettiva e priva del supporto di atti coscienti da sembrare solo un’ipotesi interessante come un’altra. Peraltro, essa appare anche alquanto bizzarra, se nel contempo apprezza la scelta della costruzione del socialismo in un solo paese come un modo per evitare quel confronto internazionale ritenuto avventuristico. Non c’è chi non vede infatti che con la scelta dell’industrializzazione forzata, interpretata in tal modo, Stalin avrebbe messo tra le priorità la necessità di battersi in campo internazionale. Solo che lo avrebbe fatto, con saggezza contadina, di nascosto o meglio senza dirlo.
Non ci sfugge ovviamente che tutta la III Internazionale degli anni venti prevedeva una II guerra mondiale che avrebbe investito anche l’Urss, ma il timore della guerra resta abbastanza sullo sfondo, se si esaminano in modo più ravvicinato i motivi che determinarono la scelta dell’industrializzazione forzata e pesante. Intanto, venne assunta ben prima della vittoria in Germania del nazismo e corrispondeva in realtà alla convinzione che ogni prima accumulazione dovesse dare la priorità all’industria e soprattutto all’industria dei beni strumentali. Tutto il dibattito che si svolse nella seconda metà degli anni venti (con all’inizio Trotsky maggior sostenitore della predetta priorità contro Bucharin/Stalin difensori dell’arricchimento dei contadini) porta in questa direzione.
Se però ci spostiamo a considerare le convinzioni espresse e non vogliamo raccontare favole, la frazione stalinista all’inizio degli anni trenta ebbe addirittura a sottovalutare il pericolo nazista al punto da suggerire ai comunisti tedeschi di assumere come nemico principale la socialdemocrazia. Dopo un’oscillazione a 360 gradi che porta alla politica dei fronti popolari non solo con la socialdemocrazia ma anche con i partiti dichiaratamente espressione del grande capitale, arriviamo al patto Ribbentrop/Molotov [7].
È noto il balbettìo al riguardo. Si sarebbe trattato di un patto per non farsi aggredire o almeno per prendere tempo. Come si concilia questa esigenza tattica con la spartizione della Polonia, l’aggressione alla Finlandia e l’indicazione ai comunisti dell’Europa occidentale di non boicottare i nazisti in guerra non è mai stato chiarito, se non con l’ossessiva ripetizione che si è trattato di tattica. Concediamolo pure.
Ciò che però non si può assolutamente concedere è che Stalin avesse intenzione di intervenire contro l’odiato nemico nazifascista. È invece evidente come una montagna che Stalin non solo credeva che con il predetto patto avrebbe ritardato l’aggressione nazista, ma addirittura che l’aveva scongiurata. Quando la Wermacht invase l’Urss non solo non si trovò preparato a resistere, ma addirittura non credette sulle prime battute che si trattasse di un’invasione e invitò con irritazione a verificare se non si trattasse per caso di incidenti o di equivoci.
Dunque, non fu l’Urss a prendere la decisione di intervenire contro il nazismo, ma fu il nazismo che intervenne contro l’Urss e tutta la documentazione storica lascia supporre che, se Hitler non avesse deciso in tal senso, l’Urss non sarebbe mai scesa in campo contro il nazismo.
Recentissimamente, Luciano Canfora nelle suo testo “Disavventure della Democrazia” ha criticato il patto sovietico con il nazismo, arrivando a definirlo un patto strategico. Il lettore non può che logicamente ricavare il nostro stesso giudizio: l’Urss non fu determinante neppure nella sconfitta del nazifascimo. Tuttavia, ci siamo resi conto con stupore che la grande scoperta di Canfora viene utilizzata dai nostalgici dell’Urss per dimostrare che essi hanno sempre ragione. Il ragionamento è pressappoco questo: lo stalinismo sbagliò e forse va finalmente considerato come un ostacolo autoritario alla cosiddetta costruzione del socialismo, ma la vitalità socialista dell’Urss, impersonata dai democratici Togliatti e Dimitrov, spinse di nuovo l’Urss ad assumere la giusta posizione contro l’allora Male Assoluto rappresentato dal nazifascismo. Va da sé che in questa nuova ricostruzione assume poco importanza il fatto che “la giusta posizione” democratica si pose alla coda della democrazia “americana”…oggi denunciata come il nuovo Male Assoluto! Ma ciò che colpisce di più in questa bizzarra ricostruzione – che continua a proporre l’alternanza della padella alla brace – è la sostanziale inconsapevolezza non solo delle cause della scomparsa dell’Urss, ma della sua stessa scomparsa.
NOTE
[1] ↑ Non ci sfugge che ci sono stati alcuni isolati gruppi di lavoratori che hanno protestato contro la dismissione del welfare sovietico e che anche oggi vi sono fasce di popolazione secondo cui si stava meglio quando si stava peggio. Ma non ci sarebbe neppure bisogno di dire che ciò non integra minimamente l’ipotesi di uno scontro che avrebbe visto in campo una forza, sia pure male organizzata, a difesa del socialismo.
[2] ↑ Il problema si presentò clamorosamente in occasione del lungo e poderoso sciopero generale del 1926 in Inghilterra. Stalin facendo prevalere la necessità e l’apologia della costruzione del socialismo in un solo paese frenò l’azione degli stessi comunisti in quel paese, opponendo agli “avventuristi” che il sostegno attivo a quello sciopero avrebbe compromesso i rapporti diplomatici con l’Occidente e la fornitura del carbone inglese ali’Unione Sovietica.
[3] ↑ Gorbaciov ebbe ad affermare impudicamente che le sue riforme rappresentavano una sorta di Nep di ispirazione leniniana. Anche i dirigenti cinesi post-maoisti si sono presentati come neppisti-leninisti, facendo aumentare pesantemente gli orari di lavoro ai livelli dell’epoca vittoriana, consentendo ampi dislivelli salariali e sacche di lavoro di fatto schiavizzato, nonché una polarizzazione che ha ridotto la gran parte della Cina ad una colonia interna della cosiddetta Cina Blu. È il caso allora di ricordare che la Nep voluta da Lenin, per quanto opinabile, venne varata per avviare un minimo di attività economica in una Russia isolata, prostrata dalla guerra mondiale (cui contribuì con 10 milioni di morti), dalla guerra civile e da una delle più devastanti carestie. Per dare l’idea, l’apparato industriale al varo della Nep si presentava solo con il 10% di quello anteguerra e veniva ripreso a ciclo morto; la maggioranza degli operai era perita nello scontro con i bianchi e i contingenti imperialisti, gli operai sopravvissuti vagavano per le campagne a raccogliere qualche radice, l’attività dei contadini era ridotta ad una minima autosussistenza, le città quindi erano affamate e a corto della minima energia. Siamo -come si vede- ad una distanza siderale dall’Urss e dalla Cina degli anni ottanta, sia perché in questi anni la metà circa dell’umanità si autodefiniva parte del cosiddetto campo socialista, sia perché in questo campo almeno i problemi della prima accumulazione erano stati ampiamente risolti.
[4] ↑ Obiettivo ben diverso dall’instaurazione del potere proletario in un solo paese, anche arretrato (cosiddetto anello debole), come prima roccaforte per alimentare la rivoluzione mondiale. Sull’assimilazione dei due obiettivi ha sempre giocato lo stalinismo. È curioso oggi che gli epigoni di Stalin, in versione democratica, abbiano scoperto che la pervasività del mercato mondiale rende a tal punto difficile la transizione al socialismo in un solo paese da doversi accontentare di un po’ di economia pubblica da inserire cautamente nel mercato, con la benedizione di governi di centrosinistra ovviamente.
[5] ↑ Ford portò nel 1914 il salario minimo dei suoi operai a cinque dollari al giorno, cioè ad un livello ritenuto all’epoca scandalosamente alto.
[6] ↑ La letteratura “riformista” europea continua a ripetere che gli Usa non avrebbero mai conosciuto una forza operaia simile a quella del vecchio continente. In realtà, con questa rappresentazione si vuole intendere che il proletariato è forte se manda al governo partiti socialdemocratici o comunque è rappresentato da tali partiti. Nel periodo sopra considerato non solo ci furono scioperi che potevano essere sedati con l’uso dell’esercito o di un’estrema violenza poliziesca, ma lo stesso partito socialista, di ispirazione più marxista di quella socialdemocratica europea al punto che simpatizzò con la rivoluzione di Ottobre, arrivò a superare il milione di iscritti; i sindacati arrivarono fino a 2 milioni e mezzo di iscritti; il sindacato IWW più radicale di ispirazione anarchica contava alla vigilia della I guerra mondiale 200 mila iscritti veri, molti dei quali attivisti infaticabili e, data la fortissima repressione wilsoniana, molto coraggiosi.
[7] ↑ Anche il patto con i nazisti è stato paragonato dagli estimatori di Stalin alla pace di Brest con i tedeschi voluta da Lenin. Naturalmente, questo delirante paragone viene solo sussurrato, perché già è evidente di per sé la differenza tra un patto (con i nazisti!) e una pace in una condizione di guerra in corso e imposta alla Russia dal ricatto finanziario anglo-francese. Peraltro, i bolscevici arrivarono vittoriosi in Ottobre proprio battendosi per la fine della guerra. Come pure è evidente che c’è un’enorme differenza tra un patto che prevede la spartizione della Polonia e una pace che consentiva ad alcune nazionalità del vecchio impero zarista di autodeterminarsi. Ma ciò che più conta è il vero scopo di Lenin (e in quel caso anche di Trotsky) nel siglare quella pace. un scopo diametralmente opposto a quello di Stalin. La pace di Brest voleva reiterare il messaggio di disfattismo rivoluzionario ai soldati tedeschi. Insomma non siamo noi bolscevichi i vostri nemici, ma il vostro governo, che vuole continuare la guerra. Noi aiuteremo i rivoluzionari in Germania a boicottare la guerra. Come è noto, fu proprio dopo la pace di Brest che iniziarono in Germania vere e proprie insurrezioni, che misero fine alla guerra mondiale e inaugurarono il ciclo rivoluzionario europeo protrattosi fino al 1923. Più di uno storico -anche non di sinistra- riconosce che senza la rivoluzione d’Ottobre, imperniata sulla parola d’ordine della pace da raggiungere anche con il disfattismo rivoluzionario, la Iª guerra mondiale sarebbe durata molto di più.
CREDITS
Immagine in evidenza: Yalta Conference;
Autore: U. S. Signal Corps, 9 febbraio 1945;
Licenza: pubblico dominio ;
Immagine originale ridimensionata, colorata e ritagliata