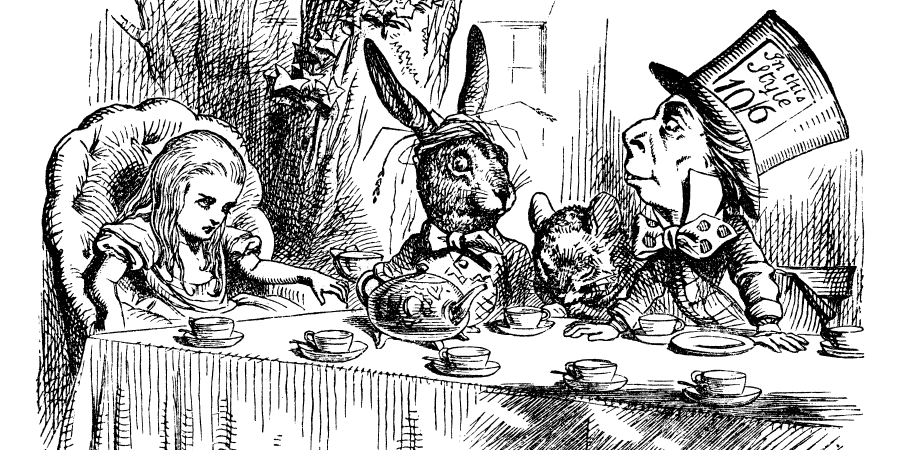Uscire e rompere l’europolo, per un progetto di superamento del capitalismo
Luciano Vasapollo (in Contropiano anno 23 n° 1 – febbraio 2014)
Il contesto attuale della competizione globale: la crisi sistemica
Parliamo ormai da tempo di crisi sistemica, poiché la strutturalità e la globalità della crisi rendono evidente la tendenza alla caduta del saggio di profitto nei Paesi più sviluppati, o – come li abbiamo sempre definiti – Paesi a capitalismo maturo. Ciò si accompagna all’enorme distruzione di “forze produttive in esubero”, siano esse forza lavoro o capitale come esplicitazione di forma di lavoro anticipato. È quindi evidente che non vi sono più le condizioni per ripristinare un nuovo modello di valorizzazione del capitale che sappia dare la “giusta” redditività agli investimenti e quindi creare possibilità per un nuovo processo di accumulazione capitalista, anche attraverso il cambiamento del modello di produzione.
Il capitale internazionale cerca così di sopravvivere alla meglio, intensificando la sostituzione della funzione del capitale produttivo con la finanziarizzazione, delocalizzazioni, esternalizzazioni, privatizzazioni e riducendo drasticamente i costi di produzione con un attacco violento e generale al costo del lavoro, alle stesse garanzie e diritti del lavoro, al salario diretto, indiretto e differito; provocando così disoccupazione strutturale, precarizzazione istituzionalizzata, uso ricattatorio della forza lavoro immigrata per espellere manodopera locale, più costosa e più esigente in termini di diritti e garanzie.
Ma la crisi economica del capitale internazionale, che sta manifestando la sua profondità in questi ultimi anni, ma che origina dai primi anni ’70 come crisi generale di accumulazione, è stata da noi identificata in vari lavori, già da oltre 15 anni, come crisi sistemica; è pertanto diversa dalle “normali” crisi in cui si dispiega il modo di produzione capitalista proprio a partire dalla sua condizione intrinseca di disequilibrio.
Ciò significa che la costante sovrapproduzione di merci e capitali nei Paesi a capitalismo maturo non trova più soluzione nelle tradizionali forme di fuoriuscita dalle crisi congiunturali né da quelle di natura più strutturale, ma si va configurando sempre più col carattere di crisi globale, accompagnata da crisi sistemica. Ciò perché le stesse relazioni di produzione entrano in un conflitto a carattere endemico, distruggendo per la prima volta anche la stessa forzata convivenza padrone-lavoratore.
La crisi è sistemica perché sempre più ampia è la divaricazione fra sviluppo delle forze produttive e modernizzazione e socializzazione dei rapporti di produzione, al punto che sono ormai intaccati non solo questi ultimi, ma le stesse relazioni sociali in tutti i Paesi a capitalismo maturo; al punto che i nuovi soggetti del lavoro, del non lavoro e del lavoro negato, cioè quel soggetto che chiamiamo classe proletaria sfruttata, nonostante la modernità delle forme, non può trovare emancipazione politica, culturale, sociale ed economica nella società del capitale.
Indipendentemente dal fatto che la sua profondità si sia evidenziata nelle Borse e nelle pratiche speculative dei grandi sistemi bancari, da sempre abbiamo avvisato che non si trattava della classica crisi finanziaria, poiché in tale “normale” situazione non si interrompono i processi internazionali di accumulazione del capitale.
Il perché della finanziarizzazione e dell’indebitamento forzato
Da quasi tre decenni la struttura dei pagamenti internazionali immette nel sistema una gigantesca concentrazione di liquidità, detenuta dalle grandi multinazionali e gestita dalle grandi banche e dalle grandi società finanziarie. Tali eccessi di liquidità sono stati incanalati nel sistema finanziario, contraendo ancor più fortemente gli investimenti produttivi, riducendo così la capacità di reddito dei lavoratori.
Tutto farebbe pensare alla scelta della finanziarizzazione dell’economia come un processo momentaneo di riassestamento del capitale internazionale, mentre si tratta effettivamente di un illusorio tentativo di uscita dalla crisi strutturale e poi sistemica, prendendo atto dell’incapacità e impossibilità del rilancio di un nuovo modello di accumulazione capitalista o di cambiamento del modello di produzione.
L’indebitamento generalizzato è parte di questa prospettiva finanziaria, che si è affermata con un lungo ciclo di bassi tassi di interesse, accompagnato da forme selvagge di deregolamentazione e con il ruolo centrale degli organismi internazionali; in particolare l’FMI ha sostenuto un sistema di pagamenti internazionali in grado di garantire la continuazione di una voluta condizione di squilibrio, nella quale l’incredibile indebitamento statunitense potesse essere assorbito dall’enorme surplus di Giappone, Germania e Cina.
Tale processo parte da lontano, già dai primi anni ’70, quando la crisi internazionale d’accumulazione assume caratteri così fortemente strutturali, e poi pienamente sistemici, da far sì che il capitale internazionale scelga di finanziarizzare le economie; ciò prende particolare slancio già nei primi anni ’80, marginalizzando di fatto il ruolo delle banche commerciali.
Quindi tale liquidità in eccesso deriva proprio dalla modifica strutturale della redistribuzione del PIL ai redditi da lavoro e capitale, a forte vantaggio di quest’ultimo già a partire dagli anni ’80. A ciò va anche aggiunto che gli incrementi di produttività del lavoro degli ultimi 30 anni sono stati redistribuiti solo in piccola parte al monte salari complessivo; e che, in ultimo, tale accumulazione di liquidità è stata dovuta anche ai processi di centralizzazione del capitale con fusioni, incorporazioni, liquidazioni, più o meno veri fallimenti e chiusure di imprese, che hanno ingigantito l’esercito dei disoccupati e dei precari.
Con la finanziarizzazione dell’economia, e quindi con la messa a rendita dei profitti e con la compressione del monte salari complessivo, il modello precedente – chiamiamolo dell’era della crescita – viene a cadere e anzi si inverte il ruolo degli operatori economici.
La riduzione del monte salari complessivo, nella redistribuzione del PIL, ne diminuisce ovviamente la capacità di acquisto e la propensione al risparmio, tramutando l’operatore famiglia, quindi i lavoratori, da risparmiatori creditori a consumatori poveri indebitati, con l’aumento delle mille forme di ricorso al debito per sostenere i consumi anche di prima necessità. Ecco il contesto nel quale, a partire dal 2009, si scatena la crisi del debito sovrano e delle connesse politiche pubbliche e governo dell’economia.
Keynesismo al servizio della sovranità bancaria
La chiusura del ciclo speculativo dell’estate 2007, con il connesso crollo del mercato del credito mondiale, porta ad un rigenerato interventismo degli Stati dei Paesi a capitalismo maturo, indirizzato però non al rilancio della produttività nell’economia reale, ma al salvataggio del sistema bancario e finanziario.
In tal modo il processo di privatizzazione, in atto dall’inizio della fase neoliberista come ulteriore tentativo di occultare gli effetti della crisi di accumulazione del capitale, accompagnato dai processi di finanziarizzazione e di attacco generale al costo del lavoro, vede la sua ultima puntata, piegando gli Stati in una crisi di natura fiscale.
Si tratta in effetti di una gigantesca operazione a favore di banche, sistema finanziario e imprese, per lo più medie e grandi, per trasformare il debito privato in debito pubblico; si conduce così la crisi del capitale in una direzione più pesante, quella relativa alla crisi economica e politica degli Stati sovrani sotto forma di crisi del debito pubblico.
Si realizza così quello che in varie occasioni abbiamo chiamato il rilancio del keynesismo, il cosiddetto keynesismo del “privato”, che in ultima istanza significa la solita via della socializzazione delle perdite. Ciò significa sottrarre fette consistenti di spesa pubblica al salario e al welfare per dare soccorso a quel sistema criminale delle banche, che dopo i disastri provocati vengono sostenute con denaro pubblico, quindi con imposte e tasse sottratte alla spesa sociale e destinate a quell’ultima forma di privatizzazione che è quella del “debito sovrano”. Si tratta semplicemente di incremento del debito pubblico assorbito per il salvataggio del sistema privato di banche e finanziarie.
Ma se il gioco è così evidente, perché le banche e i mercati finanziari convincono l’opinione pubblica che i due punti deboli dell’economia europea sono l’alto costo del lavoro e il deficit fiscale, con il connesso dato di stock del debito pubblico? Per capire ciò, come abbiamo evidenziato già in nostri scritti di oltre dieci anni fa [1] , bisogna ritornare alle modalità di costruzione del polo imperialista europeo, che si è realizzato intorno all’asse tedesco-francese ma in funzione specifica degli interessi della Germania. Non è un caso che i criteri di stabilità facciano riferimento al deficit fiscale, al debito pubblico, all’inflazione e ai tassi di interesse; cioè tutte variabili che devono essere tenute sotto controllo per favorire le esportazioni.
È in questo ambito che si scatena la speculazione dei mercati finanziari internazionali sui titoli dei Paesi volgarmente chiamati PIIGS, poiché ormai le scommesse migliori sono quelle al ribasso proprio sulle obbligazioni di tali economie-Paese; ciò rende impossibile ridurre i già molto alti livelli assunti per questi Paesi dei rapporti deficit-PIL e debito pubblico-PIL.
Da ciò si capisce chiaramente perché la Germania controlli tali variabili, in quanto la sua crescita è incentrata sull’export e perché necessita il deficit dei Paesi europei dell’area mediterranea, i cosiddetti PIIGS (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna, e doppia I se si vuole considerare l’Irlanda), compresa anche la Francia, in quanto l’acquisto da parte della Germania dei titoli del debito pubblico di questi Paesi rappresenta una forma di investimento dell’eccedente tedesco accumulato. Insomma, il surplus della bilancia commerciale tedesca è reso redditizio dall’investimento del debito dei Paesi europei con bilancia commerciale in deficit. Ed è proprio il sistema bancario tedesco che gestisce tale eccedente, compreso quello di altri Paesi del Nord Europa.
D’altra parte, operazioni simili avvengono nei mercati finanziari internazionali per risolvere agli Stati Uniti il problema della liquidità necessaria per finanziare un gigantesco deficit della bilancia commerciale, dovuto alla fortissima esposizione in importazioni. E in questo caso il sistema di operazioni finanziarie è gestito da banche di investimento USA, svizzere, francesi e tedesche.
Sono quindi le banche che realizzano la maggior parte delle transazioni nei mercati dei prodotti finanziari derivati, sono le banche e i fondi pensione e di investimento i maggiori speculatori, e la crisi finanziaria non ha affatto rallentato le transazioni su questi mercati, ma le ha moltiplicate in maniera frenetica. Ad esempio sono state le banche, in Europa, che con la forte riduzione dei tassi di interesse hanno finanziato la bolla speculativa dei prezzi degli immobili; sono le banche che hanno chiuso l’accesso al credito per le imprese e rendendolo sempre più oneroso per le famiglie.
Ma guarda caso sono le banche che hanno ricevuto gli aiuti pubblici dal keynesismo “privato statale”, gli aiuti fiscali, perfino beneficiando del carry trade, ottenendo cioè denaro dalle banche centrali a meno dell’1% di tasso di interesse per poi ricomprare i titoli del debito pubblico a più o meno il 5%; e la Banca Centrale Europea non compra debito pubblico, ma accetta dalle banche private i titoli del debito pubblico, per far loro continuare a ricevere liquidità e così comprare debito pubblico.
In pratica salvare l’Unione Europea, e quindi salvare il modello di export tedesco, significa semplicemente distruggere le possibilità autonome di sviluppo dei Paesi europei dell’area mediterranea.
È in questo senso che va interpretata l’azione dell’Unione Europea, che, non dotata di una autonoma capacità politica, impone ai Paesi deficitari le stesse regole dei piani di aggiustamento strutturale che l’FMI ha applicato in tutti gli ultimi 30 anni per fare “strozzinaggio” sui Paesi dell’America Latina e condizionarne le modalità di sviluppo. Si fa così giocare ora in Europa, come allora in America Latina, un ruolo centrale alle regole della Banca Mondiale, oltre a quelle del Fondo Monetario Internazionale.
Prospettive della competizione globale
Le politiche di strozzinaggio in chiave europea non necessariamente possono funzionare in tutta la loro capacità espansiva, poiché oggi anche nei Paesi a capitalismo maturo la produttività è stagnante da oltre 35 anni, facendo sì che l’accumulazione di capitale, con l’annessa produzione fordista, si sia spostata nei Paesi delle semiperiferia e periferia, in particolare dell’Asia Orientale e dell’America Latina.
È chiaro che la crisi del debito sovrano in Europa comporta anche una minore attrattitività negli investimenti esteri e una minore competitività dell’Europa rispetto alle altre potenze mondiali.
Il Fondo Monetario Internazionale stima che nel 2014 il debito pubblico dell’Europa supererà il 100% in rapporto al PIL, con Paesi come la Francia, la Germania e il Regno Unito intorno al 90%.
Si consideri inoltre che continuerà la politica di spostamento delle risorse dei bilanci pubblici per sostenere imprese, banche e finanza, in un contesto in cui la stessa crisi – peggiorando le condizioni sociali – dovrebbe fare aumentare la quota di risorse destinate al welfare; e che quindi i tagli previsti saranno difficili da attuare, per non esporsi a vere e proprie ribellioni sociali, e costi per la spesa sociale sempre più alti.
I Paesi PIGS sono quelli a maggior rischio. La crisi dei Paesi del Sud dell’Europa non è dovuta solo alla grande esposizione di debito pubblico, ma soprattutto al grave divario commerciale che essi hanno nei confronti della Germania.
Le economie di questi Paesi hanno un alto debito pubblico, un deficit di bilancio e poca crescita economica.
La Germania quindi si presenta come l’unico Paese europeo che continua a crescere e che approfitta della debolezza del resto dei Paesi europei e soprattutto di quelli a più alto rischio.
Ci si chiede allora: con quali piani di politica economica la Germania vuole essere a capo dell’economia europea, a scapito degli altri Paesi? Si insiste sulla necessità di tagliare la spesa sociale, evocando il falso problema che l’Europa in generale è un sistema in deficit, mentre invece risulta chiaro l’opposto, cioè l’assenza di un debito estero europeo (anche se ciò è il risultato di partite compensatorie, in cui il creditore per eccellenza, cioè la Germania insieme a qualche Paese del Nord Europa, è il detentore dei titoli del debito dei PIIGS e di altri Paesi fortemente indebitati).
È altresì vero che le banche tedesche che detengono tali titoli del debito, insieme ai mutui subprime statunitensi ed ai titoli speculativi immobiliari, fanno sì che il potenziale credito sia in parte sostanziale probabilmente inesigibile.
Ecco perché la Germania continua a mantenere prezzi e salari moderati in termini relativi, per favorire il proprio modello di sviluppo basato sull’export, tentando di aggredire i partner con un rilancio delle esportazioni extraeuropee. Ma Cina e USA non stanno certo lì ad aspettare in un ruolo di passivi osservatori.
La prospettiva futura non può prevedere altro che una crescita forte dell’indebitamento dei Paesi a capitalismo maturo, per tentare così di mantenere i propri livelli di vita. La nuova struttura della divisione internazionale del lavoro porterà ad un gioco al domino finanziario del debito, in cui ad esempio i nuovi Paesi emergenti del cosiddetto BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) continueranno a comprare titoli occidentali aumentando la concorrenza tra euro e dollaro; se solo tali Paesi decideranno di diversificare il loro possesso di titoli pubblici si determinerà un riassetto definitivo del risparmio e delle riserve mondiali, inasprendo la competizione internazionale.
La sinistra eurocentrica racconta favolette: Alice nel paese delle meraviglie
In questo quadro di accentuata competizione interimperialistica sembrano prevalere varie strategie europee di uscita dalla crisi.
La prima è la ricetta tedesca, verso quella che considerano la periferia europea, che punta alla destrutturazione del mercato del lavoro a maggiore austerità e maggiore liberalizzazione, riducendo anche le forme di protezione sociale.
In questo senso le politiche di aggiustamento strutturale in chiave europea hanno come unico obiettivo quello di salvare banche, imprese private e mercato, attraverso un indebitamento pubblico sempre crescente, che vede poi come sua cura la privatizzazione dei servizi pubblici di base, per creare un nuovo spazio di accumulazione attraverso la nuova catena del valore, che si realizza proprio sulle privatizzazioni dei servizi sociali, profitti e rendite finanziarie e di posizione.
Un’altra ipotesi è quella della sinistra eurocentrica, anche di quella cosiddetta radicale e di alternativa, che, partendo da una ipotesi di analisi della crisi come sottoconsumistica, ripropone una nuova stagione per le illusioni dei keynesiani di sinistra di superamento della crisi attraverso il sostenimento della domanda e un impossibile rafforzamento delle spese di carattere sociale e di investimento in infrastrutture pubbliche, tecnologie, educazione, ecc.
È l’ipotesi di una sorta di “euro buono“ contro le finanze del capitalismo “cattivo”: per favorire in tutti i modi il capitalismo “buono”, meglio se i capitali appartengono alla nuova borghesia europea e filtrati dalle grandi banche europee.
L’errore di tali keynesiani di sinistra sta non solo nell’identificare questa crisi come da sottoconsumo, ma anche nella loro ipotesi dell’“euro buono”, che si scontra con la loro stessa impostazione di crescita nella compatibilità capitalista.
Prende strada, in questo senso, l’idea di alzare il denominatore del rapporto debito pubblicoPIL, per ridurre l’impatto di tale indice attraverso stravaganti idee per stimoli alla crescita: green economy e progetti ambientali, progetti infrastrutturali (le opere pubbliche, tanto grandi quanto inutili e dannose), un’idea anacronistica e impossibile dell’UE a dimensione sociale, incentrata su un lavoratore felice di farsi sfruttare: una nuova e drammatica versione della favola Alice nel paese delle meraviglie.
Ma i keynesiani di sinistra, e molti che continuano a dirsi marxisti, sono cantastorie che soffrono di un esagerato e antistorico eurocentrismo; si dimenticano che non c’è il capitalismo “buono” e che la crisi del capitale è sistemica.
In un contesto storico ed economico come quello attuale, la vera utopia è credere nella possibilità di risolvere il problema della povertà e dell’esclusione attraverso la riforma del sistema capitalista. Tutte le proposte di rigenerazione del capitalismo – ad esempio per mezzo di un nuovo contratto sociale – rappresentano solamente il progetto delle classi medio-alte contro gli interessi della classe dei lavoratori, intesa in senso largo e quindi comprendente ovviamente disoccupati, le mille forme di precarietà del lavoro e del sociale, i non garantiti a vario titolo, etc… Questi settori della borghesia si muovono per tagliare reddito, diritti e vita al nuovo blocco sociale proletario, e aspirano alla sopravvivenza di un capitalismo in grado di garantire maggiore estorsione di profitti e rendite. O, nel caso di altri settori meno alti della borghesia, ad un loro un miglioramento del livello di consumo, abbattendo le pur minime forme di protezione sociale universalista.
La competizione globale è sempre più viva e acuta! La crisi è sistemica! La soluzione è solo politica ed è in mano alla soggettività di classe, capace di organizzarsi per la fuoriuscita dal modo di produzione capitalista! Invece da subito è possibile contrapporsi ai meccanismi di potere dei centri-polo, delle aree del sistema di dominio del modo di produzione capitalista, come sta tenacemente realizzando l’alleanza alternativa dell’ALBA. E per le organizzazioni sindacali e i movimenti sociali che agiscono in Europa, si tratta di acutizzare le contraddizioni, contrapponendosi direttamente alle regole dei potentati dell’Europolo. La nostra proposta è un’alleanza tra Paesi che si dotino di un percorso autodeterminato di democrazia partecipativa, con spazi produttivi e commerciali anticapitalisti, con modalità di sviluppo autodeterminato a sostenibilità socio-ambientali, in grado di sottrarsi e sconfiggere le spietate logiche capitaliste, rompendo la subalternità e accettazione dei dettami neoliberisti e antisociali della Troika, BCE, FMI e Commissione dell’Unione Europea.
Dobbiamo guardare a quei Paesi che hanno delle caratteristiche in comune e complementari anche produttivamente, all’Europa mediterranea, all’Est europeo e all’Africa mediterranea, e comprendere che l’unica risposta alla crisi per le classi sfruttate è un’alternativa politica di sistema. Un’alternativa tutta politica che si opponga alla perdita della sovranità popolare autodeterminata e ai meccanismi di lento ma inesorabile strangolamento imposto dalle banche e dal potere economico, di una nuova e potente borghesia centrale europea a guida tedesca.
Una strada rivoluzionaria che sappia imporre con le lotte, con l’obiettivo del potere politico d’alternativa di sistema, la nazionalizzazione dei gangli vitali per le economie nazionali e allo stesso tempo disegni un’economia solidale, complementare con la possibilità, anche da subito, di scambi fuori mercato o di mercato altro non sottoposto alle leggi del profitto. Un processo che sappia far fronte anche alla urgente necessità della sostenibilità socio-ambientale.
Quando ci ispiriamo all’ALBA latino-americana, non diciamo che tale modello si possa esportare, ma ci riferiamo alle condizioni favorevoli per intraprendere il processo che auspichiamo di costruzione di un’area d’interscambio solidale, complementare, che abbia le gambe per percorrere strade verso la transizione socialista.
Ispirarsi all’ALBA per rilanciare il conflitto di classe dal basso e riaprire il dibattito sull’uscita dall’Europolo e la sua rottura, per il superamento del capitalismo
In primo luogo, è sempre più centrale la necessità di un radicale cambiamento socioculturale (quello che in termini gramsciani si chiama un cambio di egemonia che modifichi il senso comune), che inverta le relazioni causali tra l’economia e la politica, come già si sta sperimentando, ad esempio, nei Paesi dell’area dell’ALBA; in particolare in Bolivia dove i movimenti sociali, di indios, i contadini, i minatori hanno determinato nuove forme di economia plurale e solidale attraverso lo strumento politico della democrazia partecipativa.
L’idea dell’ALBA era fortemente chavista e imperniata su un principio fondamentale: lo scambio solidale e complementare, fuori e contro le leggi del profitto, quindi dello sfruttamento. Un modello di relazioni economiche che si regge, non sulla legge del profitto del mercato internazionale dettata dalla teoria dei vantaggi comparati, ma sul conseguimento del maggior benessere possibile per i popoli. La complementarità e la solidarietà dei vantaggi cooperativi, mettendo a disposizione i punti di forza di ogni singolo Paese, fomentano uno sviluppo regionale condiviso ed integrato, combattendo contro ogni ingerenza imperialista [2].
Per sminuire questa nuova teoria e pratica della cooperazione complementare e dello sviluppo a compatibilità socio-ambientale, i nostri economisti di sinistra “di maniera” l’hanno etichettata come un ritorno al baratto. In realtà non siamo nel loro Paese delle meraviglie, trattandosi di un passaggio reale e fondamentale perché, in un processo di transizione al socialismo, – di questo stiamo parlando –, si realizza nei fatti un’inversione fondamentale, che vede un’area ratificare un accordo in cui si crea uno spazio di sviluppo condiviso che convive sì con il mercato, ma non con la legge del profitto capitalista, un socialismo, diciamo così, con mercato, ma non di mercato.
Un’area in cui a contare non è la legge del valore in termini di relazioni capitalistiche dello sfruttamento, ma il consolidamento di valori attraverso una nuova modalità di relazioni economiche tra gli Stati, orientata alla redistribuzione del reddito e della ricchezza; alla creazione di spazi fuori mercato e d’imprese di natura sociale, che pur convivendo anche con la proprietà privata, gettano le basi per una socializzazione dei mezzi di produzione. Il pensiero della CEPAL aveva un’impostazione keynesiana e con connotati fortemente sviluppisti e quantitativi. L’ALBA, al contrario, propone un modello di sviluppo qualitativo e di produzione altro, differente dal modello sovietico, ma non per questo non definibile socialista.
L’ALBA non va etichettata con specifiche formule, soprattutto perché in essa convivono vie, percorsi e processi in divenire, al socialismo, differenti tra loro. Per fare un esempio, infatti, ai fini dell’elaborazione di un “modello ALBA”, in quanto area economica anticapitalista e caratterizzata dalla pianificazione socialista, ancor prima di Samir Amin, potremmo parlare del COMECON. Dove, però, era esclusivamente il modello sovietico l’esempio per i Paesi che vi aderivano.
Al contrario, anche un poco attento conoscitore del processo di transizione socialista latinoamericano, nota la sostanziale differenza tra il socialismo di Cuba e, per esempio, la revoluciòn ciudadana in Ecuador, il socialismo bolivariano del Venezuela, o il socialismo comunitario in Bolivia. D’altro canto, quando Samir Amin o Hosea Jaffe proponevano il “Delinking”, lo facevano in un momento in cui, eccetto l’URSS, non esistevano realtà politiche anticapitaliste. C’era quindi la necessità di uno sganciamento per fermare la supposta – secondo le loro analisi – estorsione del surplus della classe lavoratrice del nord ai danni di quella del sud, e c’era la necessità di farlo attraverso una disconnessione dall’azienda mondo capitalista.
L’ALBA, invece, è un progetto fortemente politico, ancor prima che economico: è un’alleanza per la transizione al socialismo che non si pone solo l’obiettivo di un mercato alternativo più giusto e equo, ma è finalizzata alla costruzione di un fronte politico antimperialista e anticapitalista.
Il Venezuela presenta ancora un forte legame con l’economia nordamericana, ed è giusto sottolinearlo perché risulta cruciale tenere a mente che stiamo parlando di un processo di trasformazione in itinere. In una fase di transizione socialista, la nuova società convive con leggi monetarie e mercantili, con la vigenza della stessa legge del valore, quindi con i paradigmi del mercato che deve man mano dismettere in funzione dei rapporti di forza che si vanno a determinare come conseguenza della ancora vigente lotta di classe. Per capirlo basta leggere “La critica al programma di Gotha” di Marx, in cui meglio di ogni altra opera il filosofo tedesco spiega questi concetti, percorsi, passaggi e tappe intermedie dei processi reali di trasformazione.
Ad esempio l’esperienza socio-economica nell’ALBA, relativa alla teoria dei vantaggi cooperativi o complementari, rappresenta un percorso di transizione dal capitalismo al socialismo possibile attraverso la rottura non solo con esperienze antecedenti latinoamericane, ma anche con una concezione capitalistica dello sviluppo.
La “non reciprocità” ne è un chiaro esempio: a determinare lo scambio tra i Paesi non è ciò che può portare il libero commercio ad un singolo Paese, bensì la messa a disposizione in un’area economica solidale, e animata da principi comuni, dei punti di forza delle economie nazionali, al di là di ciò che si ottiene in cambio e in funzione di una redistribuzione della ricchezza sociale.
Questo significa che, quali che siano le forme di un sistema post-capitalista, per rappresentare un avanzamento sociale e umano esso dovrà colmare la separazione capitalista tra l’economia e la politica, la quale permette soltanto a pochi privilegiati di passare da una regione all’altra come cittadini. Per questo, la democrazia partecipativa, politica ed economica è una dimensione chiave di qualsiasi progetto del futuro post-capitalista.
Alice, non più favole ma padrona del proprio destino: in marcia nel paese reale
È possibile intravedere un ordine sociale non capitalista che permetta il miglioramento delle condizioni di vita della gente e aumenti il benessere qualitativo autodeterminato? E quindi, è necessario e praticabile realmente superare il capitalismo? Si possono qui ed ora sviluppare temi di riflessione e di ricerca, e un programma minimo di fase per riforme di struttura che almeno realizzino ipotesi di controtendenza rispetto alla scelta della società del capitale e del profitto.
Va rilevato allora che, già da subito, a maggior ragione per dare un senso socio-economico alla costruzione di economie fuori mercato a compatibilità socio-ambientale, è necessario effettuare delle scelte strategiche di politica economica generale che operino congiuntamente sulle emergenze sociali come quelle dell’occupazione e della salvaguardia ambientale.
I principi ispiratori di un diverso paradigma politico-economico dovranno mettere al centro del dibattito non la crescita economico-produttiva, ma la crescita della valenza sociale del vivere collettivo. Questi principi fanno riferimento non alle priorità aziendali ma alle priorità sociali, al miglioramento continuo della qualità della vita, alla formazione dei saperi non incentrata sulle logiche di competitività di un nuovo darwinismo economico, ma alla valutazione preventiva degli impatti socio-ambientali, dei prodotti e dei servizi orientati a una nuova qualità dei bisogni e a processi di interscambio ugualitario, solidale e complementare.
Anche questo fa parte del dibattito che dovrà inaugurarsi tra tutti i lavoratori e gli attivisti dei movimenti sociali, gli intellettuali militanti e organici alla classe dei lavoratori, per orientarsi nel cambio tecnico in funzione del progresso tecnico. Tutto ciò necessita un progetto fiscale pianificato a livello centrale, che sappia redistribuire indirizzando le risorse a investimenti in tecnologie a forte compatibilità ambientale e sociale per una dimensione socio-ecologica dello sviluppo a sostenibilità qualitativa.
La partecipazione o meno a queste lotte e al dibattito che si è aperto, sarà la linea di demarcazione della riorganizzazione dello spazio politico tra le forze della sinistra radicale e di quella di classe, con progetti inseriti ancora nella logica capitalista e le nuove strutture sociopolitiche e organizzative alternativamente proiettate rispetto al sistema vigente e quindi in chiave anticapitalista.
Allora Alice dovrà forzare l’orizzonte dell’utopia, ma come vedremo alla fine di questo articolo, camminando lentamente, molto lentamente, e con i piedi ben poggiati per terra.
Il punto fondamentale è sempre e comunque la strategia, l’orizzonte ultimo a cui si ispira e si orienta l’agire politico ed economico.
Alla fine, ciò che affermiamo da tempo in vari nostri libri è che siamo di fronte ad una questione politica, di correlazione delle forze.
E allora bisogna ripartire dall’ampliamento degli spazi partecipativi di decisione democratica, non solo in ambito politico, passando per un miglioramento sociale conseguito attraverso una redistribuzione della ricchezza. Fino ad arrivare a una necessaria pianificazione socio-economica, che permetta un uso razionale delle risorse naturali, ma anche un orientamento delle innovazioni tecnologiche al benessere dei popoli e non al profitto delle élites.
Questo significa formazione e battaglia culturale. Ma c’è un altro concetto che richiama fortemente Gramsci: la questione del blocco storico, cosa diversa dal blocco sociale. Il blocco sociale è un fronte di interessi tra soggetti di classe con bisogni e interessi socio-politici simili; invece, il blocco storico è la possibilità delle alleanze di contesto per il rafforzamento della transizione nel processo rivoluzionario.
Un’alleanza internazionalista tra i movimenti sociali, operai e del mondo del lavoro e del lavoro negato, che sia in grado di rompere con l’Unione Europea pone allo stesso modo la questione del blocco storico. Quali sono le alleanze da stringere? Guardiamo all’Italia: i precari, gli immigrati, la classe operaia, intesa in senso largo come classe dei lavoratori, sono sicuramente le componenti sociali che più stanno soffrendo la crisi economica. Ma allo stesso tempo c’è una parte consistente di piccola borghesia, di piccoli imprenditori, di partite IVA, lavoro autonomo di seconda e terza generazione, che esce tritata dalla costruzione del polo imperialista europeo, progetto della potente borghesia centrale del Vecchio Continente. Alla luce di questo, possiamo affermare che la sfida è sì economica, ma la questione dell’egemonia culturale, con tutto ciò che abbraccia e comporta, è oggi di primaria importanza politica.
Per intendere ciò, bisogna tenere bene a mente che il socialismo nel ventunesimo secolo in America Latina è la contaminazione tra la filosofia andina dei popoli originari del Buen Vivir e il marxismo, di cui una delle migliori e più attente espressioni sono gli scritti di Álvaro García Linera, vice presidente boliviano. In questo incontro dialettico, i parametri, anche quantitativi, incontrano e si modellano non al benessere, al vivere meglio nelle diseguaglianze, ma al Vivir Bien e alla sua concezione multidimensionale e qualitativa dello sviluppo. Il risultato è un socialismo comunitario, per alcuni versi ancestrale – che parte dalle grandi tradizioni maya e azteche.
Un socialismo fondato sulla cooperazione tra i popoli e sulla solidarietà, non in termini caritatevoli, ma di relazioni orizzontali tra gli Stati finalizzate a uno sviluppo equilibrato.
In questo contesto, un programma per superare la crisi della Eurozona a beneficio dei lavoratori può arrivare solo grazie ad una importante accumulazione delle forze che doti di maggior potere il movimento di classe dei lavoratori europei.
L’euro è stata una decisione di difesa destinata a facilitare la continuità del mercato unico europeo, nel contesto di una globalizzazione finanziaria imposta dal potere istituzionale degli Stati Uniti. Le politiche di aggiustamento sono la ricetta del capitale finanziario per caricare tutto il costo della crisi sui debitori, a beneficio dei creditori. Le privatizzazioni e i tagli nel settore pubblico sono la risposta alle domande del grande capitale produttivo che reclama nuove fonti di ottenimento di plusvalore e profitto. I lavoratori, il cui potere è diminuito dal periodo delle grandi lotte degli anni ’70, sono quelli che pagano i costi della crisi, nella loro doppia condizione di produttori di valore e consumatori di servizi pubblici.
Bisogna avere a disposizione una proposta alternativa all’Unione Monetaria e, per questa ragione, il dibattito sull’euro sta discutendo la costruzione di una alternativa al caos economico e sociale generato dalle politiche di gestione della crisi dell’UE.
Dal “Risveglio dei maiali”, un manifesto-proposta
I Paesi della periferia europea necessitano di un sistema monetario e finanziario alternativo all’euro e alla globalizzazione. Però non si può concepire un sistema di questo tipo nell’ambito del mercato unico neoliberista, identico a come è stato costruito nei Trattati europei. Le regole di funzionamento di questo mercato impediscono una soluzione che apporti stabilità al processo di accumulazione, almeno nel senso in cui s’intende il termine “stabilità” nel sistema capitalista, cioè un periodo relativamente lungo di crescita nel quale si susseguono cicli successivi di espansione e di contrazione economica. Per tutto questo l’alternativa monetaria e finanziaria deve inserirsi in una proposta di integrazione economica e sociale del tutto differente da quella perseguita dall’Unione Economica e Monetaria e dal mercato unico.
Il nostro è un manifesto proposta riportato sul libro Il risveglio dei maiali (di L. Vasapollo, con R. Martufi e J. Arriola, Jaca Book, 2012 e nuova ediz. 2012) che da quasi tre anni sta animando in vari Paesi europei il dibattito e l’iniziativa politica di molti movimenti sociali, sindacati conflittuali – come la USB in Italia –, organizzazioni politiche comuniste e anticapitaliste – come la Rete dei Comunisti – alcuni centri sociali. Dibattito sulla rottura dell’UE, contro la costruzione e il rafforzamento dell’Europolo Imperialista. La nostra analisi va oltre la sola uscita dall’euro, proponendo una serie di misure di politica economica a breve e medio termine (come la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e abbattendo ogni forma di precarietà, il reddito sociale garantito per i disoccupati, il diritto all’abitare con piani di edilizia popolare, investendo nel sociale ed eliminando lo sperpero in opere inutili come il TAV, recuperando risorse a partire dal non pagamento del debito e dalla tassazione dei capitali o da una seria lotta all’evasione fiscale). Politiche sociali che possano rendere il processo fattibile, con campagne di lotte per un nuovo accumulo delle forze dei movimenti del lavoro e del lavoro negato, attraverso un forte protagonismo di classe dal basso.
L’uscita dall’euro dovrebbe realizzarsi in forma concertata, in primo luogo tra i Paesi della periferia mediterranea.
Se i Paesi della periferia europea desiderano ritornare al controllo sull’attività produttiva, questo lo possono realizzare soltanto in maniera congiunta e mediante un processo di rottura con il modello della finanza privata e dello spazio monetario asimmetrico vigente.
È altresì importante che il cambiamento del sistema monetario e finanziario sia una risposta congiunta, poiché il peso della periferia europea mediterranea è molto superiore a quello dei singoli Paesi presi separatamente, e la sua capacità di resistenza e negoziazione è molto maggiore se realizzata congiuntamente, in particolare se ci si è rafforzati strutturalmente con la nazionalizzazione delle banche e dei settori strategici.
La nazionalizzazione di tali settori dovrebbe permettere di realizzare utilità verso usi sociali.
La convinzione di fondo, infatti, è che abbandonare l’euro è sì necessario, ma per farlo abbiamo la necessità – tutta politica – di un’alternativa radicale di sistema, percorribile e realizzabile con programmi tattici ma sempre con l’orizzonte strategico della transizione al socialismo.
Un’alternativa antisistema e di sistema sociale altro, perché affronta i percorsi del tentare le forme del fare socialismo, che può divenire concreta, in primo luogo, attraverso la concertazione tra i Paesi della periferia mediterranea e, in secondo luogo, mediante un processo politico ed economico imperniato su quattro elementi/momenti, senza i quali tale processo potrebbe risultare un disastro. Per primo, la determinazione di una nuova moneta comune, LIBERA dai vincoli comunitari imposti alla moneta euro. Poi, la rideterminazione del debito della nuova Area Libera per l’Interscambio Alternativo Solidale (ALIAS). Inoltre, il rifiuto e azzeramento almeno di una parte del debito, iniziando da quello contratto con banche e istituzioni finanziarie. Per ultimo, la necessaria nazionalizzazione delle banche, accompagnata da una stretta regolazione della fuoriuscita di capitali dall’Area e la nazionalizzazione delle imprese dei settori strategici dell’economia (trasporti, energia, telecomunicazioni), rafforzando il paniere dei beni collettivi a totale gratuità e proprietà pubblica, come scuola, sanità, università, pensioni, abitare per chi ha difficoltà economiche, formazione, saperi, etc.
La nazionalizzazione delle banche è la parte più importante del processo generale per uscire dalla finanziarizzazione dell’economia globale, e finché non si sarà realizzato questo obiettivo continuerà il deterioramento della qualità della vita e del lavoro al sol fine di aumentare il tasso di profitto. Rompere la logica del capitale finanziario significa nazionalizzare le decisioni d’investimento per favorire le attività socialmente utili, sottoposte a un criterio di rendimento sociale ed ecologico, che sono criteri di medio e lungo termine.
Il controllo sociale degli investimenti è imprescindibile per dinamizzare l’attività produttiva e per orientare il credito in funzione del massimo sviluppo dell’occupazione e dell’utilità sociale; tali funzioni sono fortemente differenti da quelle che applica la banca privata, che è orientata al criterio del massimo profitto a breve termine.
La nazionalizzazione delle banche in una situazione di insolvenza e di dipendenza dall’aiuto pubblico è anche un requisito per evitare la fuga dei capitali e per eliminare la drammatica e storica tradizione capitalistica di privatizzare i profitti e socializzare le perdite.
La nazionalizzazione dei settori strategici delle comunicazioni, energia e trasporti, non solo può essere un prezzo giusto, ma allo stesso tempo potrà portare le risorse per realizzare una strategia di rilancio produttivo a breve termine che permetta di creare le condizioni affinché milioni di disoccupati nei Paesi della periferia europea mediterranea comincino a produrre ricchezza sociale nel minor tempo possibile.
Questi settori strategici sono le attività produttive che stanno ottenendo maggiori benefici, come risultato della gestione delle risorse naturali non rinnovabili sulla base di una intensa socializzazione dei costi che non vengono imputati come costi interni (i costi di inquinamento, la distruzione di risorse naturali ecc.), o comunque tali settori stanno ottenendo forti risultati positivi perché stanno beneficiando della privatizzazione di reti di comunicazione e tecnologie la maggior parte delle quali si sviluppano con risorse pubbliche.
Uscire dall’euro proponendo una nuova moneta per Paesi con strutture produttive più o meno simili sarebbe l’unica alternativa realizzabile, che permetterebbe sia di mantenere un margine di negoziazione con le istituzione comunitarie e con la Banca Centrale Europea, sia di creare un nuovo blocco politico istituzionale capace di realizzare un modello di pianificazione a compatibilità socio-economica con forme di investimento sociale e di accumulazione favorevole ai lavoratori.
Costruire la strategia dell’alternativa di classe per il superamento del modo di produzione capitalista
Nelle tendenze attuali non rimane da scoprire nessuna forza, interna al sistema, che permetta di pensare alla possibilità di una ricomposizione delle condizioni del Patto Sociale del periodo post-guerra, che ha dato origine al cosiddetto Stato sociale keynesiano dei Paesi centrali. Ancora meno per un’eventuale estensione dello stesso verso la maggioranza espropriata e impoverita del pianeta.
L’alternativa possibile e necessaria richiede una maggiore qualificazione e sofisticazione nelle richieste e nelle analisi dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei cittadini e delle loro organizzazioni. Richieste di miglioramento sociale, ma anche di ampliamento degli spazi di decisione democratica partecipativa, per inaugurare la fase della trasformazione tecnologica, le decisioni di produrre e distribuire sotto il controllo di tutti i lavoratori; decisioni subordinate ad un processo politico e sociale di discussione sul ruolo che devono occupare le macchine e la scienza nelle nostre vite. Se le nuove richieste si dirigono verso lo spazio di produzione e distribuzione della ricchezza sociale, prima o poi si concretizzeranno in una strategia di rottura con lo stesso capitalismo.
Tutto ciò non è e non è stato in passato un mero esercizio teorico, ma ha avuto ed ha delle esperienze concrete che rendono tale ipotesi realisticamente praticata e praticabile. Si pensi ad esempi storici, dal Kemala ieri, all’ALBA oggi. In tali esperienze, con tutte le possibili diversità, si sono affermati modelli di sviluppo autodeterminati, incentrati sulle risorse e le economie locali, l’autodeterminazione, valorizzando al contempo le proprie tradizioni culturali e produttive. Si è anche dimostrato che, sapendo valorizzare le proprie risorse, si può rinunciare a tante merci inutili importate e funzionali ad un sistema di consumismo insostenibile.Pertanto risulta imprescindibile per l’affermazione di una nuova area, di una nuova ALBA euro-afro-mediterranea, con nuova moneta e di una politica orientata in favore dei lavoratori, contare su uno spazio produttivo nel quale si possa stabilire una nuova divisione del lavoro basata sui principi di una pianificazione economica per uno sviluppo sociale collettivo solidale e un benessere qualitativo per l’insieme della popolazione della nuova area monetaria ALIAS.
Per questo, una alternativa globale ridefinisce il discorso politico nel terreno del sociale e subordina, a questo discorso politico sul sociale, il discorso economico a partire dalla centralità della pianificazione socio-economica. È il momento di lanciare un’iniziativa politico-economica dal basso, per la realizzazione di un modello produttivo altro basato sulla distribuzione del lavoro, del reddito e dell’accumulazione del capitale, su un’economia del valore d’uso che possa diffondere e distribuire la ricchezza sociale che la classe dei lavoratori realizza e produce.
Solo così si può concretamente realizzare la costruzione e il consolidamento del sistema postcapitalistico avviato alla transizione socialista, che noi abbiamo disegnato. È cruciale la partecipazione democratica dal basso – ripeto – non solo nella vita politica, ma anche economica e culturale.
Alice nel paese reale per autodeterminare le meraviglie
Da un punto di vista logico ed ideologico, esistono varie alternative possibili alla attuale competizione globale e poi fino alla più strategica determinazione del superamento del modo di produzione capitalista, ognuna con distinti gradi di probabilità in funzione di ragioni tecnico-economiche o politico-sociali. In ogni caso, qualsiasi proposta attuabile dovrà “fare i conti” in primo luogo con l’individuazione dei soggetti, del blocco sociale, con i quali avanzare fino alla costruzione di una alternativa non capitalista, e da subito con il rapporto fra classe del lavoro e la tecnologia.
E allora la risposta alla crisi non può avere altro carattere che quello del rafforzamento politico del conflitto di classe internazionale, nelle sue diverse forme di rappresentazione sociale e politica. Un’alternativa mondiale per la trasformazione radicale deve essere un progetto che contenga un significato di classe transnazionale, con una strategia che si muova sin da ora in un orizzonte capace di determinare processi politici che, anche nei momenti rivendicativi tattici, abbiano sempre chiara la strategia politica per il superamento del modo di produzione capitalista e di costruzione del socialismo.
Subordinare l’economia alla politica sarebbe una alternativa alla mondializzazione capitalista realmente esistente.
Costruire in maniera indipendente le proprie prospettive, muovendosi da subito nella piena autonomia da qualsiasi modello consociativo, concertativo e di cogestione della crisi per riaffermare attraverso la pianificazione socio-economica la volontà di autodeterminazione dei popoli nella democrazia politica partecipativa.
Solo così l’autonomia di classe assume il vero connotato di indipendenza dai diversi modelli di sviluppo voluti e imposti dalle varie forme di capitalismo, ma soprattutto dallo sfruttamento capitalistico. Il movimento dei lavoratori non può e non deve essere elemento cogestore della crisi, ma trovare anche nella crisi gli elementi del rafforzamento della sua soggettività tutta politica.
Come sempre le sorti della classe lavoratrice non sono in mano alle varie ricette economiche, comprese quelle edulcorate dalle varie facce di un nuovo keynesismo eurocentrico di sinistra.
Il mondo del lavoro, Alice, non crede più alla favola della UE, come paese delle meraviglie, dell’imbroglio del capitalismo sociale dal “volto umano”.
La soluzione rimane tutta e solo politica e come sempre la parola va alle soggettività politiche organizzate in campo. Alice, se è capace di proporsi come forza socialista di un cambiamento totale radicale, quindi come forza rivoluzionaria, che con pazienza e lentamente… molto lentamente, come la lumaca Ribelle di Sepulveda [3] , costruisce, nei tempi della storia, il concreto, reale e autodeterminato paese delle meraviglie.
NOTE
[1] ↑ Cfr. AA.VV., No/Made Italy Eurobang/due: la multinazionale Italia e i lavoratori nella competizione globale, Mediaprint-Ediz. Roma, 2001; Martufi R., Vasapollo L., EuroBang. La sfida del polo europeo nella competizione globale: inchiesta su lavoro e capitale, Mediaprint-Ediz., Roma, 2000
[2] ↑ Su questi temi si veda l’intervista che mi è stata fatta a gennaio 2014 da Davide Angelilli
[3] ↑ Cfr. L. Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Ed. Guanda, Novembre 2013
CREDITS
Immagine in evidenza: “Alice in Wonderland” illustration №25 by Tenniell
Autore: John Tenniel; 1865
Licenza: public domain
Immagine originale ridimensionata e ritagliata