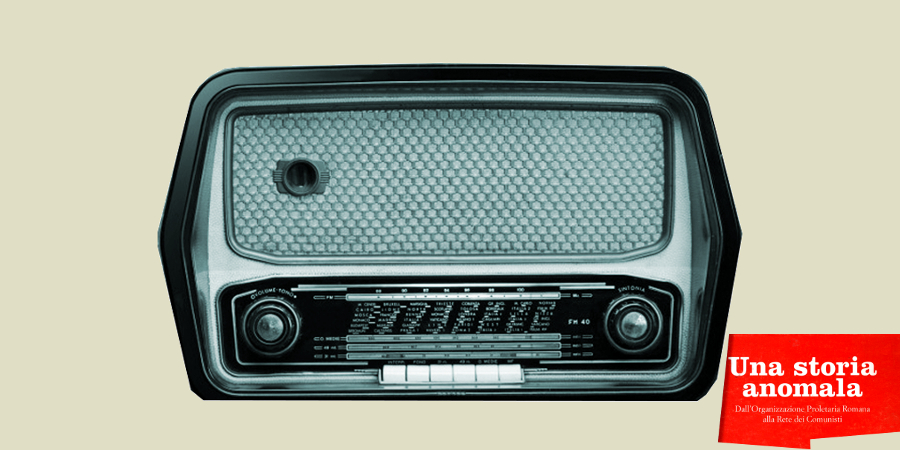da “Una Storia anomala” primo volume
pubblicato anche in Contropiano anno 28 n° 1 – marzo 2019
Per ricostruire una esperienza politica interna al movimento di classe nel nostro paese come è stata l’Organizzazione Proletaria Romana (Opr), non si può che partire dal contesto complessivo che ha caratterizzato quegli anni e, più nello specifico, dalla prima metà di quel decennio che già conteneva sia le conseguenze del conflitto internazionale e di classe del decennio precedente, sia le contraddizioni e le tendenze che si sarebbero manifestate in seguito. Un’adeguata chiave di lettura, non può che riguardare la situazione internazionale, il conflitto di classe nel nostro paese e le soggettività in campo, sia nelle classi dominanti che nelle forze schierate sul fronte antagonista.
Sul piano internazionale è inevitabile partire dalla profonda crisi che aveva colpito tutta l’economia del mondo a capitalismo avanzato e che stava rimettendo in discussione il primato degli USA anche nel consesso dei paesi capitalisti. Il momento più significativo e rilevante è stata la dichiarazione di Nixon del 15 agosto 1971 sulla fine della convertibilità del dollaro in oro, mettendo così fine agli accordi monetari siglati nel 1944 a Bretton Woods e che avevano regolato le relazioni economiche nel mondo capitalista fino a quel momento. Questa scelta era una conseguenza ma a sua volta diventerà la causa delle contraddizioni irrisolte del sistema capitalista che perdurano fino ai nostri giorni.
La necessità di rompere in modo unilaterale nel 1971 gli accordi del ’44 siglati a Bretton Woods veniva dalla crisi statunitense prodotta dal conflitto in Vietnam. All’inizio la guerra indocinese sembrava poter fungere da volano per l’economia americana ed anche per la crescita delle altre economie capitaliste. Alla fine degli anni ’60 il conflitto in Vietnam era però divenuto economicamente insostenibile, rischiando di far retrocedere il ruolo economico centrale degli USA e di aprire un conflitto tra gli stessi paesi capitalisti. Lo stretto collegamento tra il dollaro e l’oro portava, infatti, all’indebolimento della divisa statunitense ed al deficit di bilancio, inoltre, essendo gran parte della produzione americana finalizzata al “keynesismo militare”, le importazioni dei prodotti “civili” dagli altri paesi capitalisti minavano la sua supremazia industriale.
Di fronte a questi sviluppi e su indicazione della Commissione Presidenziale sul Commercio, Nixon annunciò lo sganciamento del dollaro dall’oro facendo saltare il metro di misura “oggettivo” del valore della moneta statunitense, mettendosi così in condizione di stampare dollari senza alcun limite. Questa scelta fu fatta in conflitto con gli altri paesi del blocco occidentale i quali non erano nemmeno stati informati delle misure che stavano per essere prese dai “partner” statunitensi, Da quella data emergono elementi che, oggi più di ieri, hanno caratterizzato la condizione dell’economia capitalista. Da una parte la tendenza alla finanziarizzazione, visto che con lo sganciamento dall’oro saltarono tutti i riferimenti oggettivi e generali per le monete. Dall’altra riapparve la conflittualità interimperialistica, in particolare con le economie più forti quali la Germania ed il Giappone, una competizione che era stata rimossa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma se il Vietnam era la causa immediata della crisi, esistevano però motivi strutturali che avevano portato in quel “cul de sac” e questi erano legati alla crisi da sovrapproduzione di merci. Dopo un ventennio di crescita impetuosa di tutti i paesi capitalisti nel ciclo del dopoguerra a guida Usa, proprio questa bloccava nuovamente i processi di valorizzazione del capitale, trovando limiti nella crescita del mercato e spingendo per il loro superamento con la finanziarizzazione e la competizione tra paesi capitalisti, oltre che con una maggiore aggressività nei confronti della Forza Lavoro.
Riemergono così gli ostacoli che erano stati superati dalla Seconda Guerra Mondiale, dove una distruzione generalizzata di “merci” e forze produttive aveva permesso un’ampia ripresa economica ad egemonia statunitense in quanto potenza uscita industrialmente indenne dal conflitto.
A questa prima fase di contraccolpi sulle economie a capitalismo avanzato, si sono succeduti poi momenti di ulteriore difficoltà a partire dal 1973 con la crisi del petrolio, la svalutazione del dollaro e l’inflazione galoppante a due cifre, con la ricomparsa della disoccupazione di massa anche laddove c’era stata la piena occupazione. Quello che si manifestava in quel decennio era dunque una “strozzatura” classica dello sviluppo capitalista che non mostrava ulteriori spazi di crescita quantitativa, evidenziando la debolezza di un assetto produttivo e sociale che sembrava fosse arrivato a “fine corsa”.
Questo stato di cose dunque spingeva verso un conflitto politico e militare che avrebbe dovuto modificare i rapporti di forza internazionali sia verso i paesi socialisti che verso i ritrovati competitori capitalisti Questa percezione di crisi storica del sistema capitalista era accentuata anche dalla lotta di liberazione del Vietnam e dall’esistenza di un movimento rivoluzionario montante. Se le contraddizioni del capitalismo nascono dalle dinamiche intime di questa formazione sociale, la trasformazione di queste in presupposti per la rivoluzione sono determinate dalla capacità soggettiva delle forze di classe, in quanto non esiste alcun determinismo che porti automaticamente alla trasformazione dei rapporti sociali. In quel contesto storico l’avanguardia combattente veniva svolta dalla lotta di liberazione del Vietnam divenuta un simbolo internazionale, ma questa non era altro che un momento del conflitto che dalla Seconda Guerra Mondiale andava coprendo il mondo intero.
Le guerriglie nelle campagne e nelle metropoli sud americane sotto la spinta dell’esempio Cubano ed il sacrificio del Che Guevara in Bolivia, le lotte di liberazione africane sia di carattere direttamente socialista, come quelle in Angola e Mozambico, che quelle di stampo nazionalista, anticolonialista e progressista nei paesi arabi, rappresentavano la prima linea di combattimento del proletariato internazionale. Uno scontro che stava mettendo in profonda crisi strategica l’imperialismo americano che fino ad allora aveva tenuto testa all’URSS, alla Cina ed ai movimenti rivoluzionari e democratici manifestatisi dopo la fine della guerra. Innumerevoli erano stati i tentativi rivoluzionari, dal Guatemala all’Indonesia, ma sempre gli USA erano riusciti con interventi militari, come in Corea, o con sanguinosi colpi di Stato, a contenere le spinte al cambiamento che si manifestavano in modo dirompente in quei decenni. La lotta di liberazione del Vietnam aveva invece ribaltato quella situazione e si andava affermando l’idea di una crisi profonda del capitalismo occidentale.
Eppure proprio in quella prima parte degli anni ’70 si palesavano in modo più evidente le contraddizioni anche all’interno del campo socialista, di cui la rottura tra Cina e URSS, già determinatasi dagli anni ’50, era la più significativa, tanto da portare a scontri armati sui confini dei due paesi nel ‘69 sul fiume Ussuri. Anche l’intervento sovietico in Cecoslovacchia faceva emergere divaricazioni che comunque, fino a quel momento, sembravano non rimettere in discussione la prospettiva socialista dei diversi paesi coinvolti nei conflitti “fratricidi”.
Gli eventi internazionali nel campo socialista, diedero vita ad una diversificazione tra le diverse componenti e questo si rifletté anche in Italia dove nelle mobilitazioni degli anni ‘68 e ‘69 si affermarono organizzazioni rivoluzionarie operaiste, marxiste leniniste, movimentiste. Mentre il Pci, con la scelta del Compromesso Storico (che prese corpo ufficialmente nei primi anni ’70), dava forma ad una svolta revisionista e riformista già presente nel partito, una svolta mostratasi contagiosa nei decenni successivi e di cui ancora oggi si vedono gli esiti ultimi.
La convinzione diffusa era che fosse possibile cambiare tutto, fare la rivoluzione, oltre che nei paesi del Terzo Mondo, addirittura anche nel cuore degli USA (con il movimento giovanile contro la guerra e dei neri in rivolta) e nei paesi europei a capitalismo avanzato. Sembrava cioè possibile quella “rivoluzione in occidente” che era mancata dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917. In Italia questa spinta si manifestò con l’esplosione studentesca del ’68 e con quella operaia del ’69. La forza dell’esplicitarsi di quelle potenzialità di classe e sociali, portò ad un cambiamento non solo materiale ma anche politico e culturale che si protrasse per tutto il decennio successivo.
Ma già dal 1973, nonostante la fase acutissima della crisi capitalistica, cominciarono ad emergere i primi segni di quello che, dopo qualche anno, fu giustamente chiamato il “riflusso”, un processo inteso come indebolimento della prospettiva di rottura radicale e che portò alla crisi nel giro di tre anni dei due maggiori gruppi della sinistra rivoluzionaria in Italia: Potere Operaio (1973) e Lotta Continua (1976). Questi due gruppi extraparlamentari disponevano di decine di migliaia di militanti ed attivisti che, assieme ad altre numerose formazioni nazionali o locali, tenevano vivo il conflitto di classe su tutto il territorio nazionale.
La crisi della sinistra rivoluzionaria in quegli anni, potenzialmente “rivoluzionari”, fu causata dall’incapacità di trovare una sintesi politica, un vero radicamento nella classe e di rappresentare un progetto valido per le forze che si muovevano coerentemente contro il riformismo.
Non è questo il testo per entrare nel merito del perché questo è accaduto, ma è certo che abbia pesato anche una cultura politica che, rifiutando correttamente la strategia del PCI, buttava a mare anche una pratica ed una concezione della militanza, fondamentali per sostenere una qualsiasi prospettiva rivoluzionaria. In altre parole si affermava spesso un protagonismo politico di gruppo e di piccoli leader in cui si poteva intravedere già quel politicismo divenuto dirompente nei decenni successivi. Politicismo inteso come manifestazione di una base sociale la cui natura era sostanzialmente piccolo borghese, che si era gettata alla fine degli anni ’60 nell’agone politico producendo effetti importanti ma che non si poneva il problema della tenuta e delle prospettive.
Riportiamo qui di seguito un estratto dal libro “L’orda d’oro, 1968 – 1977”, di Nanni Balestrini e Primo Moroni, utilissimo per un interpretazione corretta di quegli anni. A pag. 359 in relazione ai primi anni dei ’70 afferma: “I gruppi (extraparlamentari nota nostra) non hanno una strategia di fabbrica, i loro militanti sono esposti all’epurazione, vengono spesso licenziati (frequentemente per assenteismo) o si auto licenziano o si imboscano nel sindacato. In alcune grosse concentrazioni operaie del Nord solo la frazione clandestina mantiene una sottile rete organizzativa. I “gruppi” ingannati dalla gabbia organizzativa e dallo specchio deformante della relativa egemonia sulle lotte sociali, non si rendono esattamente conto che il periodo 1969 – estate 1973 non è un periodo di stasi rivendicativa, anzi, ma è contrassegnata da una fitta attività contrattuale, probabilmente la più intensa del dopoguerra. Pressati continuamente dalle scadenze di lotta contro la strategia della tensione concentrano continuamente le forze su vaste battaglie democratiche (tipica quella sul referendum sul divorzio) e per i diritti civili, mentre pochi si accorgono della lenta marcia del sistema dei partiti dentro la fabbrica perché questa viene coperta da una spessa cortina vertenziale”.
Di questa condizione “deformante” dei gruppi extraparlamentari della sinistra, se ne avvantaggiò soprattutto il PCI di Berlinguer, il quale da una parte, con la linea del Compromesso Storico, preparava la ritirata generale del movimento operaio e comunista e dall’altra, sul piano della partecipazione democratica, recuperava quei settori sociali protagonisti del ’68. Questi settori, di fronte alle difficoltà di sostenere conseguentemente prospettive rivoluzionarie, ripiegavano via via sull’accettazione dello stato delle cose esistente, dando vita di fatto per la prima volta a quella logica del meno peggio di cui possiamo misurare gli effetti anche oggi.
Ad esempio il sostegno ai decreti delegati della scuola del ’74, che assunsero un significato politico ben più ampio del solo settore dell’istruzione, e poi negli anni successivi la vittoria del PCI alle elezioni regionali del 1975 e quelle politiche del 1976, segnarono sia la vittoria (apparente) del PCI berlingueriano, che la crisi (reale) dei gruppi extraparlamentari nei quali avevano militato decine di migliaia di giovani ed operai.
Una parte di questi non intendeva accettare la chiusura di una fase importante dello scontro di classe che si andava prefigurando. Nè con il disarmo concreto, ossia sciogliendo le organizzazioni sorte in quegli anni, né con quello politico cioè l’accettazione del terreno riformista al di là della retorica rivoluzionaria che rimaneva ormai come semplice rappresentazione.
La storia di quegli anni è stata scritta più volte e sempre con obiettivi ed interessi politici diversi. Sicuramente il testo di Primo Moroni e di Nanni Balestrini (L’Orda d’oro) rimane, dal nostro punto di vista, quello più corretto storicamente e più lucido sul piano politico ed a quello rinviamo per gli approfondimenti necessari. Quello che invece ci interessa mettere in evidenza qui sono le risposte emerse all’epoca di fronte al recupero del riformismo, variamente mascherato, ed i motivi che portarono alla scelta di dare vita all’Organizzazione Proletaria Romana.
Una prima ipotesi politica nata nel contesto della crisi dei gruppi extraparlamentari e della ripresa dell’egemonia del PCI fu quella della lotta armata, e in quella prima fase specificamente delle Brigate Rosse.
L’ipotesi di resistenza armata non nasceva dall’obiettivo di “portare l’attacco al cuore dello Stato” ma da una doppia esigenza: da una parte sostenere con azioni militari le lotte dentro le fabbriche, colpendo in particolare la funzione dei capi reparto e dei dirigenti. Per tutta la prima fase, questo ruolo delle BR di supporto delle lotte di fabbrica fu esplicitato nelle azioni che venivano fatte (la propaganda armata) e non miravano all’eliminazione fisica delle persone individuate come obiettivi da colpire o da “punire”.
L’altra esigenza era quella di prepararsi alla resistenza armata contro i possibili colpi di Stato, che effettivamente erano in gestazione anche in Italia, e dei quali si capiva come fossero un possibile – e niente affatto inventato – strumento di intervento per bloccare il conflitto di classe nel paese. Questa motivazione poggiava su dati di fatto. In quegli anni, l’Europa euromediterranea (Spagna, Grecia, Portogallo) era tutta in mano a giunte militari. In Spagna lo fu fino al 1979. In Italia ci furono il golpe “rientrato” dell’Immacolata (la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1970), le ripetute stragi di Stato (1969 a Piazza Fontana, 1974 a Brescia e sul treno Italicus), un clima che costrinse in quel periodo molti militanti della sinistra, sia rivoluzionaria che riformista, a passare diverse nottate fuori casa per sicurezza.
Un clima che il PCI usò anche come giustificazione, dopo il colpo di Stato in Cile di Pinochet del 1973, per legittimare la propria strategia del compromesso storico.
L’altra componente che prese posizione netta contro il riformismo fu quella dell’Autonomia Operaia, la quale ricostituì le fila del disciolto Potere Operaio, che fu indubbiamente il gruppo più qualificato sul piano della produzione teorica in relazione a quella fase politica e storica.
Poiché il contesto storico è fondamentale per dare giudizi corretti, bisogna mettere in evidenza che sia le Brigate Rosse che l’Autonomia Operaia agivano in una condizione che non sarà quella prodotta successivamente dal movimento del ’77 (che per ammissioni delle prime fu come “una slavina imprevista”), ma era ancora tutto interna alla classe operaia fordista delle grandi fabbriche, dunque produceva comportamenti e strutture ideologiche diverse da quelle più “movimentiste” che poi hanno in qualche modo facilitato l’isolamento sociale, la speculazione e infine la repressione da parte degli apparati dello Stato e del PCI, che già si sentiva prossimo al governo del paese.
Alla metà degli anni ’70 si era dunque in una fase di relativo arretramento e si poneva la necessità di trovare risposte in grado di affrontare quella deriva riformista – non ancora esplicita – ma che si cominciava a vedere piuttosto nitidamente.
In quel tempestoso contesto storico e politico, nel Settembre del 1975 nasce l’OPR (Organizzazione Proletaria Romana), costituita da gruppi di intervento operaio e proletario ma con riferimenti comunisti ben saldi, che nulla concedevano alla mutazione genetica e politica in atto nel PCI divenuta esplicita con la segreteria Berlinguer. L’Opr non prevedeva nessuna compromissione ideologica con il riformismo, facendone un asse fondativo della scelta che si stava operando, ma anche con elementi di critica, tutta politica, sia verso le Brigate Rosse che verso l’Autonomia Operaia.
Con le Brigate Rosse la divergenza era politica, nel senso che non si riteneva che ci fossero le condizioni per condurre la lotta armata in una società occidentale come l’Italia, dove invece andavano privilegiati i processi di organizzazione interna alla classe nelle fabbriche e nei quartieri proletari, quella che l’Opr definì come il processo di “proletarizzazione dei militanti”.
Con la seconda, l’Autonomia Operaia, la separazione fu invece più marcatamente ideologica, in quanto il movimentismo che si affacciava dietro certe posizioni, implicava una sorta di spontaneismo che per l’OPR non era condizione sufficiente a costruire un progetto rivoluzionario.
I militanti dell’Opr saranno presenti con il Comitato Operai Metalmeccanici nelle principali fabbriche del tessuto industriale della Capitale (Autovox, Voxon) o della zona industriale di Pomezia (Ime). Saranno attivi con i Comitati nei quartieri proletari del quadrante sudest (Tiburtino, Centocelle, Prenestino) e ovest (Tormarancia, Garbatella, Nuova Ostia).
In particolare, attraverso il Comitato Proletario per la casa, si praticherà in modo organizzato l’occupazione delle case sfitte con le famiglie proletarie, provenienti soprattutto dalle numerose baraccopoli sorte nella periferia romana, insieme agli operai delle fabbriche dove si era attivi.
Il manifesto di nascita dell’Organizzazione Proletaria Romana nel 1975, riproduce il simbolo dell’Internazionale Comunista – l’operaio che spezza le catene e contiene lo slogan: “Per lo sviluppo dell’autonomia di classe, per l’unità delle avanguardie politiche”. Il manifesto è firmato dal Comitato Operai Metalmeccanici, dal Comitato Proletario per la casa e dai Comitati Popolari, cioè le strutture che daranno vita all’Opr. Infine e più tardi ci sarà il Comitato Disoccupati Organizzati che aggregherà gruppi di giovani disoccupati e di operai edili ormai espulsi dal mercato del lavoro a causa della ristrutturazione nell’edilizia che aveva eliminato moltissime figure di operai professionali nei cantieri. La proletarizzazione dei militanti agiva di fatto come una pratica e un metodo di lavoro politico.
Nel 1975 è iniziato con l’Opr un lungo percorso che ha fatto i conti con le difficoltà politiche ma anche con discontinuità storiche drammatiche, le quali hanno posto ai comunisti e al movimento di classe problemi nuovi e spesso determinanti per la sopravvivenza – e non per la rivoluzione – delle organizzazioni. Ed è proprio nella tenuta dell’organizzazione come progetto politico generale che si possono riaprire prospettive politiche di rottura importanti come si sta producendo nella attuale crisi del capitale mondializzato.